La nuova serie della creatrice di Girls è piena di difetti ma ha un pregio che da solo quasi basta a redimerla: rende bene l'idea di che cosa terribile siano le relazioni oggi.
Quello che in tanti non sanno di Marcelo Burlon
Ha cambiato la notte e l’underground milanese, poi la moda. È diventato una popstar, adesso è pronto per un’altra avventura, quella della Fondazione Marcelo Burlon, lanciata nell’estate 2021. E ora si racconta in un libro che riassume questa vita ricchissima, appena uscito per Rizzoli New York.

Mancano undici giorni al suo compleanno, il quarantacinquesimo. Si dice siano date importanti, la famosa mezza età. A Ibiza è rimasto da solo per qualche giorno. È eccitato mentre sfoglia il grosso volume bianco e blu di Rizzoli New York. Sulla copertina il titolo è: Marcelo Burlon County of Milan: Confidential. È il libro che racchiude la vita di Marcelo Burlon, dai club di Riccione fino a questa casa grande e silenziosa nascosta nella terra rossa di Ibiza e dietro a un piccolo boschetto di ulivi centenari a pochi chilometri da Sant Llorenç, lontano da tutto. Passando per County of Milan, per le feste, per le sfilate e le collaborazioni, naturalmente. Guardando poi alla seconda parte della sua vita, quella dedicata alla Fondazione Marcelo Burlon, con cui vuole creare pubblicazioni, progetti artistici, promozione e sostegno di diritti civili e umani. Anche per quella è elettrizzato. Sul telefono, aggiorna la casella email: è questione di minuti, deve uscire la notizia del nuovo progetto fatto proprio dalla Fondazione insieme a C2C Festival: il lancio in streaming di un concerto, anzi un «progetto artistico unico», come dice il comunicato, realizzato a luglio proprio in questa casa e in questo giardino, con protagonista la cantante e performer Arca.
È dell’estate 2019 la notizia dell’acquisto, da parte di Farfetch, del gruppo New Guards Group, fondato nel 2016 da Marcelo, Claudio Antonioli e Davide de Giglio, casa madre di Off-White, Marcelo Burlon County of Milan, Heron Preston e altri brand. Più o meno da quel momento Marcelo ha lasciato Milano, la cui fortuna come città in cui “succedono cose” ha contribuito a plasmare, per passare sempre più tempo in questo buen retiro balearico. In cui transitano in tanti, amici, amiche, artisti, cantanti, designer. Sembra una factory lontana dalla città. Marcelo si guarda nelle foto in bianco e nero del libro, qui è con Virgil Abloh, qui con Kim Jones, qui con Raf Simons. Marcelo ha cambiato Milano, poi ha cambiato la moda, poi ha deciso di essere una popstar. Adesso un altro cambio. Lui direbbe “evoluzione”, perché niente è davvero staccato dal prima.
ⓢ Com’è successo che ti sei innamorato così tanto di questo posto?
Mi ha affascinato dal 2003, la prima volta che sono venuto. Avevo sempre avuto questa specie di pregiudizio, quest’idea che Ibiza fosse un posto da scoppiati, perché negli anni Novanta le mie frequentazioni andavano a Ibiza veniva per farsi. Io ero già uscito da un po’ da quella storia lì. Arrivai qui e capii che invece c’era di tutto per tutti: era una questione di scelta personale su come viverla e interpretarla. Da lì ogni anno ho iniziato a venire con i miei amici, ogni volta mettendo insieme i soldi per la casa da affittare o lo scooter. E ho capito che l’isola era un posto speciale, perché potevi viverla nel modo in cui volevi tu.
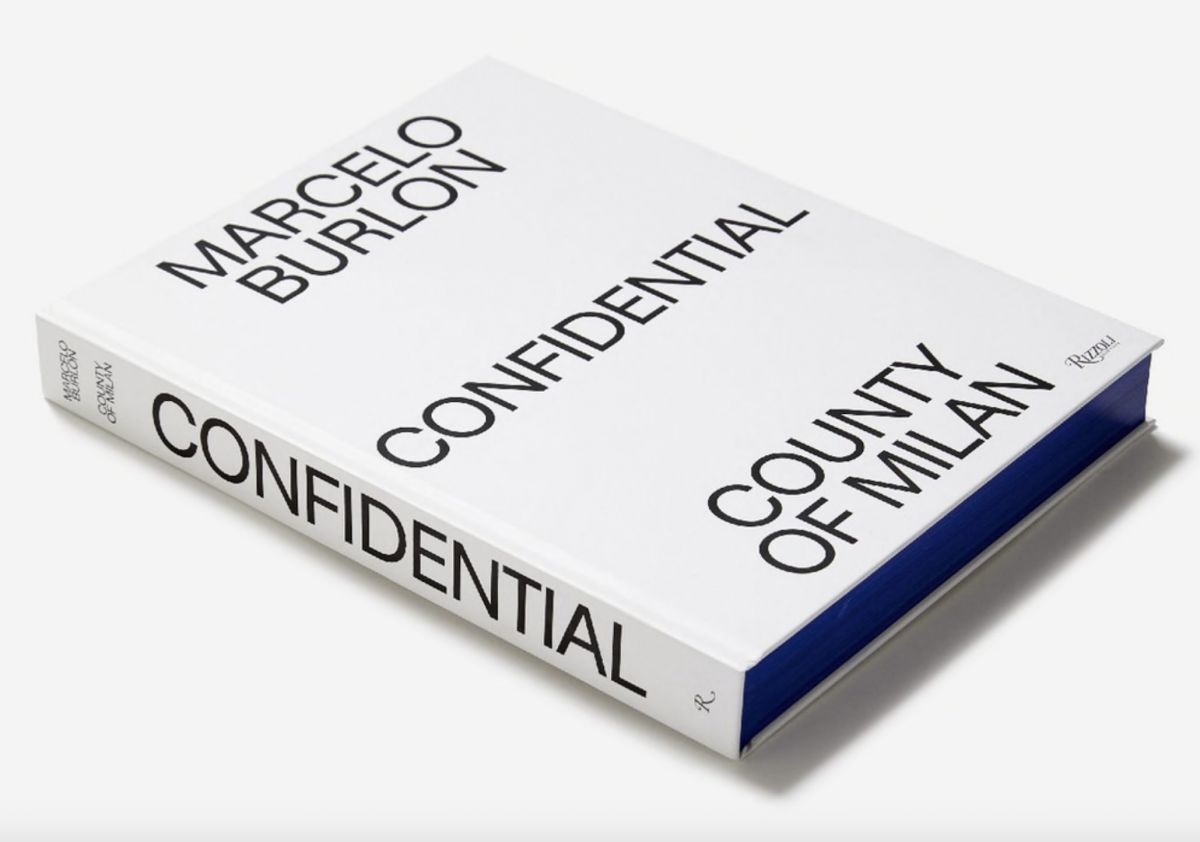
ⓢ C’è una bella storia dietro alla scelta di questa casa.
È vero. Avevo già visto molte case, questa era la ventesima che guardavo. E rispecchiava già la mia estetica, mi ricordava qualcosa dell’Argentina. Sono andato a vederla insieme un amico, che durante la visita ci si è addormentato. E ho capito che era un posto importante, proprio a livello energetico. Poi ci ho messo del mio e adesso è un paradiso.
ⓢ A un certo punto avevi bisogno di scappare da Milano, da quel tipo di città e di vita?
Piuttosto che scappare era un bisogno di raccogliersi, di vivere in una dimensione intima fatta sia di solitudine che di una cerchia molto ristretta di persone. E quindi Ibiza mi ha dato questa dimensione. Anche in questo lockdown per me c’è stato il bisogno di ridimensionare tutto.
ⓢ Quando sei venuto a vivere qui in che momento ti trovavi?
Era il 2019, un momento in cui non avevo ancora venduto a Farfetch, ma mi ero già sistemato, diciamo: avevo una casa a Ibiza, una casa a Milano, una casa in Patagonia. Succeda quel che succeda, io una casa ce l’ho. Già ero in una fase successi va, in cui non stavo rincorrendo nulla, non dovevo dimostrare niente a nessuno. Avevo fatto il mio percorso, la mia esperienza anche con County of Milan. Avevo solo bisogno di uno spazio che mi permettesse di vivere, di sentirmi anche protetto.
«La sottocultura purtroppo non c’è quasi più, è tutto alla luce. I punti di riferimenti nostri erano completamente diversi. C’era ricerca, c’era avanguardia, c’era un underground vero e proprio»
ⓢ La Fondazione Marcelo Burlon è solo una delle trasformazioni che hai attraversato…
Evoluzione.
ⓢ È solo una delle evoluzioni che hai fatto o è la più importante?
No, per me è stato tutto importante. Se non avessi fatto ogni cosa che ho fatto non sarei qui e non avrei fatto nemmeno la Fondazione. Credo sia l’evoluzione, la maturità della mia persona. Arrivare a 45 anni e poter in qualche modo strutturare una cosa per poter aiutare le persone.
ⓢ Ti muove una volontà di restituire?
Soprattutto. La mia fortuna me la sono costruita da solo, perché siamo noi gli artefici della nostra vita, siamo noi che determiniamo con ogni azione in quale direzione la nostra vita andrà. La Fondazione non è altro che il riflesso di quello che io sto vivendo e dei bisogni che io ho. Di aiutare in modo più profondo e concreto.
ⓢ È stato tipo un bisogno di creare qualcosa per gli altri?
Io ho sempre e comunque, anche prima, aiutato tantissimo. Anche
quando avevo poco dividevo
quel poco con le persone che
vedevo che avevano bisogno,
al di là degli amici, in Italia, in
Argentina. Poi naturalmente quando la fortuna è arrivata il mio aiuto è diventato anche più grande. Avere una struttura che possa coordinare i progetti, seguire dove vanno a finire i soldi, evitare che tutto o parte di tutto vada perso è fondamentale in questo momento.

Scatti di Alessandro Furchino Capria, per Rivista Studio
ⓢ Adesso l’attenzione è tutta sulla Fondazione?
Sì. Poi con la Fondazione si aprono altre mille storie, altre mille porte. Sto già lavorando alla pubblicazione di un libro sul razzismo nel mondo della moda, un esempio di come sto lavorando in maniera trasversale. Non basta mettere in copertina un gruppo di top model africane, non basta mettere su Instagram una bandiera arcobaleno, non basta più. Bisogna scendere in campo e creare dei progetti che veramente facciano la differenza, e non per tendenza, non perché è il momento in cui hashtaggare è trendy e a non farlo si fa brutta figura.
ⓢ Quando ti sei esposto ti sei sentito da solo?
Io non ho mai guardato tanto gli altri, ho sempre cercato di fare le cose a modo mio. Non ci sono tanti stilisti che si schierano, ma pensano più a vendere borsette con l’arcobaleno a giugno, iniziative il cui ricavato dovrebbe andare al cento per cento alla causa. Come il progetto che con County abbiamo fatto con il Gay Center di Roma: abbiamo contribuito all’apertura di un rifugio, una casa di accoglienza per adolescenti omosessuali o transgender che sono stati cacciati dalle loro case. O anche Casa Marcella, un’altra casa di accoglienza per ragazze transessuali, in Toscana.
ⓢ Hai detto basta alla mondanità?
Sì, da un po’. Poi il lockdown ha aiutato tanto. Per me è stato un toccasana. È arrivato in un momento in
cui avevo bisogno di quello, di staccarmi dal
mondo. Anche di rivalutare e valorizzare le
cose che stavo facendo, dove stavo andando.
ⓢ È anche perché ti senti più lontano dalla cultura pop o della strada di oggi, rispetto a quella che conosci e che hai contribuito a costruire?
La sottocultura purtroppo non c’è quasi più. Se c’è la trovi in persone più adulte, che hanno vissuto quei momenti lì, e si portano dietro le loro esperienze vissute.
ⓢ Non c’è più niente di sotto, è tutto alla luce.
Tutto alla luce e non c’è più quella cosa da
ricercare. Manca quella cosa. Che è un bene
perché comunque è un’altra potenza. Però sicuramente io sono un po’ nostalgico di quel
mondo lì. I punti di riferimenti nostri erano
completamente diversi. C’era proprio ricerca,
c’era avanguardia, c’era un underground vero
e proprio. Non è che non mi vada bene come
sta andando il mondo adesso. Mi va bene, ma
non mi appartiene. E magari capisco benissimo che il mio modo di vedere, di pensare
e di comunicare, per altri possa essere vecchio. Quello non lo escludo, anzi. Però il mio lavoro è sempre stato quello di cavalcare l’onda.
ⓢ Anche anticiparla.
Soprattutto anticiparla, mi occupavo di quello. Diciamo che sono il pioniere degli influencer. Ho vissuto tra due ere, tra quella analogica e quella digitale.

ⓢ È anche normale che nella vita, forse proprio a questo punto, ci sia nostalgia.
Io sono un nostalgico di natura. Sono anche un malinconico. Che non ha niente a che vedere con la tristezza, ma con quella mancanza che ti porta indietro. Trovo che non ci sia più sottigliezza, quella cosa se vuoi poetica dietro alle cose. C’è un bombardamento di immagini, di video, di cose che alla fine sono vuote. Almeno, io le trovo vuote.
ⓢ Questa nostalgia c’entra con l’aver lasciato l’Argentina da piccolo?
C’è sempre qualcosa che rimane, che lasci là, che guardi da lontano. Sì, sicuramente in quegli anni dell’adolescenza in cui ero in Italia pensavo alla Patagonia, e attraverso la musica riuscivo a connettermi, e mi dava un senso di nostalgia.
ⓢ Negli anni tra la fine dei Novanta e l’inizio dei Duemila, quando hai iniziato a fare club, a fare le feste, hai creato un nuovo modello, una cosa che non esisteva. È qualcosa a cui ambisci anche adesso questo creare sinergie non definibili di mecenatismo, attivismo, pubblicazioni, che riesce a tenere insieme moda, musica, cultura?
Un altro oggetto poco definito e difficile da raccontare.
È sempre stato difficile spiegare anche il mio ruolo nel sistema moda. Ho sempre fatto un milione di cose e proprio perché non ero ben definito e non volevo definirmi, non ero ben visto. Non mi stavo settorializzando come la società o come il sistema avrebbe voluto, non mi etichettavo e quelli che erano i paradigmi della struttura moda non avevano nulla a che fare con quello che stavo facendo. Io ero un punk e facevo quello che avevo voglia di fare. Poi viene fuori quel video del New York Times che racconta la mia storia e lì in molti capiscono che il multitasking era approvato dal sistema. Io non ho mai avuto bisogno di nessuna approvazione. Il mio marchio ha avuto presto un successo mondiale e allora sono stato doppiamente sul cazzo. Poi ho lanciato New Guards Group insieme ai miei due ex soci, e sono stato ancora più sul cazzo. Io però mi sono sempre fatto i cazzi miei. Possiamo fare un titolo così? Marcelo Burlon: mi sono sempre fatto i cazzi miei.
Unire le persone. Alla fine hai sempre fatto questo, ed è alla base di quello che farai ancora.
Sì, fare da ponte.
ⓢ La Milano che si vede nel libro Confidential pulsa di un underground incredibile a guardarlo oggi, ma era una città diversa, che ha preceduto quella splendente di cui si parla in questi ultimi anni. In questo passaggio si è perso qualcosa?
Quello che non c’è più sono dei punti di riferimento. Non ci sono più i posti in cui ti ritrovi senza doverti mettere d’accordo con nessuno, ma sai che trovi tutti lì. Persone che condividono idee, gusti. Quella cosa lì mi sembra che non ci sia più.
«I ragazzini mi dicono sei un esempio, voglio diventare come te. Però la gente non sa quello che c’è stato nei vent’anni prima. Per arrivare a questo punto io ho dovuto passare vent’anni di esperienze»
ⓢ C’entra anche il fatto che non c’è più quella nightlife, fatta di posti e serate che hanno fatto la storia. Magazzini Generali, Rocket, Pink Is Punk, Plastic.
È vero. Come se ci fosse stata un’evoluzione… sbagliata? Però non è giusto dire sbagliata, perché è il mondo di oggi, è il modo in cui si vive oggi. Ogni momento ha la sua vita. I cerchi si chiudono, se ne aprono altri. Quindi va bene così. Che piaccia a me o meno, poi, è un altro discorso. Sicuramente non mi rappresenta più e non rappresenta molta gente della mia generazione.
ⓢ Però hai questa passione per i nuovi talenti.
Ce l’ho sempre avuta: dove ci sono gli adolescenti, dove c’è la gioventù, c’è il motore di come stanno andando le cose. Io, attraverso la mia esperienza, provo a raccontare come vedo le cose. E attraverso la Fondazione. Uno dei punti principali è quello di educare: non solo a livello scolastico, con delle borse di studio, ma anche a livello sociale. Per esempio, dare supporto psicologico gratuito a famiglie con figli transgender perché possano capire, la comprensione va oltre l’accettazione, e ne è anche il cardine.
ⓢ Hai dei modelli per la Fondazione?
No, niente di preciso.
ⓢ Hai mai avuto modelli in generale?
Mi sono sempre inventato tutto.

ⓢ Quando hai venduto la tua creatura a Farfetch che emozione hai provato?
Ma non ho mai mollato del tutto. All’inizio il marchio per me è stato uno sfogo per raccogliere tutte le mie esperienze sia come stylist che come dj che come pr. Quindi è stata l’occasione per dirigere non solo la parte creativa riguardante il design, ma anche la comunicazione, le campagne, le collaborazioni, le sfilate… Credo che il marchio sia diventato un po’ più maturo, adulto. Ovviamente le ali le abbiamo sempre fatte e continueremo a farle, è una grafica che rimarrà.
ⓢ Come si può definire questa casa oggi: una specie di factory?
Una specie di Disneyland. Una specie di parco dei divertimenti.
ⓢ C’è una progettualità dietro a come vivi questa casa, chi inviti…
C’è voglia di collezionare pezzi d’arte importanti, ogni collezionista ha un’estetica e un gusto proprio. Quindi per fare una collezione che rappresenti il mio gusto, la mia storia, c’è un che di progettuale, ma per il resto è solo improvvisazione.
ⓢ Cosa ti guida, in questo?
Mi guido da solo, seguo quello che mi emoziona, che mi muove qualcosa. Vasarely, Keith Haring, Andy Warhol… Artisti che appartengono alla mia storia, alla mia cultura. Io sono cresciuto negli anni Novanta con Gaultier che faceva le collezioni ispirate a Vasarely, poi negli anni Duemila sono cresciuto col rap, nel negozio King Kong [a Milano in via Vigevano, fondato da Federico Sarica e Ivano Atzori, nda], e quindi Keith Haring era un riferimento. Invece, per Andy Warhol: avevo un gruppo negli anni Novanta con due amici a Rimini, ci chiamavamo Sinners, e facevamo delle performance di una specie di teatro avanguardistico. Facevamo proiezioni sui nostri corpi di diapositive con le opere di Warhol. Il giorno in cui ho comprato il mio primo quadro di Warhol ho ricevuto da un amico una vecchia foto di me, scattata negli anni Novanta, con i fiori di Warhol proiettati sul mio corpo; avevo appena comprato quella stessa serigrafia.
ⓢ Come fai a far coesistere in questa Disneyland profili diversissimi, dico per esempio Sfera Ebbasta e Edward Buchanan, cultura e moda e pop?
Per me è naturale, ma bisogna anche vedere le storie dietro le persone. La storia di Sfera rispecchia un po’ la mia storia, di arrivare dall’Argentina e andare a lavorare in fabbrica o fare le pulizie in hotel con mia mamma, la voglia di riscatto che Sfera stesso ha, oppure anche Lauro. Edward dall’altra parte è stata la mia guida in tanti aspetti, soprattutto in quello umano. A volte c’è bisogno di andare in profondità, e a volte no. È bello che ci siano questi aspetti, uno non esclude l’altro. C’è un momento per tutto, un momento per andare dentro alle cose e un momento per ballarci sopra.

ⓢ La spiritualità è importante per te?
Da sempre. È sempre stato un cavo a terra. Qualcosa che ti fa stare sveglio, nel senso di consapevole. La consapevolezza ti porta a sua volta a ragionare in un certo modo verso la vita, la famiglia, gli amici, il lavoro.
ⓢ Hai rischiato di perderti, a un certo punto?
Rischio di perdermi tutti i giorni. Non sono un illuminato. E perdersi è fondamentale, perché se sei intelligente sfrutti quel momento per rimetterti in discussione, per tirare fuori delle energie che non avresti potuto tirare fuori se tutto fosse andato bene. La cosa fondamentale è il percorso che uno fa. Ti metti un obiettivo, e prima di arrivare all’obiettivo succedono sempre mille cose, quindi la parte importante è sempre il percorso. A volte arrivare a destinazione, all’obiettivo prefissato, non è come chiudere un cerchio, perché quell’obiettivo non è più necessario e il percorso ti ha portato altrove.
ⓢ Hai un piano per il Marcelo Burlon del futuro?
No, non ho mai avuto un piano di nessun tipo, né a livello personale né professionale.
ⓢ Come è nato invece il bisogno di raccontarsi nel libro?
Si può chiamare bisogno?
L’idea del libro è nata cinque o sei anni fa insieme a Macs Iotti, nel mentre ci siamo bloccati per mille motivi. E poi a un certo punto mi sono concentrato sul documentario, che è uscito nel 2017, poi è arrivato Bratislav, quello che è mio marito da un anno, è diventato il mio braccio destro, e da lì insieme a Macs e Bratislav abbiamo deciso di continuare a fare il libro, ci siamo concentrati per due anni a raccogliere tutto, a dargli una struttura insieme ad Angelo Flaccavento. Ma più che bisogno
era la voglia di raccontare
anche quello che avevo fatto in passato che in tanti non sanno, o che si è perso nel tempo, nei bombardamenti di tutte le cose successe poi.
ⓢ Penso sia importante che nella tua figura pubblica così pop si riesca a vedere tutta la tua parte prima, l’underground, la creazione, le fondamenta.
Lo è, perché così uno si rende veramente conto di come la storia è iniziata. I ragazzini mi dicono sei un esempio, voglio diventare come te. Però la gente non sa quello che c’è stato nei vent’anni prima. Per arrivare a questo punto io ho dovuto passare vent’anni di esperienze.
ⓢ L’amore ti ha cambiato la vita?
C’è stata un’evoluzione a livello mio personale nei confronti della coppia. Mi ha dato sicurezza mentale. Quando trovi l’amore vero ti senti più libero di creare, ti senti supportato nel bene e nel male, anche quando fai degli errori la persona che ti sta a fianco ti dice le cose come stanno. L’incontro con Bratislav per me è stato fondamentale. Poi è arrivata Noah [il cane, nda], la ciliegina sulla torta, e anche lei ha risvegliato una parte che non conoscevo di me.
ⓢ Ci pensi mai a una storia alternativa? Dove saresti senza il successo?
Sarei ancora a ballare sui cubi.






