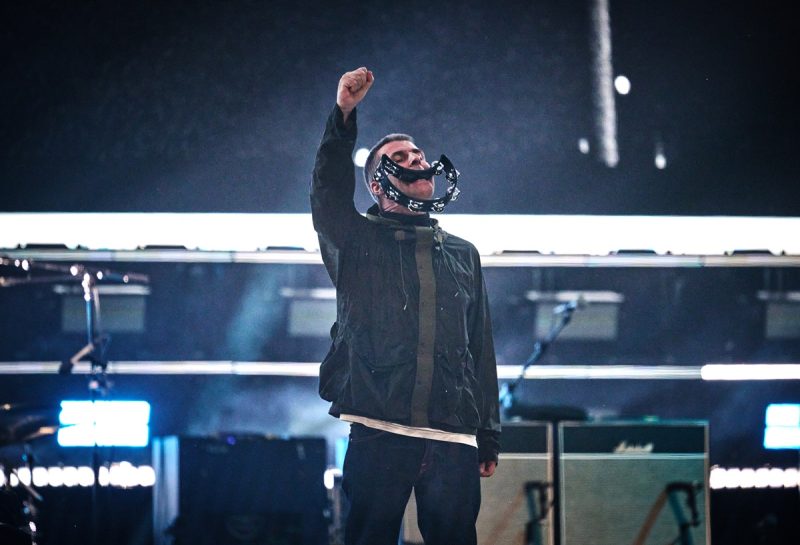Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a gennaio in redazione.

Rachel Aviv, Stranieri a noi stessi (Iperborea)
Un giorno, con gli amici, si parlava di podcast carini, e io avevo citato uno dei miei preferiti, Going Mental di Eileen Kelly, descrivendolo come «un podcast sulla salute mentale». «Oddio che palle!», aveva esclamato, delicatissimo, un mio caro amico. Un po’ divertita e un po’ offesa gli avevo rinfacciato la sua condizione di uomo mentalmente sano, a cui giustamente non frega niente di psicofarmaci, effetti collaterali, diagnosi sbagliate, interi stipendi spesi in terapie e ricoveri, celebrity depresse, disturbi alimentari, dismorfismo corporeo, eccetera. Lui mi aveva doppiamente sorpreso dicendo che in realtà, dicendo che palle, provava a mettersi nei panni del malato (sottinteso: io). Già a queste persone tocca vivere con l’immensa rottura di avere una malattia mentale, in più si devono pure sorbire un podcast sull’argomento? Non avevo saputo ribattere, anche perché in parte aveva ragione: in effetti, quando voglio rilassarmi o divertirmi, preferisco ascoltare podcast true crime. Ma sapevo anche, conoscendolo, che nel suo modo un po’ ruvido voleva ricordarmi che potevo essere molto altro, che non avrei dovuto permettere alla mia malattia di dominare la mia personalità e i miei interessi. Spesso, infatti, mi rifugio nella mia diagnosi come nella più accogliente delle comfort zone. Ecco, mi sono ricordata questo scambio mentre leggevo quello che posso definire senza alcun dubbio il mio nuovo libro preferito. Inizia con la storia dell’autrice, Rachel Aviv, che a sei anni viene ricoverata con una diagnosi di anoressia nervosa. La storia della sua misteriosa guarigione apre questa raccolta di “casi” psichiatrici, cinque persone le cui diagnosi hanno finito per impossessarsi completamente delle loro identità, tra cui Laura, promettente studentessa di Harvard che dopo anni di terapie e diciannove psicofarmaci diversi non sa più chi è senza medicine. È invece Hava, anoressica, a dare il titolo al libro con una frase del suo diario, in cui si definisce «straniera a se stessa». Anni di studio, interviste e dialoghi con i protagonisti danno forma all’indagine con cui la giornalista del New Yorker esplora il bisogno che abbiamo di raccontarci nel disperato tentativo di conoscerci, nella speranza di guarire, ma con il rischio di incastrarci in una definizione che non ci corrisponde mai del tutto. (Clara Mazzoleni)

Kashmir Hill, La tua faccia ci appartiene (Orville Press)
Di tutti gli organismi complessi, gli esseri umani sono gli unici che dimostrino un’evidente tendenza (e uno spiccato talento) per l’autodistruzione. Ed essendo il più complesso degli organismi, diamo a questo nostro desiderio di autoannientamento le forme più complesse. L’ultimo anno lo abbiamo passato a discutere di quanto ovviamente pericoloso sia affidare a intelligenze artificiali proprietà di aziende private tutte le informazioni (parole, foto, video, audio, etc.) presenti su internet. Le ultime 48 ore le abbiamo spese a discettare sulle implicazioni morali e sociali degli impianti cerebrali, dei chip neurali che saranno gli oggetti della prossima Guerra fredda tra Stati e tra corporation. Leggere la storia raccontata da Hill in La tua faccia ci appartiene è come guardare da vicino il volto di un pazzo che si aspetta di ottenere prima o poi un risultato diverso ripetendo sempre la stessa azione: l’umanità continua ad affidare la sua salvezza a tecnologie potenzialmente e prevedibilmente distruttive, per poi stupirsi del sensibile peggioramento della qualità della vita che queste portano. Certo La tua faccia ci appartiene appassiona più che deprimere (fa anche quello), sconvolge più che stizzire (fa pure questo): ha il passo veloce e la struttura a cerchi concentrici dei migliori thriller politico-complottisti. Attorno a una “banalissima” app per il riconoscimento facciale (Clearview AI) si raccolgono mano a mano eminenze politiche, eversori dell’alt-right, tecnomiliardari insaziabili, figure tra il picaresco e il romanzesco – il fondatore di Clearview AI Hoan Ton-That sembra uscito dalla mente di uno sceneggiatore di action movies hollywodiani degli anni ’80 – che se questo fosse un romanzo metterebbero a dura prova la sospensione dell’incredulità di chi legge. Ma è tutto tanto vero quanto assurdo, e Hill tiene la storia attaccata alla realtà sfidando di volta in volta il senso di superiorità che inevitabilmente si accende nel lettore di fronte al disastroso dipanarsi di questa matassa. Certo, è facile indignarsi quando il riconoscimento facciale viene usato male dalla polizia e causa l’ingiusto arresto di un innocente (è successo davvero, a Detroit, ovviamente l’ingiustamente arrestato era un afroamericano). Ma il punto è che certe tecnologie sono intrinsecamente cattive, e il loro impiego dovrebbe indignarci anche quando contribuiscono alla condanna di poliziotti violenti, di rapitori, di ladri, di rapinatori, di assassini. In tutto il suo racconto Hill sottintende che l’impiego di ogni tecnologia è auspicabile solo se siamo disposti ad affrontarne le peggiori conseguenze. Fa impressione che questo libro esca a breve distanza dall’uscita nelle sale di Oppenheimer, che in sostanza pone allo spettatore una domanda assai simile a quella che pone Hill: se avessimo saputo cosa sarebbe successo poi, ci saremmo davvero messi a spaccare gli atomi? E sapendo le conseguenze devastanti che certe tecnologie possono avere nelle mani sbagliate, perché continuiamo a permettere che in quelle mani ci finiscano? E perché queste tecnologie continuiamo a inventarle? (Francesco Gerardi)

Yasmina Khadra, Cosa sognano i lupi? (Sellerio)
Molto prima dell’Isis e ancora prima dell’Undici settembre, e in modo diverso rispetto alle vibrazioni khomeyniane già arrivate dall’Iran, c’è stato un Paese che ha fatto conoscere a noi occidentali le efferatezze ideologiche e materiali del fondamentalismo islamico: l’Algeria, oggi abbastanza sparita dalle mappe, negli anni ’90 incarnò più di ogni altro Paese del mondo arabo una nuova paura che avremmo poi imparato a conoscere benissimo. In questo luogo e proprio in quel tempo emerse la voce di uno scrittore che iniziò a circolare prima in Francia e poi anche da noi. Yasmina Khadra, nome apparentemente femminile, che in realtà nascondeva l’identità di Mohammed Moulessehoul, ex membro dell’esercito e testimone della sanguinosissima guerra civile algerina che segnò il Paese dal ’92 al 2002. Yasmina Khadra ha avuto in Italia editori come Feltrinelli e Mondadori, ma sembra poi essere arrivato alla sua naturale destinazione di sempre, Sellerio, che ne sta ripubblicando l’opera. Perché naturale destinazione? Perché il suo modo di scrivere, che usa il noir o il poliziesco per raccontare in realtà la società algerina, è il tipo di letteratura di impronta diciamo così sciasciana che ha reso l’editore palermitano un marchio con una sua identità riconosciuta. E così è Cosa sognano i lupi?, riedizione di un romanzo del 1999 originariamente uscito per Feltrinelli, dove, come in altri romanzi dello scrittore algerino, si racconta la storia di formazione di un terrorista, Nafa Walid, passato dalla gloria di una mezza comparsata in un film, che gli fa sognare una carriera nel cinema, al lavoro di autista presso una famiglia ricca e potente di Algeri, per arrivare infine ad abbracciare le armi e la fede, più per un senso di solitudine che altro. Una storia che, come si dice, finisce per risultare tremendamente attuale, ma che include motivi per leggere puramente letterari. La scrittura limpida e tesa, l’atmosfera così lontana così vicina di questo Nordafrica urbano, l’attrazione/repulsione imposta da molti dei personaggi che prendono vita nelle pagine. (Cristiano de Majo)
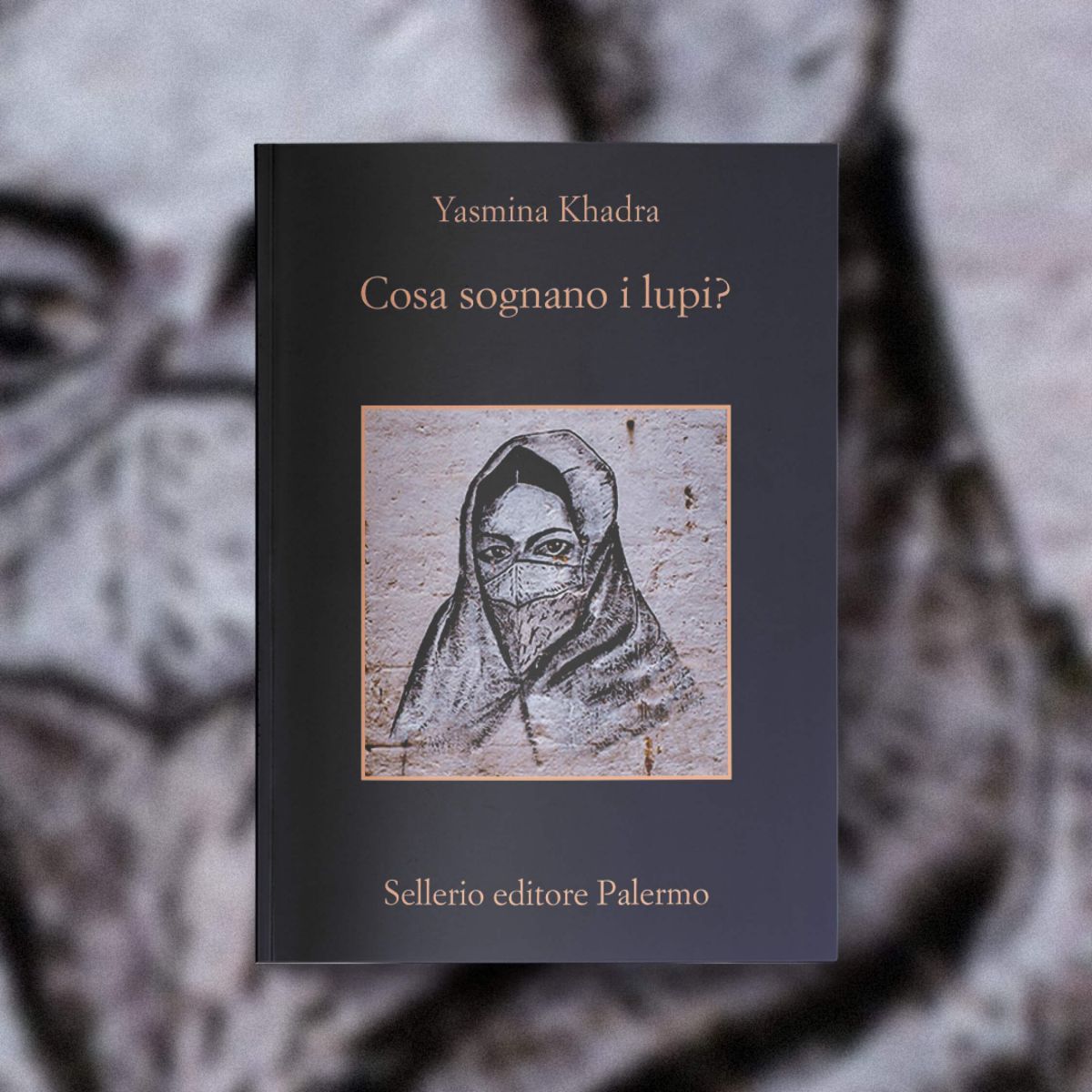
Emanuela Anechoum, Tangerinn, Edizioni E/O
A un esordio letterario la prima cosa che chiedo è di non essere noioso. Di non essere banale. Di non essere come tutti gli altri, e di non essere moralistico. Di essere magari divertente, oppure va bene anche disturbante. Di non essere necessario, come scrivono sulle bandelle dei libri assolutamente non necessari. Questo Tangerinn di Emanuela Anechoum rispetta tutti i miei desideri. È fresco, è provocatorio, è cinico per certi tratti, e per altri molto tenero. È diverso. Emanuela è nata in Calabria ma ha un padre marocchino e, va detto subito, questo libro non è un memoir. Certo, c’entra la sua esperienza di vita, questo non sentirsi né una cosa né un’altra, troppo marocchina per essere italiana, troppo italiana per essere marocchina, come scriveva in un articolo su Vice che in un certo senso anticipava questo libro. Ma Mina, la sua protagonista, ha trovato la sua identità nell’essere come tutti, tutti quelli giusti si intende: vive a Londra e dice le cose giuste, combatte le battaglie giuste, condivide le Stories giuste, è una specie di Airbnb dell’attivismo in formato umano. Ecco, l’acutezza con cui Anechoum smaschera lo slacktivism o un certo femminismo performativo e capitalista è uno dei punti più forti di Tangerinn. La sua compagna di casa a Londra, modello di influencer impegnata, le dice subito: sono un’alleata. Lei non capisce che vuol dire. Poi, affascinata da quelle origini arabe, dice ancora: voglio sapere tutto di te. Ma la interrompe subito, e se ne disinteressa in fretta. Ancora: «Un Natale, con Liz e altri amici eravamo andati in India, a conclusione di un percorso spirituale iniziato con un’app di meditazione e coronato da una lettura di Eat Pray Love». La protagonista non è una vittima, e lo capisci quando la trovi a pisciare nel balsamo della sua amica, e scuoterlo forte. Ma non è solo questa, la forza di Tangerinn. Il lato più umano e sofferto è quello del rapporto con le origini (che sono varie: italiane e marocchine, cattoliche e musulmane) e con la famiglia. Il padre (marocchino) di Mina muore, e lei deve tornare nel piccolo paese mafioso del sud Italia, e fare i conti con quello scheletro di famiglia che le rimane, con la fumosità delle sue convinzioni, con l’eco delle proprie radici, con la vita di un genitore che non le ha mai detto tutto, e forse ha fatto bene così. Questa è la vera spina dorsale della trama, su cui Anechoum costruisce poi le scene caustiche o romantiche, sofferte o sceme, di un palcoscenico di personaggi tutti storti e tutti rotti. Come succede nelle storie più vere, non c’è nessun miracolo, alla fine. (Davide Coppo)

Alice Scornajenghi, Atti Puri (Nero Editions)
Scrivere scene ed episodi erotici è una delle dannazioni di qualsiasi scrittore. Quasi tutti quelli che si sono cimentati con difficoltà hanno raggiunto un risultato coinvolgente, non imbarazzante o cringe tanto che, dal 1994 fino al 2022, Literary Review ha premiato la peggior scena erotica dell’anno. Nell’esperimento narrativo e amoroso generazionale e non solo che contraddistingue questi anni, anche questo genere viene preso, sfidato e capovolto soprattutto da scrittrici giovani, nel tentativo di raccontare il nuovo concetto di amore e di sesso, controvertendo quello che abbiamo sempre pensato “normale” dimostrando che a non esistere in questo campo è proprio il concetto stesso di norma. Alice Scornajenghi è una di queste. Prima con la sua fanzine Ossì – un magazine porno? erotico? underground? tutte queste cose insieme? – e ora con la raccolta di racconti Atti Puri, uscita a novembre 2023 per Nero Editions, esplora cosa significa scrivere di sesso oggi da un nuovo punto di vista che possiamo certamente definire femminista, e poi disincantato, sperimentale, che mette al centro il piacere e i modi innati e naturali di raggiungerlo. Così naturali che travalicano le ere e le galassie e per questo sceglie ambientazioni – forse anche per rischiare il meno possibile di suonare scontata o ridicola – volutamente esagerate, gonzo, post-umane, fantascientifiche. Nel racconto “L’allevamento”, ad esempio, si cura l’asma con lo sperma, in “Comfort Food” umani atterrano su un nuovo pianeta; nel “Pollice del panda” gli umani sono in estinzione e sono loro a vivere in uno zoo. Nei sei racconti che raccontano il sesso da un punto di vista insolito e svergognato ci sono i robot, nuovi messia, cazzi fluo. Atti Puri è un esperimento narrativamente interessante, vivo, che apre a nuovi mondi, talvolta a prescindere dalla vera eccitazione del lettore. Forse perché ora non è solo questo l’obiettivo, ma soprattutto quello di aprire una breccia, mettersi alle spalle il panico e rendere anche questo un genere come un altro, stavolta sì “normale”. (Teresa Bellemo)
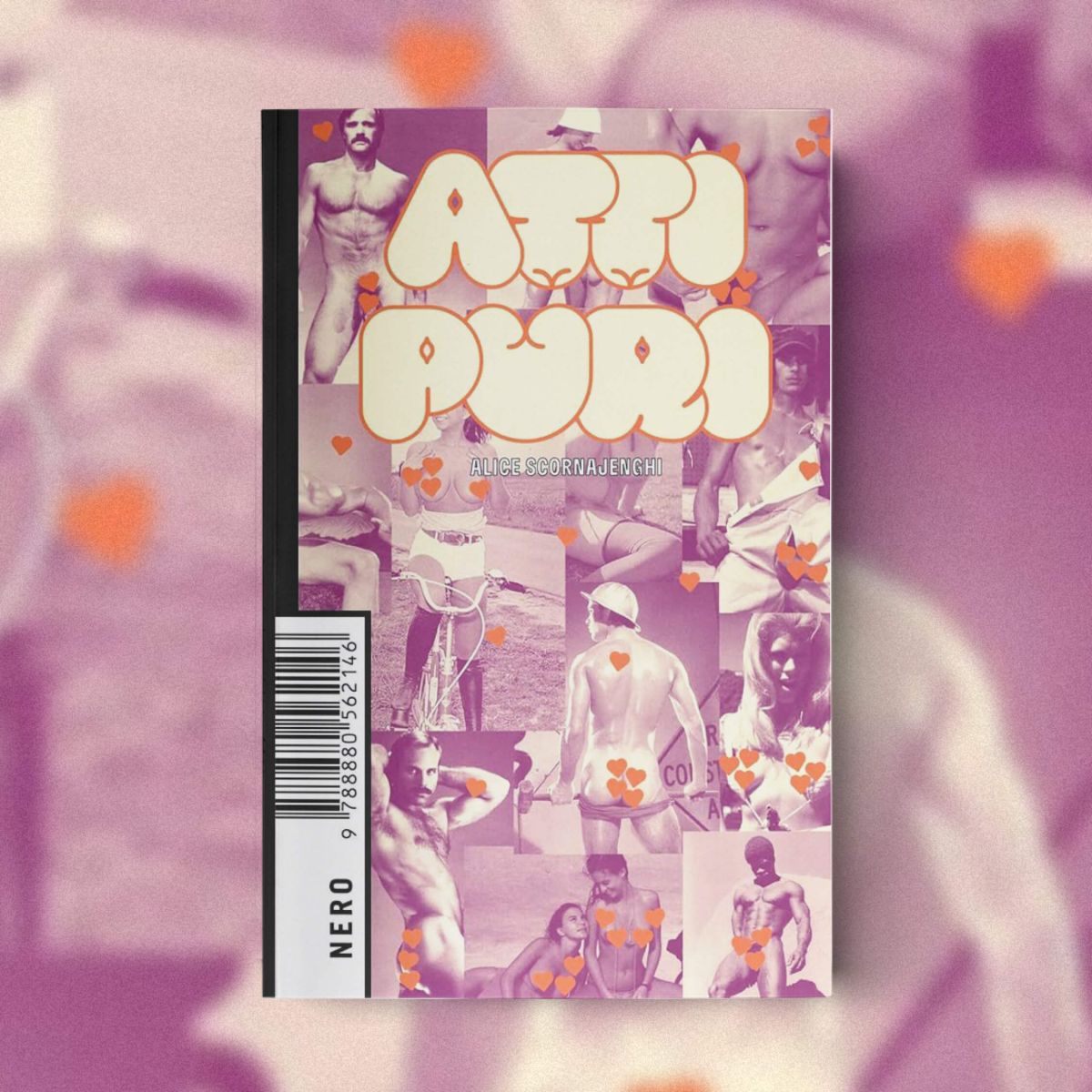
Nell’immagine di copertina: un dettaglio di “Rigged” di Kate Cooper