La nuova serie della creatrice di Girls è piena di difetti ma ha un pregio che da solo quasi basta a redimerla: rende bene l'idea di che cosa terribile siano le relazioni oggi.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a marzo in redazione.

Lidia Yuknavitch – Il libro di Joan (Einaudi)
Trad. Laura Noulian
Se la terra finisse a causa di un’ultima catastrofe in cui il genere umano è riuscito a distruggere quasi del tutto se stesso e una larghissima parte delle risorse del pianeta, e se non rimanesse altro che uno sparuto gruppo di super ricchi che riesce a trasferirsi su un pianeta B, che poi è una specie di grande nave spaziale dalla quale non si può uscire e dove governa un dittatore fascista e misogino che sulla Terra era una celebrity e che ha sfruttato la sua fama per costruire il suo consenso politico, allora saremmo su CIEL, il non-luogo immaginato da Lidia Yuknavitch per il suo Libro di Joan, pubblicato in Italia da Einaudi. Ed è quasi ironico, ritrovandoci a vivere il momento in cui viviamo, immaginare un futuro in cui a sopravvivere sono proprio i membri coltissimi di quelle élite cui oggi si imputa il fallimento di un modello, ma l’autrice non ha paura di rinunciare a tutte gli autocompiacimenti umani, primo fra tutti il mito del progresso 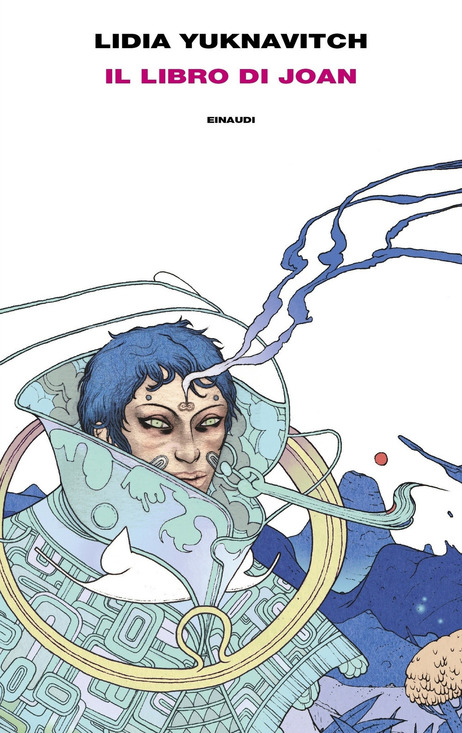 inevitabile. Nel mondo di Yuknavitch nessuna questione è stata risolta, né quella ecologica, né quella razziale, tantomeno quella di genere: è venuta l’apocalisse e gli umani non hanno saputo far di meglio che trasformarsi in larve senza sesso né colore, bianchi bruchi fosforescenti capaci solo di scriversi, e farsi scrivere, degli strani innesti («lontani discendenti dei tatuaggi, cugini spuri dell’alfabeto Braille») sulla pelle molliccia. Ora muoiono tutti a cinquant’anni e non possono riprodursi, obbediscono a uno che ha impedito loro anche solo di pensare al sesso, così quando Catherine, che compone innesti radicali perché ancora umani, decide di scriversi addosso (e così tramandare, anche se non è detto che esisterà qualcosa dopo CIEL) la storia dell’eco-terrorista Joan di Fango, nemesi del dittatore-celebrity e figura cristologica ispirata a Giovanna d’Arco, qualcosa si incrina, o forse ricomincia. Il libro di Joan è un libro difficile, che non costruisce davanti agli occhi gli universi alla maniera di Jeff VanderMeer, perché Yuknavitch sceglie di prospettarci sin da subito la peggiore delle fini possibili, quella in cui sopravviviamo e rischiamo di sbagliare tutto un’altra volta. (Silvia Schirinzi)
inevitabile. Nel mondo di Yuknavitch nessuna questione è stata risolta, né quella ecologica, né quella razziale, tantomeno quella di genere: è venuta l’apocalisse e gli umani non hanno saputo far di meglio che trasformarsi in larve senza sesso né colore, bianchi bruchi fosforescenti capaci solo di scriversi, e farsi scrivere, degli strani innesti («lontani discendenti dei tatuaggi, cugini spuri dell’alfabeto Braille») sulla pelle molliccia. Ora muoiono tutti a cinquant’anni e non possono riprodursi, obbediscono a uno che ha impedito loro anche solo di pensare al sesso, così quando Catherine, che compone innesti radicali perché ancora umani, decide di scriversi addosso (e così tramandare, anche se non è detto che esisterà qualcosa dopo CIEL) la storia dell’eco-terrorista Joan di Fango, nemesi del dittatore-celebrity e figura cristologica ispirata a Giovanna d’Arco, qualcosa si incrina, o forse ricomincia. Il libro di Joan è un libro difficile, che non costruisce davanti agli occhi gli universi alla maniera di Jeff VanderMeer, perché Yuknavitch sceglie di prospettarci sin da subito la peggiore delle fini possibili, quella in cui sopravviviamo e rischiamo di sbagliare tutto un’altra volta. (Silvia Schirinzi)
Olga Tokarczuk – I vagabondi (Bompiani)
Trad. Barbara Delfino

Ci dev’essere qualcosa in mezzo, capitava di ripetermi negli ultimi anni quando la dicotomia tra fiction e non-fiction diventava sempre più urlata, e si annunciavano morti e risurrezioni dell’una e dell’altra sia negli articoli dei giornali che nelle cene e negli aperitivi – «sai ormai leggo solo saggi, ho smesso coi romanzi». E c’era, naturalmente, qualcosa in mezzo: innanzitutto negli stessi saggi e negli stessi romanzi, sempre un po’ finti e un po’ veri con equilibri diversi a seconda del genere. Ma in questi stessi ultimi anni si ri-sviluppava un interesse per una letteratura di viaggio interpretata in un modo originale, e alla fine trovavo sempre questo ambiguo mezzo in W.G. Sebald, nelle sue passeggiate e nelle sue storie e nelle sue fotografie. L’anarchia narrativa di Olga Tokarczuk è dello stesso ramo di quella di Sebald, ma anche dello stesso ramo, in un certo senso altro senso, di quella delle recentissime Claire Louis Bennett (Stagno) e Rachel Cusk (la Trilogia): libri a cavallo tra verità e invenzione, fatti di una forma non convenzionale, con una lingua attenta, prosastica ma fortemente poetica. I vagabondi (in polacco l’intraducibile Bieguni, in inglese il più adatto Flights), vincitore dell’International Man Booker Prize 2018, è un libro fatto di centinaia di brevi testi – alcuni di poche righe, altri di alcune pagine – di divulgazione (scienza), finzione (racconti) o chissà (aneddoti oppure osservazioni in prima persona di un’anonima protagonista) – sullo spostamento, il viaggio, la migrazione, il movimento, l’abbandono. Un libro o raccolta di testi da leggersi come si legge un frasario, un libro di poesia, una rivista, un Libro delle risposte, le Note azzurre di Carlo Dossi, moderno e tradizionalissimo, ambiguo, in mezzo. C’è un angosciante racconto lungo una decina di pagine su un turista polacco su un’isola croata che vede sparire da un’ora all’altra la moglie e il figlio, e sette bellissime righe che dicono: «Volo da Irkutsk a Mosca. Si decolla da Irkutsk alle otto del mattino e si atterra a Mosca alla stessa ora – otto del mattino dello stesso giorno. Questo è il momento esatto in cui sorge il sole, quindi si vola per tutto il tempo all’alba. Si rimane in questo singolo istante, grande, tranquillo, espanso come la Siberia. Dovrebbe essere il momento per la confessione di un’intera vita. Il tempo scorre all’interno dell’aereo, ma non fuoriesce all’esterno». (Davide Coppo)
Rachel Cusk – Transiti (Einaudi Stile Libero)
Trad. Anna Nadotti
 Difficile stabilire se sia più colpa di Proust o di Hbo, ma una delle tendenze forti della letteratura-letteratura recente è il ritorno della saga e della serialità, un formato normalmente prediletto dalla letteratura cosiddetta di genere. Non per tutti è uguale, però, e mentre Elena Ferrante, con i suoi quattro volumi, si muove su un territorio al confine tra high e middlebrow, Knausgård, con i suoi sei, finisce invece dalle parti del ciclo di romanzi di cui tutti parlano e che nessuno ha veramente letto per intero. La “Trilogia” di Rachel Cusk, che arriva in questi giorni alla pubblicazione del secondo volume in traduzione italiana, Transiti, è qualcosa di ancora diverso: sono libri che hanno avuto un’attenzione critica enorme (in lingua inglese, soprattutto) ma che portano in sé la potenzialità del passaparola; viene voglia di leggerli e di consigliarli anche, una specie di miracolo considerati i tempi. Certo Resoconto aveva impressionato – o meglio: mi aveva impressionato – così tanto, che non posso nascondere una certa delusione rispetto a questo “seguito”. La parte iniziale è meno smagliante, forse per un maggiore ricorso di Cusk al discorso diretto (che rende la scrittura meno ipnotica, meno sinusoidale), forse perché in Resoconto era più forte la presenza della vita con i suoi snodi, laddove in Transiti la riflessione teorica prende a volte troppo il sopravvento. Resta naturalmente un libro da leggere, soprattutto quando la scrittrice ritrova il filo del discorso: il punto in cui la storia inizia a fuggire e a scavare un tunnel che si spalanca davanti a un’ulteriore storia rispetto a quella che sembra essere la “trama principale”, come succede nel caso della conferenza: pagine fantastiche di vita e letteratura. (Cristiano de Majo)
Difficile stabilire se sia più colpa di Proust o di Hbo, ma una delle tendenze forti della letteratura-letteratura recente è il ritorno della saga e della serialità, un formato normalmente prediletto dalla letteratura cosiddetta di genere. Non per tutti è uguale, però, e mentre Elena Ferrante, con i suoi quattro volumi, si muove su un territorio al confine tra high e middlebrow, Knausgård, con i suoi sei, finisce invece dalle parti del ciclo di romanzi di cui tutti parlano e che nessuno ha veramente letto per intero. La “Trilogia” di Rachel Cusk, che arriva in questi giorni alla pubblicazione del secondo volume in traduzione italiana, Transiti, è qualcosa di ancora diverso: sono libri che hanno avuto un’attenzione critica enorme (in lingua inglese, soprattutto) ma che portano in sé la potenzialità del passaparola; viene voglia di leggerli e di consigliarli anche, una specie di miracolo considerati i tempi. Certo Resoconto aveva impressionato – o meglio: mi aveva impressionato – così tanto, che non posso nascondere una certa delusione rispetto a questo “seguito”. La parte iniziale è meno smagliante, forse per un maggiore ricorso di Cusk al discorso diretto (che rende la scrittura meno ipnotica, meno sinusoidale), forse perché in Resoconto era più forte la presenza della vita con i suoi snodi, laddove in Transiti la riflessione teorica prende a volte troppo il sopravvento. Resta naturalmente un libro da leggere, soprattutto quando la scrittrice ritrova il filo del discorso: il punto in cui la storia inizia a fuggire e a scavare un tunnel che si spalanca davanti a un’ulteriore storia rispetto a quella che sembra essere la “trama principale”, come succede nel caso della conferenza: pagine fantastiche di vita e letteratura. (Cristiano de Majo)
Marco Missiroli – Fedeltà (Einaudi)

È stato bello seguire idealmente la mappa della città schizzata in Fedeltà. Leggerlo in Piazzale Bacone durante una pausa pranzo passata su una panchina dei campi da bocce di Via Morgagni dove passa anche Margherita; passeggiare per Milano, per me che ci vivo da poco, e immaginare la casa Concordia, chiedersi se avranno poi installato l’ascensore, ora che ci sono anche i lavori per la metropolitana. Vedere NoLo con gli occhi di chi ci è nato cinquant’anni fa, andare a un appuntamento con un agente immobiliare appena chiusa la pagina ambientata in via Porpora, confondendo i civici del libro con quelli dell’annuncio. Fedeltà è un libro che porta e accompagna in giro per Milano schivando la folla, in una sorta di lenti passaggi di luce, di diverse illuminazioni, dove è notte e dove è giorno, dove si tocca l’amore e dove si sfiorano le mancanze. (Teresa Bellemo)
Claudia Durastanti – La straniera (La nave di Teseo)

Nel suo memoir-saggio-romanzo, entrato nella dozzina del Premio Strega, Durastanti racconta i primi anni di vita vissuti negli Stati Uniti, il trasferimento in un piccolo paese della Basilicata, il presente in una Londra ostile e deludente. Ma soprattutto racconta i suoi genitori, creature rare e affascinanti, entrambi sordi, entrambi dotati di un temperamento artistico poco spendibile nella vita reale. È ormai un luogo comune dire che un libro scritto da una donna sia scritto con un linguaggio “duro”, “senza fronzoli”. Non è questo il caso. La straniera è un libro poco americano e molto italiano: procede disordinatamente, scardinato, affettuoso, concitato. È scritto con amore e parla di storie d’amore (non so se ci avete mai provato, ma sono entrambe cose difficilissime da fare in un memoir). Si interroga su cosa significhi essere immigrati e di cosa significhi essere disabili, senza retorica ma non senza poesia. Non dice che quando ci sentiamo smarriti, senza un luogo da poter chiamare nostro, ci restano le persone: dice anzi che possono essere proprio le persone che amiamo di più a farci sentire smarriti e che certi punti di riferimento possono trarci in inganno invece di indicarci la via. Per questo motivo, anche se racconta una storia assolutamente unica, La straniera è il primo libro italiano in cui mi sono riconosciuta a livello generazionale. Non parla di trentenni, ma è intriso del senso di smarrimento che caratterizza quelli come noi: dell’aver sentito, a un certo punto del nostro percorso di crescita, la terra sotto ai piedi che si riempiva di crepe. Su quale zolla restare, per salvarci? Come decidere? È un’atmosfera mentale ben precisa, che difficilmente chi è più grande o più piccolo può capire e che finalmente una scrittrice italiana è stata in grado di dipingere. (Clara Mazzoleni)






