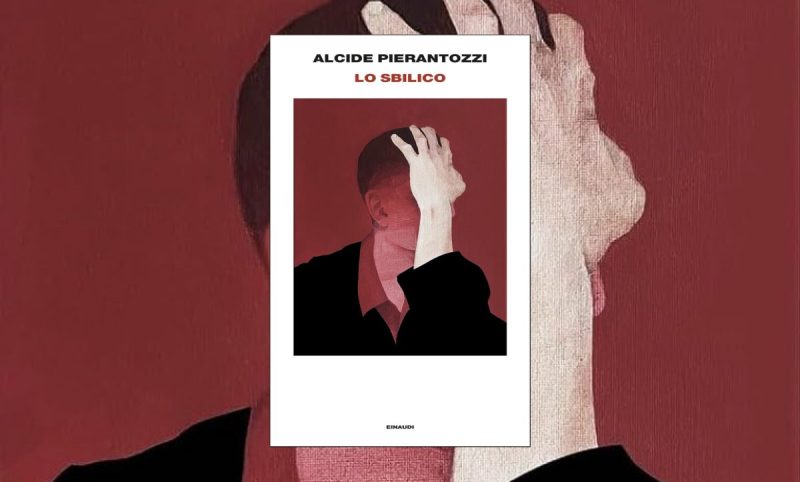La nuova serie di Netflix con protagoniste Julianne Moore e Meghann Fahy racconta le dinamiche di potere tra tre donne, ma soprattutto dell’uomo che le guarda dall’alto.
Il successo delle brutte poesie di Franco Arminio
A Sanremo Marco Mengoni ha letto i versi del poeta che si auto-definisce "paesologo" e ha conquistato le classifiche con la sua ricetta di autenticità.

In uno dei tanti video celebrativi che si trovano in rete, Franco Arminio è seduto in quella che credo sia la sua casa a Bisaccia, in Irpinia, dove è nato e ha sempre vissuto. Ha una sciarpa a righe sul collo e un maglione nero. È un bell’uomo. Dice che la poesia non deve essere per pochi, che è come se la nobiltà e la bellezza fossero per pochi. Ha una voce calma ma leggermente acuta, alta. Racconta di aver fondato una disciplina che si chiama paesologia e che consiste nell’andare a zonzo per paesi diroccati, abitandoli con il proprio spirito. La vita in città non gli interessa, il progresso e la modernità sono corrotti, l’uomo è allo stremo, può risorgere solo prestando attenzione alle piccole cose. È convinto di piacere, di dire cose profonde che attaccano il senso comune. In generale, l’immagine pubblica che vuole dare è quella di un avventuriero, di un grande amatore, di uno che sa quello che vogliono le persone. Anche la sua attività poetica in fondo sembra imperniata più che altro sul restituire una precisa immagine di colui che scrive, e sul renderla il quanto più seducente. È come se ogni suo verso dicesse: «chi scrive le parole che state leggendo, lui sì che ha scoperto il segreto del vivere».
Il che potrebbe anche essere vero. Franco Arminio è riuscito nell’impresa di fare soldi con la poesia. I suoi libri non mancano mai negli scaffali delle librerie, ne pubblica uno o due all’anno, immagino la sua vita come quella di un operaio della catena di montaggio dello spirito. Pochi giorni fa è uscito il suo primo libro per Einaudi, Studi sull’amore. A Sanremo Filippo Scotti e Marco Mengoni hanno letto una sua poesia. Le fascette dicono che è il poeta italiano più seguito sulla rete.
Ovviamente è facile parlare male di Arminio, come di qualsiasi fenomeno para-letterario. Le sue raccolte sono l’equivalente degli Harmony in poesia. Risultano stucchevoli e imbarazzanti pure all’interno dello stagnante panorama poetico italiano, ancora pieno di petrarchismo e anime belle. La singolarità è che Arminio, a differenza di autori come Guido Catalano e Gio Evan, sembra provenire dalla letteratura seria. Nel 2010 pubblica Cartoline dai morti, nel 2011 Terracarne con Mondadori, libri anche latamente sperimentali, non scontati, in cui non senza sforzo possiamo trovare qualche pregio. La critica lo ignora, i lettori di più, gli addetti a lavori guardano a lui con una certa neutralità: come se fosse un deodorante o un dentifricio. Nel 2017 la svolta. Cedi la strada agli alberi, con una brevissima prefazione di Saviano, diventa un bestseller, Franco Arminio un fenomeno letterario. La sua scrittura da insipida diventa volutamente brutta. Inizia a scrivere sui giornali. Pubblica testi sul Corriere della Sera, poesie sul coronavirus, su Maradona, sul ministro Boccia.
Arminio, in un articolo del 2020, rivendica la legittimità della propria poetica: «Non capisco perché di fronte a una mutazione inaudita in atto nel mondo la letteratura debba rimanere tale e quale. Un mondo che si è fatto velocissimo richiede una letteratura semplice e breve, diretta e limpida. Questo non significa che si passa dall’espressione alla comunicazione, non significa che il chiarore faccia perdere intensità e complessità. Semplicemente bisogna prendere atto che oggi nessuno ha tempo da perdere con la letteratura che non sa consolare, non sa orientare. Le persone non leggono, ma se leggono vogliono essere consolate e orientate».
Ancora: «La letteratura che si ritiene seria e complessa e colta spesso è semplicemente una letteratura arrogante che odia i lettori per il fatto che hanno uno sguardo sulle cose che gli scrittori non hanno. Gli scrittori che cercano la brevità e la semplicità non sono dei venduti al gusto dei lettori, non sono quelli che mettono acqua nel vino, sono gli scrittori che ancora provano a fare miracoli e qualche volta li fanno». Queste ultime parole hanno qualcosa di vero. Solo che tendere la mano al lettore non significa trattarlo come uno scemo. Le poesie di Arminio non hanno niente di semplice o di genuino o di autentico, o addirittura di denso, come dice nel prosieguo dell’articolo, offrono semplicemente una visione del mondo semplicista e consolatoria, manichea e reazionaria. L’essere umano per Arminio non è scisso, può ancora contare su una solida Stimmung, su un accordo con il mondo e le cose. Leopardi e il Novecento sono un ricordo lontano. Ora è tempo di resistere alla barbarie del presente («non mi pare sopportabile/ che la modernità sia diventata/ la fossa comune dell’economia,/ il cielo rifiuto alla morte, a Dio,/ alla poesia») e di postare magnolie e cascine diroccate su Instagram, di andare il weekend a fare arrampicata. Nel sistema valoriale di Arminio non è consentita alcuna incertezza, alcuno scarto da una partecipata gioia di vivere, alcun comportamento deviante rispetto all’adesione a se stessi e al mondo.
I suoi libri non mancano mai negli scaffali delle librerie, ne pubblica uno o due all’anno, immagino la sua vita come quella di un operaio della catena di montaggio dello spirito.
Il dilettantismo formale e l’approssimazione estetica, il sentimentalismo e il paternalismo che troviamo nelle poesie di Arminio, insieme a quello schema cognitivo irriflesso che permette ai suoi versi di restituire una realtà priva di chiaroscuri, in cui il bene è sempre separato dal male e facile da raggiungere (è dentro di noi, ma questi tempi cattivi non ci permettono di vederlo), e insieme, ovviamente, all’infantilismo etico e politico (non esistono classi, la dialettica campagna-città così centrale per i suoi testi è privata di qualsiasi dimensione materialistica e si risolve in una dicotomia piatta, a due dimensioni), tutte queste cose, fanno di lui il Walter Veltroni della poesia italiana.
Molti testi consistono in delle brevi scene che l’autore (lo sentiamo) concepisce come particolarmente autentiche: un vicolo di un paesino diroccato sull’Appennino lucano, un vecchio bar senza clienti, un ricordo dell’infanzia (Arminio è ossessionato dalla figura materna, ha chiaramente un enorme Edipo irrisolto); azioni minime in cui è nascosto il Senso negato all’uomo di città, al borghese che non è anche un artista, al lavoratore sottopagato che non è dotato di sensibilità, al bancario che non coltiva ulivi in Cilento. Il problema è che questi quadretti così importanti per la soggettività di Arminio non sono altrettanto importanti per la mia, perché non sono mediati artisticamente. L’impressione principale che si ha leggendo i suoi libri è infatti quella di un egocentrismo smisurato, di attraversare, pagina dopo pagina, un ambiente di un’autoreferenzialità asfittica («Sono Arminio/ alto e fragile, di alluminio./ Della quiete e dell’amore/ sono il franco tiratore»). L’egotismo di chi dice io nel testo è patologico, la sua postura è quella del prete, del vate, del taumaturgo, del dittatore (al punto di gioire al dolore degli altri pur di esercitare la propria funzione: «La sera che fece il terremoto io stavo bene./ Mi piaceva tutta quella gente per strada,/ tutti che si guardavano come se ognuno/ fosse una cosa preziosa./ Quando si sono messi a dormire/ nelle macchine/ mi sono fatto un giro,/ li ho benedetti uno per uno»).
Non bisogno aver letto Hegel o Adorno per capire che in letteratura, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono importanti le cose ma come sono dette. E che questo è il contenuto sociale di un testo letterario. Per quanto Arminio voglia ammantare la propria operazione poetica di ambizioni politiche e carica civile (perché sì, per lui la poesia può cambiare il mondo), essa risulta invece colma di narcisismo e cattiva soggettività, seduce, non trasforma. È conservatrice, non rivoluzionaria. È un OGM in cui non si capisce dove finisce il kitsch e dove inizia il cringe.
La poesia di Arminio è una sorta di cura omeopatica di massa attraverso cui ogni lettore rafforza il proprio senso di unicità (non c’è niente di più conformistico e consumistico di sentirsi unici), la propria distinzione sociale, assume capitale simbolico a basso costo, in una sorta di fast-food dell’anima. Avvalora la sensazione di stare dalla parte giusta della storia (dalla parte degli alberi, degli anziani, delle cose desuete, a chi non piacciono?), si sente gratificato. Ed è una sensazione che non richiede sforzi: le singole poesie che incontra nelle raccolte sono ad alta comprensibilità, immediate, interscambiabili le une con le altre; le metafore che le compongono sono meccaniche, elementari, quando non esplicitamente patetiche o casuali (a volte si ha l’impressione che quella di Arminio sia quasi poesia automatica, nel senso che l’autore scrive la prima cosa che gli viene in mente senza preoccuparsi che abbia molto senso). Gli accostamenti nome-predicato sono sempre scontati (il cielo è azzurro, la morte è brutta ecc.), la lingua è complessivamente sciatta. Insomma si tratta di una scrittura che non ha niente di “poetico” in senso forte, ma che ambisce ad esserlo in un senso del tutto deteriore, ovverosia nella convinzione che la poesia abbia a che fare con i buoni sentimenti, con una supposta profondità, con il bello, con la natura e l’armonia.
Non so bene perché, ma sono convinto che tra qualche anno uscirà fuori che quello che noi crediamo essere Franco Arminio non esista, che sia tutta un’invenzione, che sia stato un gesto di trolling mitopoietico per beffarsi del mercato editoriale, che era tutto uno scherzo ai danni dei lettori. Franco Arminio è un collettivo di ricercatori della Sorbonne, è un bot, un esperimento scientifico, un test sociologico, un lapsus delle big tech dotato di bell’aspetto e barba rada e brizzolata. «Io vorrei un’umanità follemente sentimentale/ perché siamo più belli/ quando cominciamo a sfiorarci».