Il film si intitola The Mountain, The Moon Cave and The Sad God ed esce nello stesso giorno del loro nuovo disco, The Mountain.
Trevi, un fallimento esemplare
Sul nuovo libro dello scrittore romano, Sogni e favole, che rimpiange il passato e contesta la superficialità del presente.
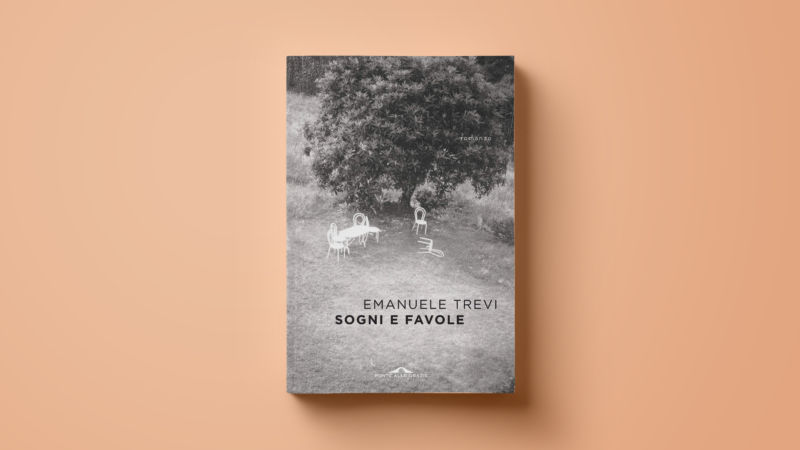
Esempio italiano di “letteratura camminata“, Senza verso di Emanuele Trevi (Laterza, 2004), è anche probabilmente uno dei romanzi italiani migliori degli ultimi anni. In una Roma uterina, caldissima e impossibile, il narratore, uno spiantato trentenne inetto e iperiflessivo, tenta di sopravvivere a un trasloco e a una dolorosa separazione girando ossessivamente per le stesse strade (su tutte via Labicana e via Merulana), cercando, nei suoi tragitti sempre identici, un’amniotica, salvifica, sensazione di familiarità. La sua meta principale è la Basilica di San Clemente in Laterano, perfetta, con la sua stratificazione su tre livelli (sagrestia “moderna”, di epoca medievale + due livelli sotterranei: basilica risalente al III secolo e tempio di Mitra), nell’offrire un rimedio alla calura e all’inquinamento sonoro particolarmente opprimenti nelle estati romane. Ma la peculiarità del romanzo, della sua bellezza, nonché della sua stessa struttura, è l’interrelazione tra spazio e memoria, tra, come dire, una geografia interiore e una geografia esteriore: le strade che Trevi consuma nell’estate 2003 sono le stesse strade che era solito percorrere con un amico-mentore, Pietro Tripodo, uno dei poeti (e traduttori) italiani più raffinati del secondo Novecento. Il narratore sembra così lentamente scrollarsi dalla sua morbosità scorciando un ritratto emozionante e indimenticabile dell’amico.
Il nuovo libro di Trevi, Sogni e favole, appena uscito per Ponte alle Grazie, sembra richiamarsi direttamente a Senza verso: una solitaria passeggiata in una Roma stavolta piovosa e fredda, tra le strade e le stradine che da Campo de’ Fiori vanno fino a piazza del Fico, è l’apparente occasione per parlare di tre grandi personalità che hanno influenzato la vita del narratore, a quelle strade intimamente legati: Amelia Rosselli, amica dello psicanalista Mario Trevi, padre di Emanuele; Arturo Patten, che di Emanuele era stato amico a partire dagli anni ’80; Cesare Garboli, il geniale e scostante critico presentato a Trevi proprio da Arturo. Su di loro aleggia il fantasma di Metastasio, popolano romano trapiantato a Vienna, autore del sonetto che dà titolo al libro: un amaro lamento che ruota intorno all’inconsistenza ontologica del reale, alla sua porosa irrealtà.
Il narratore, quindi, partendo da alcune coincidenze spaziali, in un collasso di tempi e destini, rievoca le figure e le opere dei grandi artisti e maestri, di cui abbozza come delle radiografie esistenziali. Il libro («a metà fra il saggio letterario e la seduta spiritica»), è, di fatto, composto solo di lunghe digressioni e fughe tematiche, secondo il tipico andamento lirico-saggistico della maggior parte dei libri di Trevi, in cui tante brevi sezioni si articolano in base a criteri più associativi che logici o consequenziali. Il problema è che su Sogni e favole grava il peso di una lettura semplicistica, riduttiva e reazionaria del presente. Tutto il libro oppone manicheisticamente a un passato autentico e profondo un presente inautentico e superficiale, in una schematizzazione che finisce per inficiare tutta la narrazione: «Era ancora il tempo degli artisti, nel senso che questa parola poteva avere nel lento crepuscolo del Novecento, quando un poeta, un pittore, un regista erano esseri umani investiti da una vocazione, e la loro vita non era un pettegolezzo, una delle tante variabili della celebrità, un’attraente carriera mondana, ma una storia vissuta fino ai limiti dell’umano, spremuta fino all’ultima goccia». Ma si prenda, nel complesso, tutta questa pagina: Trevi sta parlando di Tarkovskij, che considera esempio perfetto di artista totale, che non scende a compromessi con il pubblico e con il mercato, «Mi ricordo di una proiezione di Nostalghia in un cinema romano. A un certo punto si realizzava una situazione tipicamente “tarkovskiana”: qualcuno camminava sul fondo di una piscina vuota, doveva portare una candela accesa da un bordo all’altro o qualcosa del genere. Mentre quella sublime, ermetica, insensatezza si protraeva oltre ogni tollerabilità, un grido interruppe il concentrato, partecipe silenzio che regnava in sala – “daje, ce la puoi fare co’ ‘sta candela!”. Tutti iniziarono a fare il tifo, e quando la scena finì scrosciò un applauso liberatorio. Con la mentalità di oggi, diremmo che l’artista, in questo caso, aveva mancato il bersaglio, aveva fatto un errore. Perché il gioco ormai consiste esclusivamente in questo: tenere buona la gente a colpi di consenso narrativo e identificazione emotiva. Come se l’unica necessità fosse quella di riuscire a intrattenere dei poveri coglioni bisognosi di emozioni. È finito il tempo delle candele, delle piscine vuote, di tutte quelle cose che ti colpivano perché non le capivi e non le capiva neanche chi le aveva inventate. Finito per sempre: non tornerà più, inutile lagnarsi».
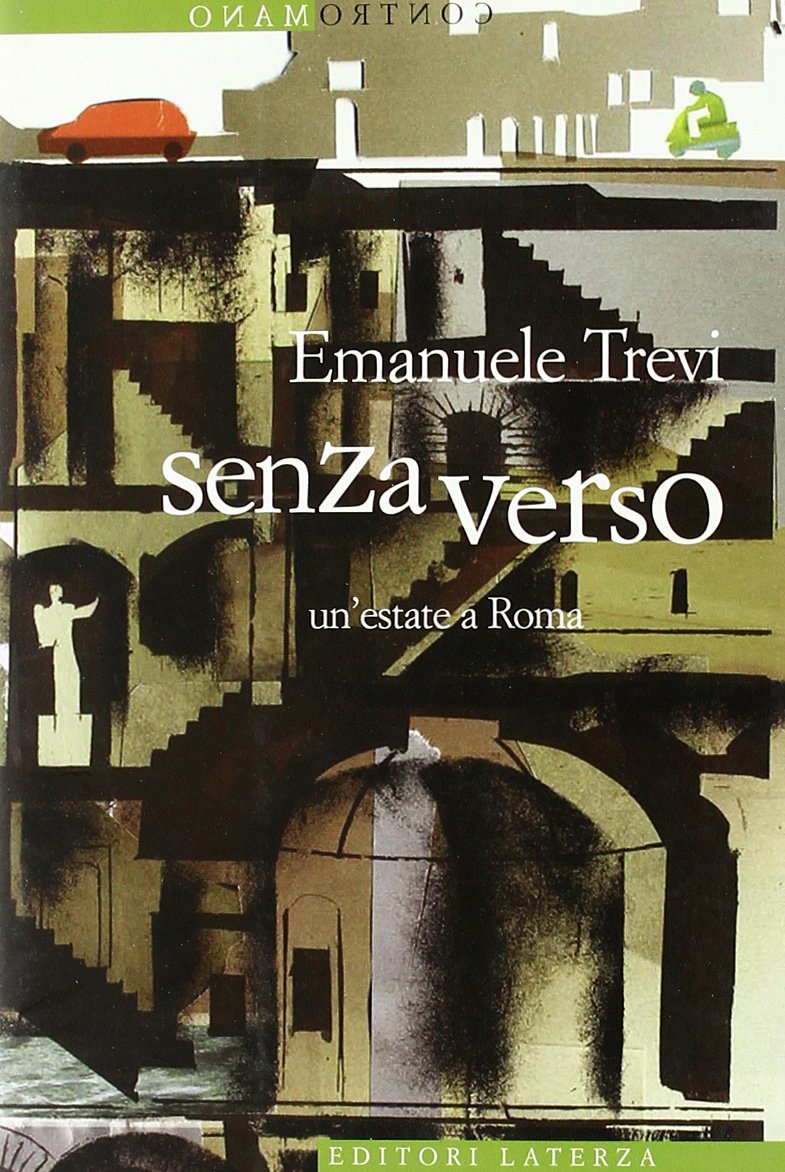
«Senza verso di Emanuele Trevi (Laterza, 2004), è probabilmente uno dei romanzi italiani migliori degli ultimi anni»
Non solo questa pagina ha un che di goffo e sgraziato (forse è colpa mia, che ho in mente le luminose ecfrasi tarkovskiane contenute in Zona di Geoff Dyer e Dias de 1978 di Bolaño), ma credo che esprima il limite di gran parte degli autori italiani della generazione di Trevi: l’anacronismo e il provincialismo, l’incapacità di mettere a tema e di rappresentare la complessità dei nuovi modi con cui gli esseri umani costruiscono e leggono la realtà, continuano, tutto sommato, a fare esperienze. Gli atteggiamenti più comuni degli scrittori italiani nei confronti della contemporaneità sono quelli di una ingenua avversione (la natura di Cognetti, il feticcio della profondità di Trevi) o di una altrettanto ingenua adesione ai suoi aspetti deteriori (penso ai libri di Francesco Piccolo). Sono atteggiamenti privi di qualsiasi ambiguità (o, se ambigui, di un’ambiguità codificata), che banalizzano in maniera eccessiva e semplicistica quelle che sono le peculiarità delle nostre attuali condizioni di vita, le possibilità che i recenti sconvolgimenti (socio-economici, culturali, ecologici, cognitivi) offrono alla letteratura.
Lo so che è una questione datata, ma se sta diventando sempre più difficile anche solo portare a termine un romanzo italiano forse il problema non è tanto dei lettori o del mercato editoriale, quanto della poca capacità che gli scrittori hanno di interessarci, di farci provare, leggendo, sensazioni a cui non sappiamo ancora dare un nome, di farci vedere ciò che fino a un attimo prima era sotto i nostri occhi ma non riuscivamo a scorgere. Tornando a Trevi, il passo citato contiene una contraddizione lampante. Il narratore rimpiange una sorta di autonomia e assolutezza dell’estetico (ma è mai esistita?), in un libro che ne è una vera e propria negazione. Perché la scrittura di Sogni e favole è quasi ovunque sciatta, ingenua, inutilmente enfatica (come dimostra il reiterato ricorso a un linguaggio disfemico: «Non si viene mai a capo di nulla, e prima o poi tutti quelli che sapevano qualcosa muoiono portandosi via i loro stronzissimi segreti», «Parlo della bellezza duratura, non delle cazzate di cui si parla qualche mese fino all’arrivo di nuove cazzate»; «perché siamo al mondo? Che cazzo significa?»; «Dio stesso, stufo di sé e delle sue colpe del cazzo, aveva deciso di chiudere un occhio» etc.); le pagine sono poi infarcite di noterelle pseduo-sapienzali che vorrebbero essere profonde ma sono una sorta di parodia della profondità, l’equivalente letterario di un’iscrizione bimestrale a un corso di hatha yoga: «Tutto ciò che è stato e non sarà mai più è una specie di film, tutto ciò che vediamo in un film assomiglia in maniera sconcertante al disperato desiderio di persistenza che fa dell’anima, come è lecito supporre, la parte più sottile e tenace del nostro corpo»; «Fidati di noi, dicono tutti quei volti […] – fidati di noi che siamo vivi, e come tutti i vivi siamo in balia della corrente, non c’è scampo alle sue insidie, non c’è nessun vero riparo! La vita è troppo breve per non accettare di essere quello che si è!».
Insomma, se in Senza verso e in Qualcosa di scritto ma anche in “Merulana Reloaded” (racconto contenuto nell’antologia La qualità dell’aria), Trevi era riuscito a scrivere delle opere belle e convincenti, capaci di trasformare l’aneddoto privato in storia culturale, la narrativa in critica letteraria, l’ermeneutica in poesia, in Sogni e favole l’alchimia non si ripete. Leggendolo ho provato lo stesso scoramento avvertito, rimanendo in tema, guardando gli ultimi film di Tarkovskij: la sensazione di un autore che si affida in modo incondizionato ai proprio cliché, svuotandoli della propria forza e del proprio impatto tanto emotivo quanto conoscitivo. L’appiattimento culturale di cui si lamenta Trevi, lungi dall’essere una catastrofe antropologica, è, semmai, al limite, la causa del successo e dei consensi che riceverà il suo libro.

Che si vanno ad aggiungere ai 77 che spenderà per completare l'acquisizione. Che comunque potrebbe non completarsi, se l'Antitrust non darà il via libera. E in questo caso, Paramount dovrà pagare altri 7 miliardi di multa.

Le ricerche dicono che il gusto musicale si congela intorno ai 33 anni. Ma dietro c'è un fenomeno più profondo, che riguarda il modo in cui il cervello codifica i ricordi, la costruzione dell'identità e un'industria che monetizza la nostalgia.





