Cosa abbiamo letto a giugno in redazione.
Cosa si nasconde dietro al mito moralista della capanna
In anteprima dal nuovo numero di Urbano, dedicato ai materiali di costruzione, un intervento del filosofo Leonardo Caffo incluso nella sezione dedicata al legno.

Dedicato alla cultura dell’urbanistica, Urbano è un magazine nato in occasione del centenario di Borio Mangiarotti, società di sviluppo immobiliare fondata a Milano nel 1920. I numeri di Urbano sono concepiti come monografie, approfondimenti verticali di un soggetto specifico. Al tempo stesso, da ogni nucleo tematico emergono in filigrana delle questioni trasversali, che sono punti di osservazione possibili sul mondo urbano di oggi e di domani. Il nuovo numero ruota intorno all’importanza dei materiali di costruzione – marmo, legno, mattone, cemento, ceramica –, del tatto e della fisicità di ciò che ci circonda.

L’intervento di Leonardo Caffo che pubblichiamo accompagna l’intervista a Azzurra Muzzonigro all’interno della sezione dedicata al legno. Nel 2020 Andrea Gessner, editore di Nottetempo, commissiona ad Azzurra Muzzonigro, architetto, la realizzazione di una capanna nel bosco, in occasione dell’uscita del libro Quattro Capanne o della semplicità di Leonardo Caffo, filosofo, e più in generale della collana di libri “terra”, attraverso i quali si mette in discussione il rapporto della nostra specie Homo sapiens con il pianeta che ci ospita. Inizialmente pensata per essere luogo di presentazione del libro al Salone di Torino, con l’arrivo della pandemia ha assunto ancora maggior significato.
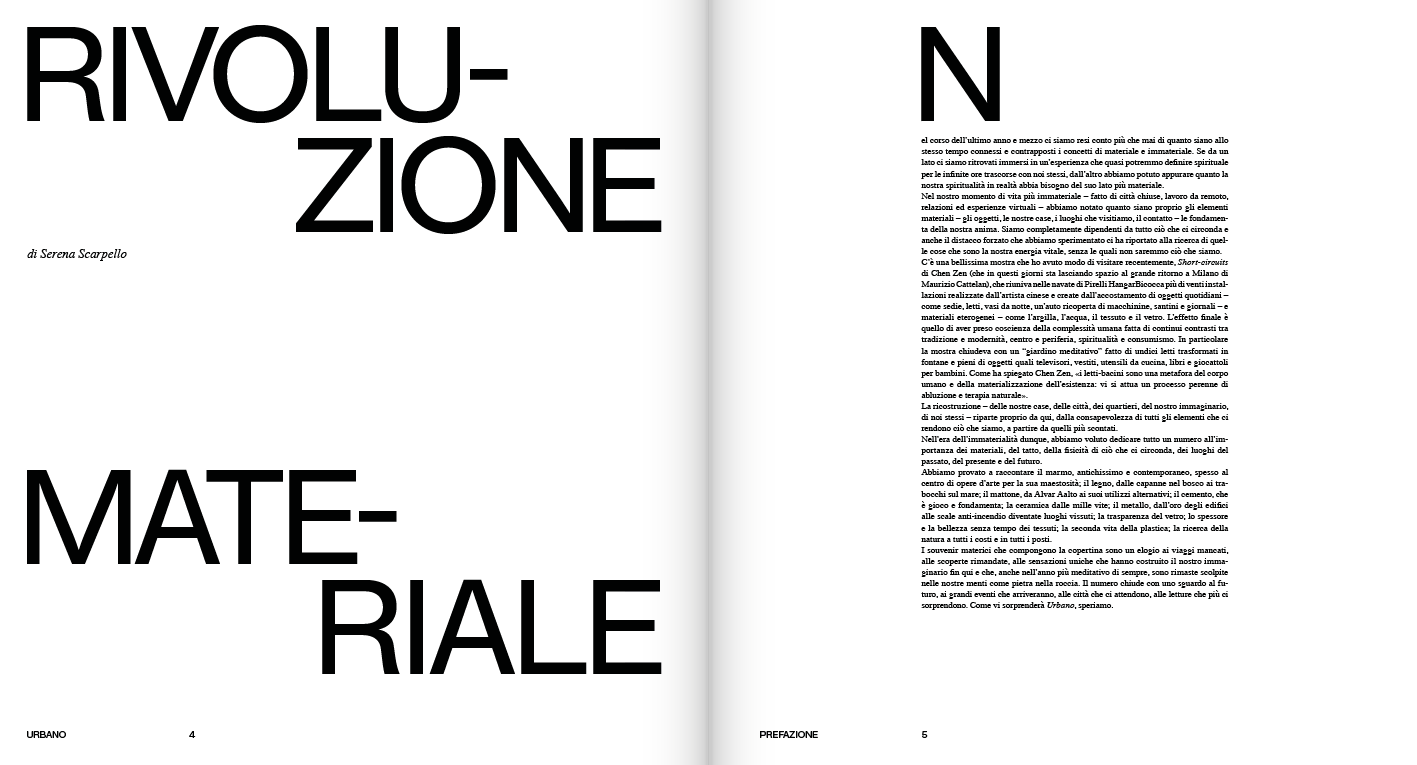
Non bisogna fare di una retorica una soluzione: essa è, appunto, più simbolo che segno. La capanna non è il luogo dove vivremo tutti in futuro, e una capanna più o meno costosa o trendy non ha nulla a che vedere con una via di uscita dall’antropocentrismo o dai problemi climatici. Per chi scrive, la capanna è piuttosto un’immagine spaziale di un ragionamento formale: cosa può un corpo umano, una vita umana, una volta che vengono decostruiti totalmente il modello di vita e la cultura in cui questa esistenza era stata, per così dire, gettata di peso. Nella mia ricerca la capanna, soprattutto in Quattro capanne (Nottetempo, 2020), si è assunta l’onere di fare da crocevia tra pensiero e azione attraverso esempi celebri di capanne occidentali, da quella di Thoreau fino a quella di Wittgenstein. Devo dire, perché non ci siano fraintendimenti, che trovo stucchevole il moralismo dell’abitare alternativo fatto dalle proprie case più o meno borghesi; certo, se per esperimento mentale l’umanità diminuisse drasticamente e costruisse in legno le proprie case come capita in alcune regioni del Sud-Est asiatico, molti problemi sparirebbero… ma stiamo – ipocrisia e tiritera squallida a parte – davvero parlando di questa cosa? Non credo.
Il punto è decostruire la morale dell’abitare non dal lato del moralismo, “tipo viva l’eco-friendly ma poi mangiamoci la porchetta”, ma dal lato dell’esplosione stessa della morale sulla scia del pensiero di Nietzsche: che cos’è una vita umana al di là del bene e del male? Dove vivrebbe? Come produrrebbe o mangerebbe? Che casa abiterebbe questo corpo postumano? Dunque, non me ne vogliate: orti sinergici, merda di vacca per costruire le mura, sono tutte simpatie umoristiche del pensiero occidentale contemporaneo con quel suo insopportabile “si stava (abitava?) bene quando si stava peggio”. Il mio obiettivo, attraverso lo studio filosofico di alcune vite incredibili culminate nella costruzione di una capanna, non era un invito a fare capanne museali (bene anche essere stato interpretato così, ma non è il mio pensiero), ma a immaginare capanne e dunque collassi tra vita e azione in cui davvero il nostro ordinario modo di concepirci come umani viene completamente fatto fuori. Vi sembra che un po’ di orti simpatici o capanne mostrate come animali in uno zoo possano svolgere questa funzione? Ovviamente no. Una delle capanne di cui parlo nel mio libro, mi riferisco a quella di Unabomber, nel momento stesso in cui è stata estirpata dal suo luogo di origine per essere infilata alla fine in un museo, ha smesso di essere una vera capanna, proprio come direbbe John Berger: un leone smette di essere tale all’interno delle gabbie di un giardino zoologico. È il paradosso del contemporaneo di cui parla Giorgio Agamben, quello dell’archeologia delle opere e missioni nate per distruggere il presente ma che dal presente vengono afferrate come oggetto di studio o esibizione… “guardate che bella questa capanna!”.
Ma se l’architettura che analizza questo pensiero radicale ha un minimo di senso che non sia ornamentale, come non lo era la sperduta capanna norvegese del filosofo Ludwig Wittgenstein, è proprio distruggere e avvitare sé stessa fuori dal simbolo e trasformarsi in un segno concreto non di un altro modo di abitare (facciamola finita, vi prego, con Heidegger) ma di vivere questo mondo semplicemente entro una presenza a sé stessi da cui, meraviglie del legno come materiale a parte, siamo ancora davvero lontanissimi.

Il regista inglese torna alla saga che lo ha reso famoso e decide di stravolgerla: il risultato è un film d'autore, horror ma anche politico e sentimentale, che disattende tutte le aspettative e che ha diviso i fan.





