Il 13 luglio del 1985 due miliardi di persone seguirono il più grande evento musicale della storia: oggi che un musical ripercorre la sua avventurosa organizzazione ci rendiamo conto di quanto sarebbe impossibile ripeterlo.
Michael Cunningham, dopo un lungo silenzio
Dopo 10 anni l'autore di Le ore è tornato con Day: lo abbiamo incontrato a Milano e con lui abbiamo parlato di raccontare il Covid in un romanzo, del costo delle case a New York e del suo profilo Instagram fatto tutto di cieli azzurri.

Ritorna in libreria dopo una lunghissima pausa Michael Cunningham, già vincitore del Pulitzer per la narrativa nel 1999 con Le ore. Il suo nuovo libro è Day, pubblicato in Italia da La Nave di Teseo. Cunningham, ormai settantenne e venerato maestro della letteratura americana, affronta un argomento che ha messo in difficoltà molti suoi colleghi: la pandemia. Day racconta di una coppia formata da Dan, ex musicista fallito e padre modello, e Isabel, photo editor di successo, che va per la quarantina e vive con i due figli e Robbie, fratello di Isabel, a Brooklyn. Il libro attacca con la notizia che Robbie deve cercarsi una nuova casa, e descrive le vite dei protagonisti nel corso di tre giorni: il 5 aprile del 2019, del 2020 e del 2021. Incontro Cunningham nel bar di un hotel con vista sulla Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, che lui definisce «un centro commerciale di lusso». Sbarbato, in forma e con un paio di occhiali neri dalla montatura spessa, dimostra una quindicina di anni in meno della sua età. È terrorizzato dalle istruzioni dei suoi amici italiani sull’ora più adatta per ordinare un cappuccino, lo rassicuro che prima di pranzo è sempre tollerato.
ⓢ Bentornato in Italia, passi spesso da queste parti?
Torno quasi ogni anno. Elisabetta Sgarbi è così gentile da inserirmi regolarmente nel programma della Milanesiana. Poi vado spesso in Toscana a visitare la mia amica Beatrice Monti von Rezzori, bellissima, lucidissima, elegantissima, gestisce la miglior residenza al mondo per artisti. È a 25 km a nord di Firenze, in un luogo isolato. Per arrivarci bisogna infilarsi in un sacco di stradine prima di svoltare in un sentiero sterrato dove è quasi impossibile guidare. Beatrice mi ha invitato la prima volta quindici anni fa, e ci sono rimasto per sei mesi. Con me c’erano Zadie Smith e uno scrittore ungherese, Péter Esterhazy. Mi sono trovato così bene che ci torno per una settimana o due ogni estate, c’è sempre una stanzetta per me. Andrò anche domani a salutarla, prima di tornare a casa.
ⓢ È passato un bel po’ dal tuo ultimo romanzo, circa dieci anni. Non c’era mai stato un intervallo così lungo nella tua carriera. Che cosa hai fatto nel frattempo?
Purtroppo non ho niente di drammatico o sconvolgente da raccontarti, mi piacerebbe darti una risposta meno noiosa. Per scrivere proprio il romanzo che hai scelto di scrivere, e non uno qualsiasi, bisogna lasciarlo decantare qualche tempo prima che le cose vadano nel verso giusto. Ho trascorso anni a scrivere un altro romanzo che alla fine è rimasto nel cassetto, ci stavo ancora lavorando quando è arrivato il Covid.
ⓢ Di cosa parlava questo libro?
Una saga famigliare, che inizia negli anni Trenta del ‘900.
ⓢ Perché l’hai abbandonato?
Quando è arrivata la pandemia, mi sono detto che avrei dovuto scriverne. Non potevo ignorare una rivoluzione del genere, e non c’era modo che potessi includerla nel romanzo al quale stavo lavorando. Così l’ho lasciato da parte per iniziare a scrivere Day. Prima che me ne potessi accorgere, sono passati dieci anni.
ⓢ Non hai avuto paura di perdere il tocco magico, o che la gente si dimenticasse di te?
Da un lato mi preoccupo tutto il tempo, è una condizione perenne e credo abbastanza comune. Ma una delle cose più belle di vivere abbastanza a lungo, e di aver pubblicato qualche libro, è che non vado più nel panico come una volta.
ⓢ Beato te.
In passato mi è capitato di iniziare un romanzo perché mi sentivo in dovere di farlo, non la migliore premessa per produrre letteratura memorabile. Ma, ripeto, ormai ho vissuto abbastanza, e scrivo solo quello che credo sia giusto scrivere, senza particolari ansie. Poi, certo, a volte ho ancora paura del giudizio del pubblico. Ma è una forma di panico, diciamo, accettabile.
ⓢ Com’è la tua routine di scrittura?
Tutte le mattine, appena mi sveglio, mi rovescio in testa due tazze di caffè, esco di casa e me ne vado diretto allo studio dove lavoro. Parlo soltanto, e proprio se è necessario, con mio marito. Se mi fermassi a fare due chiacchiere con un negoziante, o se facessi una telefonata, mi lascerei sedurre dal mondo reale. Non posso nemmeno fermarmi al negozietto all’angolo.
ⓢ Nemmeno una colazione veloce in piedi?
Ho caffè a casa, ho caffè nello studio. Poi, certo, se capita di dover scambiare un veloce saluto di cortesia con uno sconosciuto non mi tiro indietro. Ma niente di più. Mi serve il minimo contatto con la vita vera prima di iniziare a scrivere. L’unico segreto della mia routine è passare prima possibile dal mondo del sonno e dei sogni al mondo immaginario che sto inventando io. La realtà, sulla quale ho pochissima influenza, mi distrae.
ⓢ Com’era la tua vita durante il Covid?
Io e mio marito, psicoanalista, ci siamo trasferiti in tutta fretta a Venice Beach. Anche il mio lavoro di insegnante, come il suo, si è spostato online. Trascorrere la stagione peggiore del Covid a Brooklyn non avrebbe avuto senso, così abbiamo affittato una casa sulla spiaggia, dove potevamo andarcene a passeggio anche nei momenti più tragici.
ⓢ Ottima idea. È stato difficile inserire in un romanzo la pandemia, un fenomeno così temporaneo, che ha avuto un inizio e una fine, e che stiamo cercando tutti di dimenticare in fretta?
È stato molto difficile. Come si fa a scrivere un libro che renda giustizia all’enormità di quello che abbiamo appena vissuto, senza perdere di vista i personaggi? Non volevo scrivere un romanzo che parlasse di un virus. Da lì mi è venuta l’idea di dividerlo in tre parti, all’inizio i protagonisti non hanno idea di quello che gli sta per succedere, poi si trovano in mezzo al disastro e infine li incontriamo un anno dopo, quando lo stato di emergenza non è ancora finito, ma si possono iniziare a stendere i primi bilanci.
ⓢ In quanto professore di scrittura creativa, pensi che la rivoluzione digitale abbia cambiato il modo di narrare? Che cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima generazione? Libri più brevi, moltissimi meme?
Da quello che vedo io, sta crescendo un sacco l’interesse per il fantasy e per la fantascienza. Semplificando al massimo, l’idea che un ventenne voglia inventarsi un nuovo mondo o una nuova realtà, in effetti, ha molto senso.
ⓢ Avrei detto più romanzi autobiografici.
Non sarebbe assurdo, ma non è questa la tendenza principale. Ovviamente, leggo un sacco di roba autobiografica. Ma la maggior parte dei testi dei miei studenti sono ambientati in un mondo simile al nostro, dove però accadono cose impossibili.
ⓢ Sai già, quando scrivi, come cresceranno i tuoi personaggi? A me, dopo aver finito Day, è rimasta la curiosità di scoprire come diventeranno Nathan e Violet da adulti.
Non so mai nemmeno come finirà un libro, quando lo inizio. Non sono uno di quegli scrittori che si preparano schemi prima di iniziare, parto a scrivere con una certa idea ma se ho già il finale troppo chiaro in mente mi sembra che i personaggi diventino impiegati della storia, il cui compito è andare diligentemente verso la propria destinazione.
ⓢ Mi sono fatto l’idea che Nathan non farà una bella fine.
Può darsi. Vedi, i finali sono sempre la parte più difficile. Non è mai una vera conclusione, è più tipo: adesso abbandoniamo la storia.
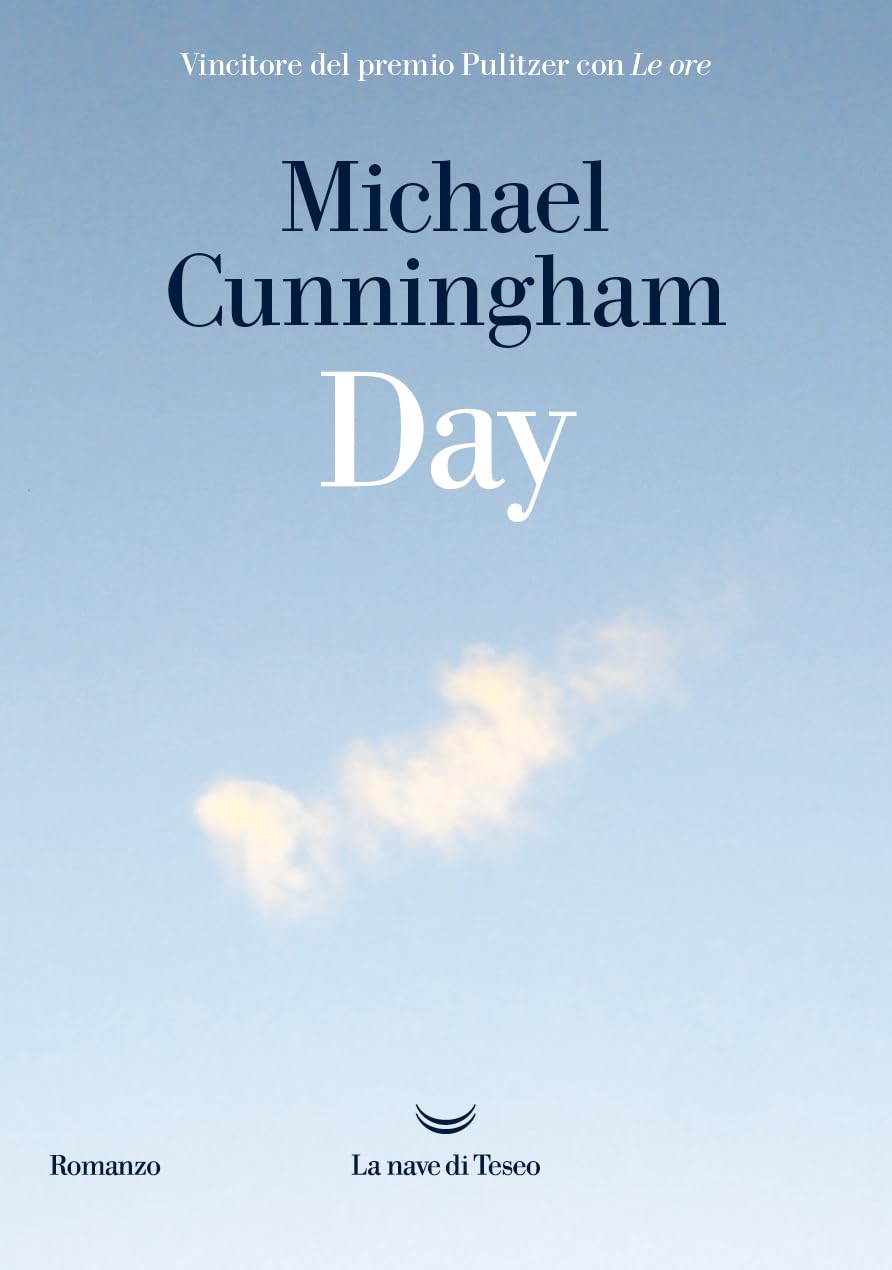
ⓢ Non vorrei sembrare insolente, ma ho letto che la relazione con tuo marito dura da trentacinque anni. Qual è il segreto?
Non sono sicuro che sia un segreto, ma il fatto che Ken sia strepitosamente intelligente, oltre a tutte le altre qualità che possiede, ha aiutato. Ovviamente siamo passati attraverso momenti difficili, litighiamo come tutti, ma non ho mai perso interesse nel chiedermi come ci si sente a essere nei suoi panni. Questo è probabilmente l’elemento che ci ha tenuti insieme tutto questo tempo. Quasi mai mi ritrovo a pensare che vorrei chiudesse la bocca.
ⓢ È il tuo primo lettore?
Ormai Ken mi conosce abbastanza da sapere che non sono del tutto stupido, quindi gli leggo senza vergogna anche le prime bozze. Ha fiducia in me, ma è un lettore spietato. Lui odia tutti i sentimentalismi, taglierebbe tutte le parti dove si parla di emozioni, quindi ho imparato a fare la tara ai suoi commenti, e a non farmi influenzare troppo dalle sue stroncature.
ⓢ Recentemente ho parlato con Lawrence Osborne, che mi raccontava come moltissimi scrittori e giornalisti stiano abbandonando New York, per via dei costi sempre più alti e della scena artistica sempre meno stimolante. Tu che vivi a Brooklyn che ne pensi?
Penso che sia vero. Sta diventando molto più costosa, e quasi sempre questo è sinonimo di meno interessante. Un sacco di persone che conosco si stanno trasferendo a Los Angeles, quattro o cinque amici miei solo nell’ultimo anno. Mi sembra si stia diffondendo questo sentimento: fuck New York, let’s go to LA. Non esattamente un posto economicissimo dove vivere, ma è talmente grande che ci sono ancora case più alla portata. Si avverte un certo fermento creativo a Los Angeles, in questo momento, che una volta era tipico di New York. I movimenti artistici stanno cambiando la natura della città. Gli artisti, a New York, ormai abitano tutti al Queens.
ⓢ Hai fatto il liceo a Pasadena, dove l’Italia ha perso la finale dei mondiali nel 1994. Com’eri tu e com’era il liceo?
In famiglia eravamo regolarmente infelici. Vivevo con mia madre, mio padre e mia sorella. Mi rendo conto che da un vero artista ci si aspetta un’infanzia tragica, ma in realtà ho bei ricordi della scuola. Entrambi i miei genitori avevano origini croate, venivano da famiglie che erano emigrate dall’Europa a Gary, nell’Indiana, per poi sparpagliarsi in giro negli Stati Uniti.
ⓢ A Gary, nell’Indiana? E come mai proprio lì?
Non lo so. Credo sia un posto adatto per persone non abbastanza ambiziose. Il primo gruppo di croati si dev’essere fermato lì per riposare un po’, e altri connazionali poi li hanno raggiunti. I miei genitori non erano veramente americani, ma recitavano il ruolo perfettamente tutto il tempo: mia madre stava a casa a preparare la cena, mio padre tornava la sera dopo un duro giorno di lavoro salutandola con “hey, honey” prima di godersi il suo hamburger. A me sembrava una messinscena.
ⓢ Durante la Summer of Love, nel 1968, avevi sedici anni. Sei entrato nella controcultura?
La mia generazione è diventata grande subito dopo i primi hippy, dopo Woodstock, quando il movimento stava già collassando. Eravamo post-hippy. Prendevamo un sacco di Lsd, non ci vergognavamo a essere affettuosi fra amici, i giovani avevano smesso di atteggiarsi da macho. Erano anni divertenti.
ⓢ Se Day dovesse essere adattato per il cinema, come già successo a due dei tuoi romanzi, chi sceglieresti per i ruoli di Isabel, Dan e Robbie?
Per i ruoli maschili, ci dovrei pensare. Per Isabel, mi piacerebbe una bellezza non ortodossa tipo Charlotte Gainsbourg.
ⓢ Una curiosità: quante copie ha venduto in tutto Le Ore?
Onestamente, non lo so. Un bel po’. A volte mi annoia continuare a doverne parlare, ma poi mi dico di smetterla: di quanti libri si può dire lo stesso a distanza di venticinque anni? Mi ha cambiato la vita.
ⓢ Scusa, ma non posso non chiedertelo: che cosa sta succedendo alla politica americana?
Lo so che da fuori potrebbe non sembrare, ma ti assicuro che noi americani siamo preoccupati quanto, se non di più, tutti gli altri cittadini del mondo. La situazione è… pazzesca. All’inizio non prendevo sul serio la ricandidatura di Trump. Ho cambiato idea. Adesso non si parla d’altro che dell’età di Biden, che è coetaneo di Trump, solo più magro e meno arancione. Forse Biden dovrebbe diventare più arancione. Sembra incredibile, ma non è impossibile che Trump vinca le elezioni. Cambiamo argomento, che è meglio.
ⓢ In Day, Isabel e Robbie creano un finto profilo Instagram con immagini rubate a sconosciuti dal web. È stato difficile dare a un social dignità letteraria?
No, è importante che i romanzi parlino di quello che succede nel momento in cui vengono scritti. Contribuiscono a creare una memoria storica.
ⓢ Il profilo Instagram che ho visto stamattina, dove ci sono decine di foto del cielo, inattivo da un po’, è tuo o di qualcuno che si spaccia per te?
Sono io. Lo usavo soprattutto durante il periodo peggiore della pandemia. Era il mio modo per diversificare i giorni, che mi sembravano tutti uguali. Cercavo di fissare il tempo, questo cielo è così in questo momento, una roba del genere. Poi, all’improvviso, passata l’emergenza sanitaria, ho perso interesse nel mio piccolo progetto social, ma non la passione per le foto del cielo, come si sarà notato dalla copertina scelta per Day.
ⓢ Sei ancora uno dei più grandi appassionati al mondo di Virgina Woolf?
Sì. Per dire il mio livello di fanatismo, alla presentazione di Day ieri sera qua a Milano ho raccontato di avere un tatuaggio a tema Virginia Woolf sul petto, e la gente mi ha preso sul serio.

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.






