Il 13 luglio del 1985 due miliardi di persone seguirono il più grande evento musicale della storia: oggi che un musical ripercorre la sua avventurosa organizzazione ci rendiamo conto di quanto sarebbe impossibile ripeterlo.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a gennaio in redazione.

Herbert Clyde Lewis, Gentiluomo in mare (Adelphi)
A cura di Marco Rossari
Un uomo inciampa in una macchia di olio e cade in mare da un cargo. Per prima cosa pensa a quanto sia imbarazzante la situazione in cui si è messo quando verrà ripescato. «Cadere da una nave era molto peggio che rovesciare il vassoio di una cameriera o calpestare la strascico di una signora. Era ancora più imbarazzante di quello che era capitato a una povera ragazza dell’aristocrazia newyorchese, che aveva incespicato ed era finita giù per tutta una rampa di scale mentre faceva l’entrée nella sera del suo debutto in società». Ma poi, pian piano, Henry Preston Standish si rende conto che i suoi problemi sono ben più preoccupanti dell’imbarazzo, dovendo sperare, mentre galleggia nell’Oceano Pacifico, che prima o poi qualcuno a bordo si accorga della sua assenza e faccia tornare indietro la nave. Piccolo prezioso libro, Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, può essere condensato in queste poche righe, ma è in realtà uno straordinario shottino letterario: poche pagine da mandare giù in un sol sorso e quella sensazione di calore e di piacevole bruciore che dà la letteratura migliore. A cominciare dal suo protagonista, Henry Standish, che come giustamente ricorda nella postfazione Marco Rossari, curatore dell’edizione, ha qualcosa in comune con Bartleby e (aggiungo io) con tutti gli altri eroi mediocri della letteratura novecentesca; gente che sembra fatta più di carta che di carne ma con cui è piuttosto naturale stabilire un’empatia immediata. Ad accrescere il fascino del libro, sia la storia travagliata del suo autore – giornalista, scrittore, sceneggiatore sempre sul punto di arrivare al successo, ma in definitiva fallito e marchiato dal destino – sia quella editoriale della novella, uscita con scarsi riscontri nel 1937, scomparsa e poi ripescata a partire dagli anni Dieci di questo secolo, prima in Argentina, poi in Olanda e in Inghilterra, con un successo notevole e quasi beffardo. (Cristiano de Majo)

Ocean Vuong, Il tempo è una madre (Guanda)
Traduzione di Damiani Abeni e Moira Agan
«Lo so. Lo so che la stanza in cui hai pianto si chiama America» scrive Ocean Vuong in “Beautifil Short Loser”, una delle poesie della sua raccolta Il tempo è una madre (Guanda), che riprende tutti i temi che hanno reso l’autore di origine vietnamita uno dei punti di riferimento della nuova poesia americana. Ocean Vuong parla di morte, quella della madre a cui ha dedicato Brevemente risplendiamo sulla terra e che sempre ritorna nella sua produzione, come madre ispiratrice e come fantasma infestante, ma soprattutto parla di vita, la sua, quella della sua famiglia, naturale e acquisita, quella di chi come lui ha passato molti anni a chiedersi chi è, cosa è, cosa significano le sue esperienze. Nelle sue poesie, spesso brevi, altre volte veri e propri racconti in versi che sembrano a tutti gli effetti sceneggiature di pièce teatrali, quelle esperienze ritornano, anch’esse fantasmi di cose che avrebbero potuto essere e non sono state, di errori commessi o evitati per un soffio, di identità costruite e altre diluitesi nel tempo che dà il titolo al libro. «Una volta ero un frocio e ora sono una casella da spuntare», inizia Vuong in “Not even”, «Te lo giuro, ero qui. Ho provato delle cose che hanno reso la morte tanto grande da renderla indistinguibile dall’aria, e ho continuato dentro di lei a distruggere come il vento in una tempesta», continua, in uno dei componimenti più belli e imprendibili della raccolta, che accompagna il lettore nei suoi pensieri più intimi, i più difficili da confessare – «Una volta ero frocio, adesso sono un figo. Ah» – e quelli che più toccano i temi che oggi ci interessano profondamente: un ragazzo di terza generazione, un figlio di immigrati, un rifugiato di guerra, un esule il cui dolore, il cui trauma, diventa il biglietto d’oro per l’accettazione in una società che non potrà capirlo mai fino in fondo. Una Heimat che non esiste e un nuovo mondo in cui non ci si incastra mai a perfezione: Ocean Vuong le racconta meglio di tutti, perché sa che il tempo è madre ma è anche stronzo, il più delle volte. (Silvia Schirinzi)

Karin Boye, Kallocaina (Iperborea)
Traduzione di Barbara Alinei
Karin Boye è nata nel 1900 ed è morta suicida nel 1941. Kallocaina esce pochi mesi prima, nel 1940, ed è ancora oggi il suo romanzo più noto fuori dai confini della Svezia. Questa, uscita a gennaio per Iperborea, non è una prima edizione italiana, perché sempre Iperborea lo pubblicò nel 1993. Kallocaina è una distopia in divenire: non è già perfetta quando apriamo il romanzo, ma lo diventa mano a mano che si procede. L’evoluzione totalitaria è merito proprio di Leo Kall, protagonista e inventore della Kallocaina, un siero che costringe il paziente (anzi: l’imputato) a dire tutta la verità per alcuni minuti. Kall, con la moglie, i figli, e tutti i protagonisti del libro, lavora come chimico nello Stato Mondiale, l’entità suprema che sfrutta subito l’invenzione per “anticipare” i crimini dei cittadini, in uno scenario alla Minority Report. Lui, d’altra parte, è felice di donarla al regime, essendo un entusiasta ingranaggio della grande macchina collettiva. Non ci sono buoni e non c’è nessun lieto fine, in Kallocaina, perché anche Kall, l’eroico inventore, scrive ora da un luogo di prigionia: è una distopia, quella di Boye, che non promette rivoluzioni, ma anzi evolve nella sua stretta totalitaria pagina dopo pagina. I protagonisti, d’altra parte, da Kall al capo della polizia, dagli studenti del laboratorio di chimica presieduto da Kall fino ai ministri della propaganda, non sono né terribilmente cattivi né terribilmente alienati: per questo ci si immedesima in loro, e la previsione riecheggia inquietante dentro di noi. Paragonato a 1984 di Orwell, il mondo di Kallocaina in realtà è meno allegorico e più spaventosamente realistico: per questo ricorda in realtà sia l’Urss delle purghe staliniane descritta da Arthur Koestler in Buio a mezzogiorno, pubblicato non a caso proprio nel 1940, sia il capitalismo della sorveglianza in cui ci stiamo immergendo oggi. (Davide Coppo)

Mohsin Hamid, L’ultimo uomo bianco (Einaudi)
Traduzione di Norman Gobetti
«Un mattino Anders, un uomo bianco, si svegliò e scoprì di essere diventato di un innegabile marrone scuro». Mohsin Amid ha voluto scrivere la sua versione delle Metamorfosi di Kafka, forse la versione delle Metamoforsi di Kafka che meglio si adatta ai nostri tempi: cosa c’è di più spaventoso, oggi, per un uomo perfettamente bianco che svegliarsi un mattino e scoprire di essere diventato di un innegabile marrone scuro? Il terrore di Anders, il protagonista di L’ultimo uomo bianco, sta tutto in quell’aggettivo: innegabile. C’è un momento della storia in cui Anders se ne sta impalato davanti allo specchio, alla ricerca disperata di indizi che smentiscano la sua trasformazione, una sorta di Gengè Mosca al contrario. Indizi che smentiscano non ne trova: la trasformazione è proprio innegabile. Anders però è un uomo dei nostri tempi, non può e non vuole definirsi malato: il colore della pelle non è una condizione patologica. Però, come la trasformazione in lui è innegabile, è innegabile anche la consequenziale trasformazione del mondo dentro e intorno a lui, proprio come se una malattia lo avesse colpito all’improvviso. Il primo istinto di Anders bianco è quello di «ammazzare l’uomo di colore che gli si parava davanti lì in casa sua», cioè Anders nero. Disperato, esce di casa alla ricerca di una spiegazione – cura? – e trova un mondo disinteressato alla stessa: il problema riguarda solo alcuni (per il momento, la situazione degenererà con il diffondersi della trasformazione), tutto sommato pochi, e quindi perché preoccuparsene, un punto di vista che Anders il bianco ha adottato troppo spesso per condannare e dimenticare. Come in The Leftovers di Perrotta o in Cecità di Saramago, il mistero non viene mai rivelato, restano solo le conseguenze dello stesso. Che, nel caso di Anders, stanno nella scoperta della coesistenza di mondi diversi dove lui prima pensava esistesse soltanto il suo. Un mondo in cui il personal trainer gli dice che si sarebbe ammazzato se la stessa cosa fosse successa a lui. Un mondo in cui la madre ipercomplottista della sua compagna Oona trova in lui la conferma delle più bislacche teorie di sostituzione etnica (dopo aver esplicitato, ovviamente, tutto il suo imbarazzo per il fatto che ora sua figlia frequenti un nero). Un mondo in cui esistono il privilegio e il suo colore, e adesso anche la più spaventosa delle prospettive, l’incubo finale per gli Anders di tutto il mondo: perdere l’uno e (quindi) l’altro. (Francesco Gerardi)
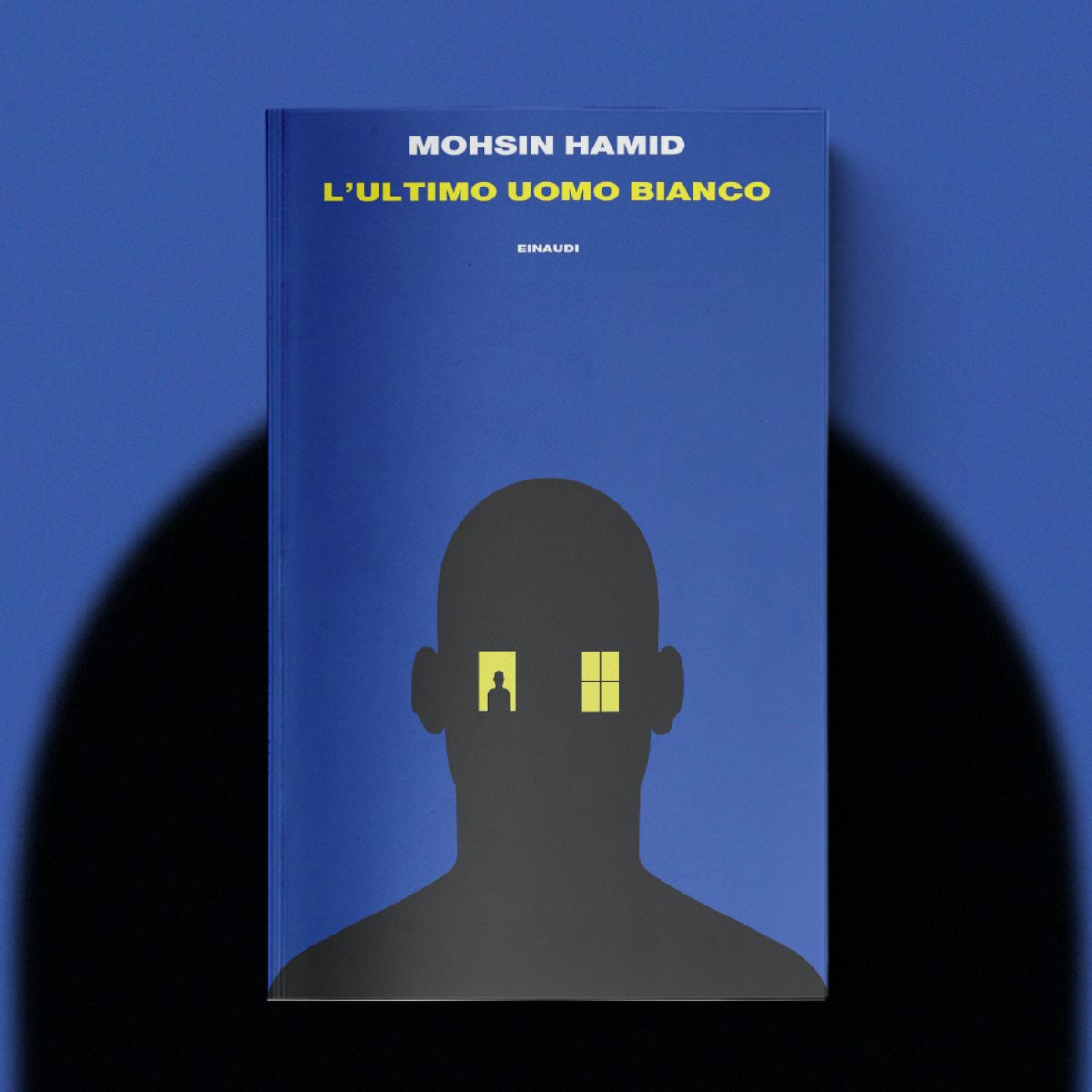
Murata Sayaka, La cerimonia della vita (E/O)
Traduzione di Gianluca Coci
In Italia (ma non solo) Murata Sayaka è conosciuta come l’autrice del bestseller del 2016 La ragazza del convenience store, pubblicato da E/O nel 2018. In realtà è una scrittrice molto prolifica: prima di raggiungere la fama internazionale con la storia di una trentaseienne disadattata, solitaria e priva di ambizioni, aveva già scritto e pubblicato dieci romanzi. Questa raccolta (in libreria dal 22 febbraio) è il suo lavoro più recente, uscito in Giappone nel 2019. Nei dodici racconti che la compongono, ritroviamo i personaggi emarginati e strani tipici di Sayaka e di altre sue colleghe scrittrici come Mieko Kawakami (a gennaio è arrivato da noi anche il suo splendido Gli amanti della notte, ne parlavamo qui). Sayaka, Kawakami, Matsudo Aoko (sua la raccolta Nel paese delle donne selvagge), fanno parte di una generazione di autrici che sta cambiando il mondo letterario nipponico, raccontando storie di donne artistiche, autarchiche e fuori dalla norma (come scriveva Arianna Bonazzi in questo articolo). La cerimonia della vita è una collezione di frammenti di esistenze apparentemente banali che invece sono dei veri e propri racconti dell’orrore. “Materiale di prima qualità”, ad esempio, è ambientato in un tempo indefinito in cui è perfettamente normale utilizzare i corpi dei morti per realizzare vestiti (ad esempio maglioni fatti di capelli), gioielli (si usano i denti) e mobili (costruiti con le ossa). I protagonisti di questo racconto sono due fidanzati. Lei, Nana, è “normale”, nel senso che, come tutti gli esseri umani, dà per scontato che utilizzare i corpi dei morti in questo modo sia ok, mentre il suo promesso sposo Naoki è “strano”, cioè disgustato da questa pratica, tanto che lei non può capire come una persona così gentile possa essere così «crudele da dire che dovremmo scartare l’intero corpo anche se così tante parti possono essere riutilizzate». Secondo Dwight Garner del New York Times il difetto dei racconti di questa raccolta è che sono un po’ moraleggianti, come se fossero degli esercizi un po’ freddi volti a dimostrare una tesi, tanto che il migliore, secondo lui, è “Body Magic”, più caldo e sfuggente degli altri, in cui una ragazzina vergine ascolta rapita il racconto della prima volta della sua amica. Forse molti lettori saranno d’accordo con lui, ma ci sarà anche chi, come me, si divertirà moltissimo a immaginare le situazioni costruite da Sayaka con tanta precisione che sembra di vederle e, soprattutto, ritrovarsi a elencare i dettagli della realtà che ci fanno capire che anche noi stiamo vivendo in un mondo horror, ma tendiamo ad andare avanti come se non ce ne rendessimo conto. (Clara Mazzoleni)


Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.






