Nel primo teaser del film Tom Holland e gli altri attori utilizzano una marcata cadenza americana, particolare che ha indispettito molti fan.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a settembre in redazione.
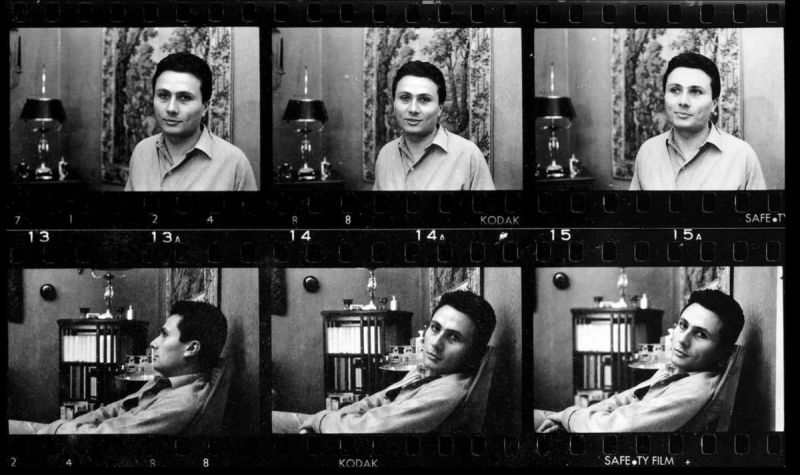
Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You (Faber & Faber)
C’è chi la paragona a Proust e chi non pensa che quello che scrive sia letteratura: Sally Rooney è in grado di suscitare dibattiti in cui i duellanti si ritrovano a sostenere posizioni totalmente opposte, che poi è proprio lo “sport” che lei stessa praticava e in cui eccelleva (campionessa europea) prima di diventare una scrittrice famosa, esperienza raccontata in un articolo che attirò l’attenzione di un agente letterario e tutto il resto è storia.
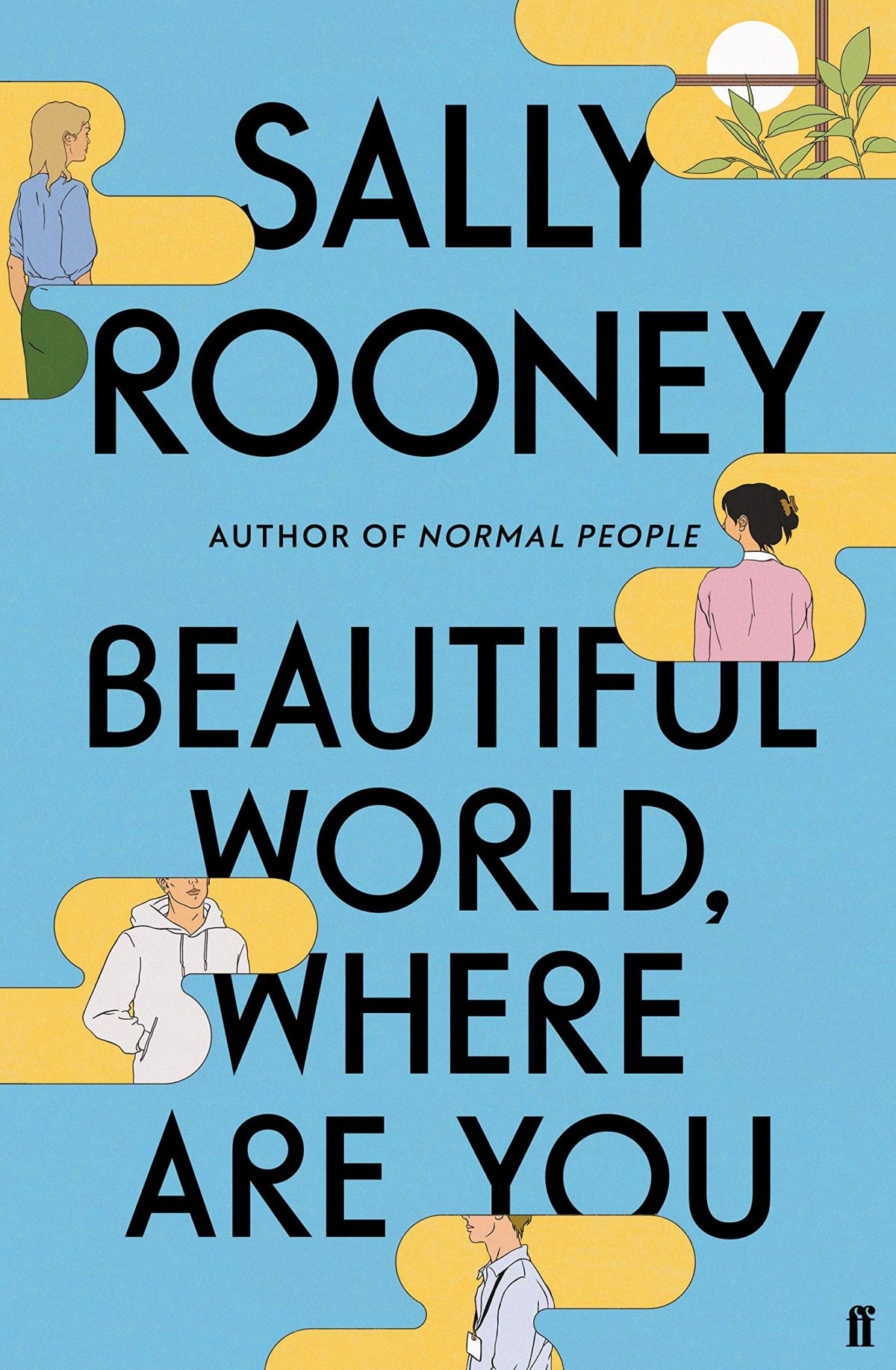 Al solito mix di ingredienti rooneyani – ottimo sesso, dialoghi flirtanti, personaggi di rara intelligenza magri e tristi e intensi, un pizzico di disturbi psichiatrici, un tocco di lotta di classe, amicizie e amori on/off ma allo stesso tempo eterni – si aggiunge per la prima volta un personaggio apparentemente sovrapponibile a lei (Alice, scrittrice di successo), che regala alla morbosità della lettura una spinta in più, e cioè il desiderio di conoscere più profondamente la mente dietro a tutto questo. Cosa che in effetti accade, ma non perché c’è un personaggio simile all’autrice. Il fatto è che a differenza dei romanzi precedenti, velocissimi e ossessivi, Beautiful World Where Are You (in Italia uscirà all’inizio del 2022, Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli) appare più forzato, lento e macchinoso. Le mail che si scambiano le due protagoniste sono infarcite di (illuminanti) riflessioni sui massimi sistemi, il che è perfettamente plausibile – non dubito che Rooney mandi mail del genere alle sue amiche – ma sembra anche un modo per dire ai critici: ecco qui, vedete, non è solo sesso e body language, io sono marxista e rifletto sulle cose del mondo. Il continuo spostarsi del punto di vista dalla prima alla terza persona crea situazioni interessanti (scene viste sia da dentro che da fuori il personaggio) che però raffreddano la lettura. Rispetto agli altri due romanzi, gli ingranaggi della storia sono più ingombranti e quindi più visibili: un’occasione preziosa per cercare di carpire, ancora una volta, e forse ancora invano, i segreti di questa scrittrice pazzesca. (Clara Mazzoleni)
Al solito mix di ingredienti rooneyani – ottimo sesso, dialoghi flirtanti, personaggi di rara intelligenza magri e tristi e intensi, un pizzico di disturbi psichiatrici, un tocco di lotta di classe, amicizie e amori on/off ma allo stesso tempo eterni – si aggiunge per la prima volta un personaggio apparentemente sovrapponibile a lei (Alice, scrittrice di successo), che regala alla morbosità della lettura una spinta in più, e cioè il desiderio di conoscere più profondamente la mente dietro a tutto questo. Cosa che in effetti accade, ma non perché c’è un personaggio simile all’autrice. Il fatto è che a differenza dei romanzi precedenti, velocissimi e ossessivi, Beautiful World Where Are You (in Italia uscirà all’inizio del 2022, Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli) appare più forzato, lento e macchinoso. Le mail che si scambiano le due protagoniste sono infarcite di (illuminanti) riflessioni sui massimi sistemi, il che è perfettamente plausibile – non dubito che Rooney mandi mail del genere alle sue amiche – ma sembra anche un modo per dire ai critici: ecco qui, vedete, non è solo sesso e body language, io sono marxista e rifletto sulle cose del mondo. Il continuo spostarsi del punto di vista dalla prima alla terza persona crea situazioni interessanti (scene viste sia da dentro che da fuori il personaggio) che però raffreddano la lettura. Rispetto agli altri due romanzi, gli ingranaggi della storia sono più ingombranti e quindi più visibili: un’occasione preziosa per cercare di carpire, ancora una volta, e forse ancora invano, i segreti di questa scrittrice pazzesca. (Clara Mazzoleni)
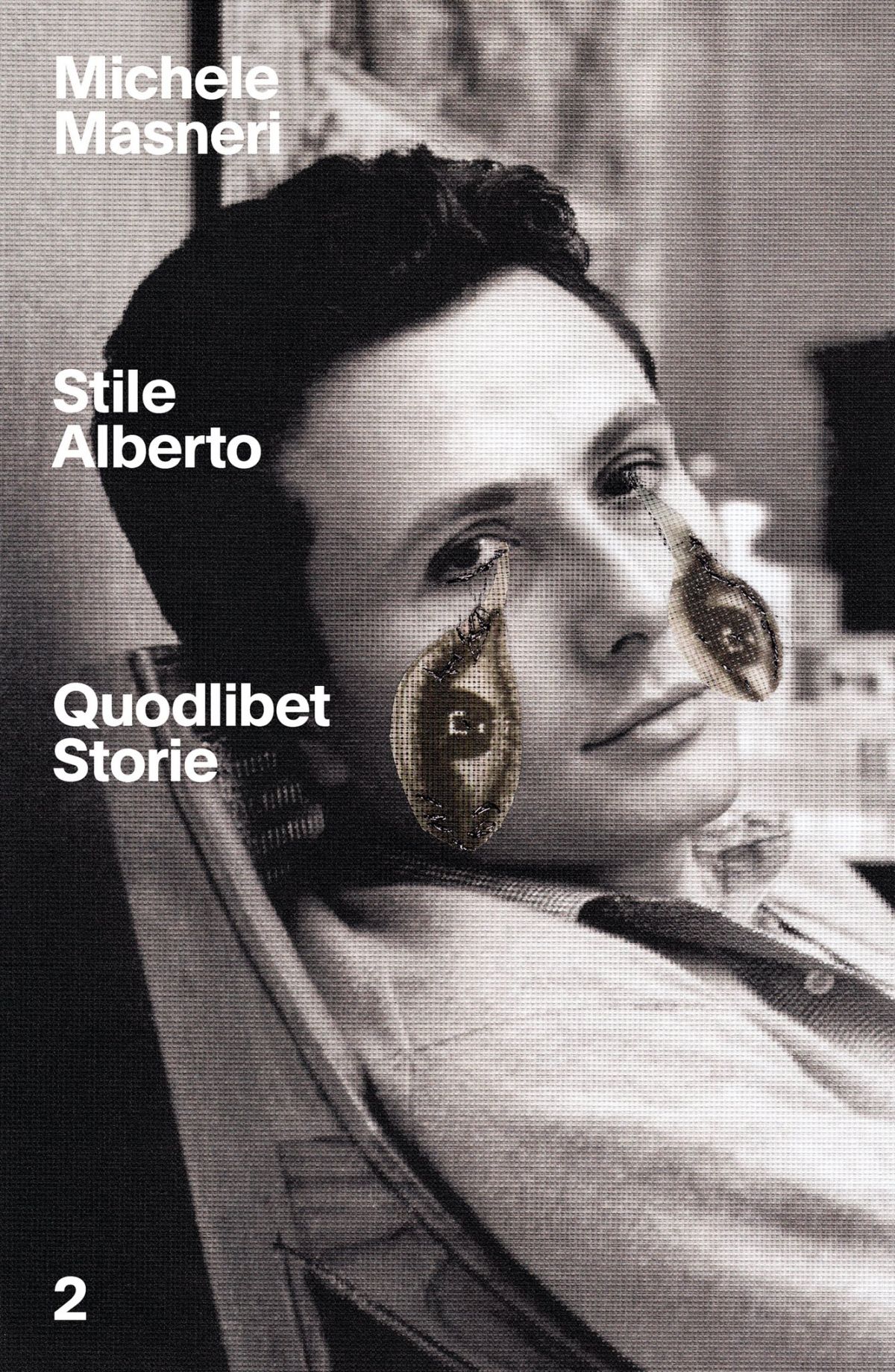 Michele Masneri, Stile Alberto (Quodlibet)
Michele Masneri, Stile Alberto (Quodlibet)
Non esisterebbe la letteratura senza l’influenza (Bloom docet) e, fateci caso, gli scrittori che dichiarano la propria urgenza come principio regolatore e nessuno modell ispiratore sono anche quelli che scrivono le robe peggiori. Ma, generalmente, un grande scrittore è anche uno che nel tentativo di imitare un modello forte è riuscito a superarlo. E, sempre generalmente, chi resta alla fase dell’epigonismo (la fase anale dell’apprendistato letterario) non diventa un bravo scrittore. Generalmente appunto, perché vi sono anche casi in cui l’imitazione di un modello, insistita, consapevole, si afferma come uno stile completamente personale e riconoscibile. È il caso di Michele Masneri che da arbasiniano dichiarato è riuscito a diventare masneriano. E che in questo piacevolissimo librino, uscito per Quodlibet, con copertina site specific di Francesco Vezzoli, chiude il cerchio di questo suo rapporto, apparentemente poco sofferto e nemmeno tanto edipico, con il suo padre letterario. Un “corpo a corpo”, lo definirebbe il critico, ricco di storie bellissime dell’Italia culturale anni Cinquanta e Sessanta (bellissime per esempio sono le pagine che raccontano il rapporto di AA con Pasolini), così come di tragicomici aneddoti personali (bellissimo è anche, per esempio, il racconto del rapporto tra i due: in punta di piedi, fugace, a volte formale, tra un imbarazzante invito a casa e un viaggio in macchina iniziatico). Leggerlo è come entrare in uno di questi salotti super-borghesi, se non addirittura principesseschi, frequentati dall’autore di Fratelli d’Italia (e un po’ anche da Masneri): si resta in silenzio e si ascolta ammirati e divertiti questo gossip a forma di letteratura. (Cristiano de Majo)
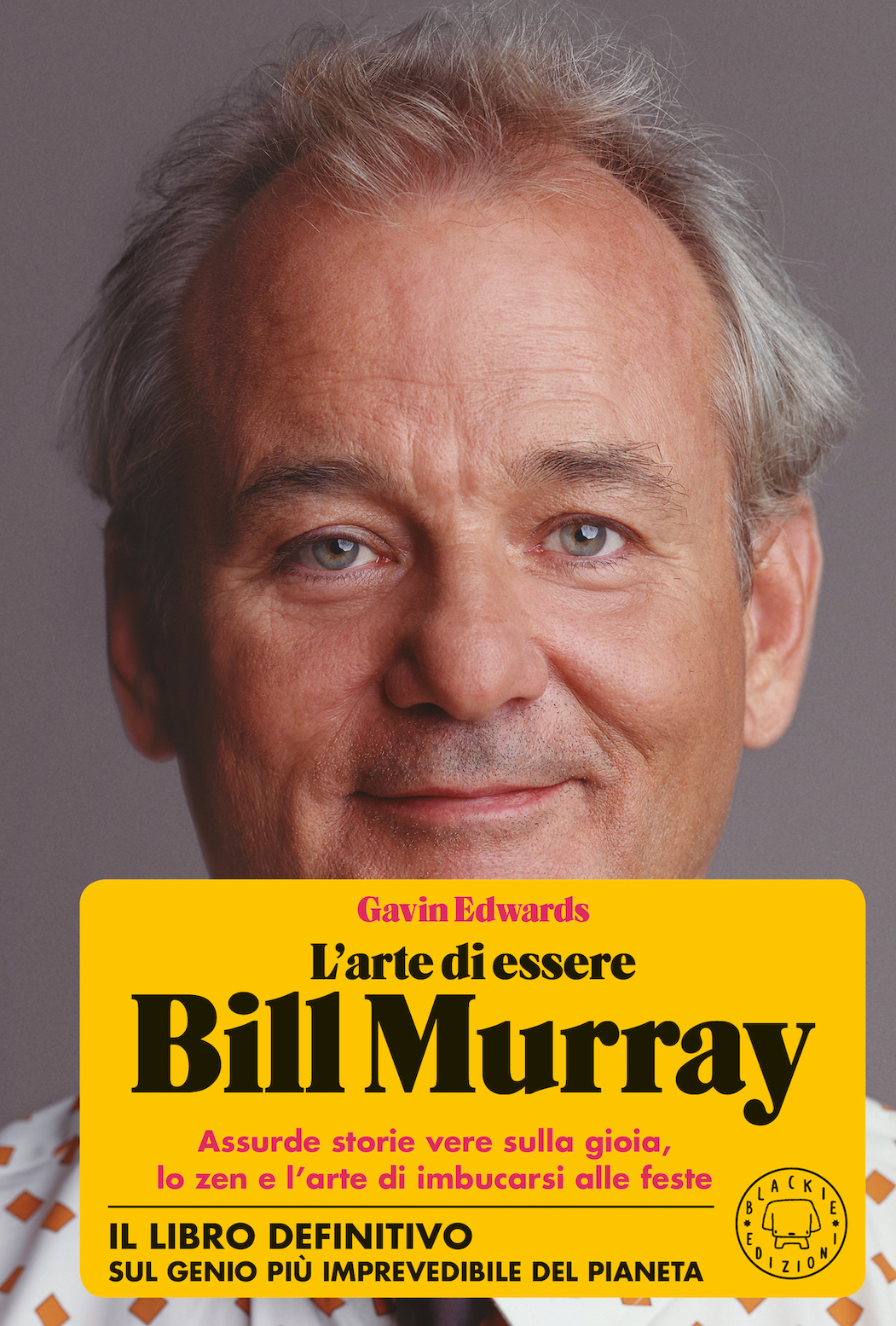 Gavin Edwards, L’arte di essere Bill Murray (Blackie Edizioni)
Gavin Edwards, L’arte di essere Bill Murray (Blackie Edizioni)
Trad. di Michele Martino
Nonostante Bill Murray adori la poesia e da ragazzo abbia scritto qualche verso, è stato abbastanza saggio da non condividerli con il resto del mondo. È solo una delle tante storie che riguardano l’attore e che compongono il libro di Gavin Edwards, L’arte di essere Bill Murray, una raccolta di testimonianze di amici e conoscenti di Murray che Edwards ha organizzato in una lista di 10 principi per imparare a vivere come l’antidivo, tra la passione per imbucarsi alle feste e l’importanza di fermarsi ogni tanto a guardare il muro senza fare niente. Da spettatori (e ora lettori), amiamo Bill Murray anche se forse non siamo mai riusciti a indagarne le ragioni. Con molta probabilità lo abbiamo scoperto in Ghostbusters, abbiamo empatizzato con lui in Ricomincio da capo, per poi eleggerlo a modello di vita quando l’abbiamo visto seduto al bancone del bar nel lussuoso albergo di Tokyo mentre non capiva che direzione stesse prendendo la sua vita (siamo tutti Lost in Translation). È la stessa domanda che si fa Edwards più volte – perché sentiamo Murray così tanto vicino? – e a cui prova a rispondere raccontando la sua vita, i suoi film e interpellando Murray stesso: l’infanzia complicata, cacciato dal college, tanti lavori, il celebre Saturday Night Live come rampa di lancio, il ruolo di spalla a Hollywood e poi l’approdo ai cult (Ed Wood, I Tenebaum, Il treno per il Darjeeling, Moonrise Kingdom). La risposta emerge già a metà libro: grazie a Murray e ai suoi personaggi sempre malinconici, punti d’incontro miracolosi tra amarezza e ironia, sappiamo che nessun Giorno della Marmotta alla fine dura per sempre, proprio come un temporale. Lo dice anche Edwards in uno dei “racconti di cantina” ambientati nei bar, quando «bagnato fradicio dalla testa ai piedi, Bill Murray entrò nella vineria sfuggendo a una pioggia apocalittica con indosso un paio di jeans, un impermeabile e un casco originale del famoso stuntman Evel Knievel. Lo aveva appena comprato a un’asta». Faceva ridere, ma era comunque un riparo. (Corinne Corci)
 Matteo De Giuli, Nicolò Porcelluzzi, Medusa (Not)
Matteo De Giuli, Nicolò Porcelluzzi, Medusa (Not)
È così difficile definire Medusa, la trasformazione da newsletter a libro dell’appuntamento bisettimanale di De Giuli e Porcelluzzi, che ammetto che all’inizio il lettore, cioè io, ne può anche essere disorientato. Ci si potrebbe chiedere, nelle prime pagine: cos’è questo oggetto? Il fatto è che Medusa è, a proposito di modi di dire introiettati e nati da cose che hanno trainato il cambiamento climatico dell’ultimo secolo, un diesel. Si parte dalla pandemia, perché dalla pandemia non si può che partire se si parla di antropocene e ricadute più che concrete, anzi catastrofiche, di alcune tipicità dell’antropocene, e poi come un radar si allarga lo spettro. Ecco: Medusa è un radar, ogni bip un capitolo, ogni oggetto incontrato una disamina. Medusa è una bussola per orientarsi nella fine del mondo per come lo conosciamo, che non solo è inevitabile ma è qui, ci stiamo camminando dentro – è a quello che servono le bussole, no? Medusa è un oggetto ambizioso che fa incontrare, come scrive Veronica Raimo sulla quarta di copertina, la letteratura scientifica alla letteratura punto e basta, perché anche da questa distanza e questo scollamento sono nati i disastri in cui annaspiamo. E infatti non si parla di clima e apocalissi e basta: si parla del perché non le abbiamo sapute raccontare fino a ora, di cosa non va nella nostra (nostra di umanità) percezione della fine, di cos’è l’uomo in rapporto al resto del regno animale, di colonizzazioni antiche e di nuovi problemi che sorgono con ogni possibile soluzione. Va a finire che Medusa è anche un uragano, che ci finisci dentro e non ne esci più, incuriosito dal meccanismo narrativo sebaldiano applicato alla scienza, e affascinato e insieme terrorizzato dagli orizzonti che descrive, che se alzi gli occhi sono tutti qui intorno. (Davide Coppo)
 Billy-Ray Belcourt, Storia del mio breve corpo (Black Coffee Edizioni)
Billy-Ray Belcourt, Storia del mio breve corpo (Black Coffee Edizioni)
Trad. di Sara Reggiani
All’inizio del suo libro, Billy-Ray Belcourt scrive un capitolo-dedica alla sua nôhkom, parola che in lingua Cree indica la nonna, depositaria della storia di famiglia ma anche punto di riferimento nella vita del giovane autore, queer e nativo americano. O meglio, NDN, acronimo di “not dead Native”, nativo non ancora morto, un’espressione che, nell’epoca delle sigle che distinguono le persone e indicano la loro appartenenza a un determinato gruppo, racchiude con una certa ironia la condizione dei nativi, i veri “americani” che sono stati cancellati sistematicamente affinché l’America come la conosciamo oggi prendesse forma. Quello di Belcourt, poeta, è un libro che affronta la questione dell’identità in tutte le sue sfumature, sia rispetto al mondo che hanno costruito i “colonizzatori” – “Hey Colonizer” è anche un hashtag virale su TikTok, promosso dai tanti account, come quello di Lance Tsosie, che parlano di com’è essere nativi oggi negli Stati Uniti – sia rispetto alla sua stessa comunità, all’interno della quale gli effetti della cristianizzazione hanno complicato di molto le cose per le persone queer. Così Storia breve del mio corpo è un viaggio alla ricerca delle proprie radici ma soprattutto del proprio futuro, tra comunicazioni interrotte e incontri Grindr, feticismi e nuove forme di colonialismo, nel tentativo di ridare corporeità a un’esistenza, personale e collettiva, che la società ha spezzato fino a renderla fantasma. (Silvia Schirinzi)







