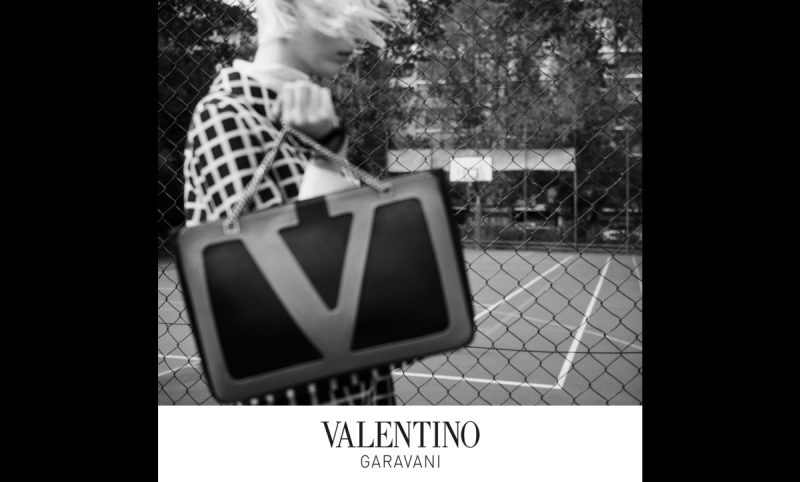L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
L’orrenda storia di Abercrombie & Fitch
La racconta White Hot, il documentario disponibile dal 19 aprile su Netflix, che esplora le tante controversie del marchio di cui i Millennial si vergognano di più.

Aprendo il sito di Abercrombie & Fitch oggi, si ritroverà un video di promozione della nuova linea Active (la declinazione sportswear del marchio) in cui immediatamente si vedono un ragazzo e una ragazza di origine asiatica orientale, un ragazzo nero, una ragazza plus-size. Insomma, una campagna perfettamente in linea con i nuovi canoni del marketing che negli ultimi anni hanno riformulato l’industria della moda e tutto quello che le gravita intorno: inclusione, diversità, accettazione di sé. Niente di particolarmente innovativo, se non fosse che ogni Millennial che si rispetti – il pre adolescente all’inizio degli anni Duemila, che assiste oggi al ritorno di quell’estetica che lo ha traumatizzato da piccolo – ha un ricordo decisamente diverso di cos’era Abercrombie & Fitch. Potranno essere i negozi bui con la musica sparata a tutto volume in cui veniva diffusa la nauseabonda fragranza del brand, gli stessi in cui si veniva accolti da ragazzi a petto nudo e ragazze in minigonna, tutti ugualmente belli, magri, e bianchi. Oppure potranno essere le campagne pubblicitarie di cui quei negozi erano lo specchio fedelissimo: le più significative le aveva scattate Bruce Weber ed erano il sunto perfetto dell’estetica omoerotica del grande fotografo americano, ora caduto in disgrazia. Abercrombie & Fitch era tutto tranne che inclusivo, e non aveva problemi ad ammetterlo.
White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch, il documentario diretto da Alison Klayman disponibile su Netflix dal 19 aprile, racconta la storia del marchio così come l’ha immaginato e portato al successo dalla fine degli anni Novanta il Ceo Mike Jeffries e, cosa ancora più interessante, le tante ragioni per cui l’interpretazione del concetto di “all American” che proponeva ci risulta oggi incredibilmente vecchia, ma soprattutto razzista. Il documentario si avvale dei contributi di molti ex dipendenti (all’appello mancano ahimè Jeffries e Weber, com’era prevedibile) ed esperti di moda, tra tutti la critica e giornalista di moda Robin Givhan, ex firma del Washington Post e già vincitrice del Pulitzer. Quando Jeffries arriva da Abercrombie nel 1992, tramite nientemeno che Leslie Wexner, il magnate del retail dietro a Bath & Body Works e Victoria’s Secret tra gli altri (lo stesso che è finito nei guai per i suoi legami con Jeffrey Epstein), ha la fortunata intuizione di trasformare un marchio che nasceva nel 1892 per vestire i ricchi nei loro passatempi da ricchi – con tanto di look per i safari – in un brand che unisse «l’estetica sexy di Calvin Klein e quella Total Americana di Ralph Lauren», come sintetizza Givhan. Una versione scadente di entrambi quei mondi ma decisamente ben confezionata, soprattutto grazie alle inedite qualità di “micro-managing” dello stesso Jeffries, personaggio tanto misterioso (della sua vita privata si è sempre saputo pochissimo) quanto macchiettistico, Ceo ossessivo e malamente botoxato.
Non sembrino velleitarie le accuse di razzismo, ché appellarsi al pensiero unico o al politicamente corretto (come spesso succede) qui non attacca. A cominciare dalla celebre intervista del 2006, che doveva essere un articolo per il New York Times ma che poi finisce su Salon perché l’azienda si era tirata indietro, in cui Jeffries diceva senza giri di parole: «Inseguiamo i ragazzi popolari. Inseguiamo il ragazzo americano con tanti amici e un’attitudine di successo. Molte persone non rientrano in quest’immagine e non possono indossare i nostri vestiti. Siamo esclusivi? Assolutamente». Non è un caso che, per le loro pubblicità, reclutassero solo ragazzi e ragazze da confraternite universitarie rigorosamente bianche. Quell’intervista, inizialmente passata in sordina, diventa virale qualche anno dopo la sua pubblicazione, quando il clima culturale intorno a questi temi è ormai cambiato, e scatena una petizione online firmata da migliaia di persone che chiede le scuse formali di Abercrombie e un cambio delle loro policy, in primis il rifiuto di produrre vestiti sopra una certa taglia.
Ma c’è anche, anzi c’è soprattutto, la questione dei lavoratori: Abercrombie viene infatti formalmente accusata da un gruppo di ex dipendenti, che rivelano un sistema di classificazione in base alla “hotness” (ovvero quanto si è bianchi e convenzionalmente belli) nel processo di reclutamento del personale e distribuzione dei turni. «Ci sono troppi asiatici in questo store», avrebbe detto Jeffries durante una delle sue temute visite in negozio, con la conseguenza che i dipendenti non caucasici venivano spostati nel retro, messi a fare le pulizie o gradualmente licenziati. La causa si concluderà con un patteggiamento, ma intanto diventa chiaro a sempre più persone cosa l’all American di Abercrombie significhi. Ci sono poi le magliette con gli slogan razzisti – «Two Wongs can’t make it white», recitava una, che ha fatto scoppiare la protesta delle associazioni degli studenti di origine asiatica per il suo contenuto caricaturale – e c’è la storia di Samantha Elauf, che non era stata assunta perché il suo hijab non corrispondeva al “look Abercrombie” e che nel 2015 ha vinto la causa contro il marchio per discriminazione nelle pratiche di assunzione.
Dopo queste esperienze, e prima della dipartita di Jeffries dal marchio nel 2014, Abercrombie ha tentato di migliorare le sue policy, soprattutto nei negozi, ma come White Hot racconta bene il fulcro della sua identità è rimasto quello che era all’inizio degli anni Duemila, nel suo periodo d’oro, lo stesso che si scontrerà ferocemente con la nuova sensibilità dei consumatori. La nuova Ceo Fran Horowitz, nominata nel febbraio del 2017, sta cercando intanto di ribaltare le carte, come il nuovo sito racconta. A un certo punto uno dei dipendenti ricorda che nel film di Spiderman con Tobey Maguire (2002), quello diretto da Sam Raimi, il bullo era vestito Abercrombie: «Qualcosa stava cambiando, non eravamo più cool», dice con gli occhi sgranati. Chi era giovanissimo in quegli anni, ricorderà come “Abercrombie” era l’appellativo sprezzante con cui Seth di The O.C. si riferiva a Luke, il biondone (nonché testimonial per davvero del marchio in quel periodo) primo fidanzato di Marissa. Abercrombie non è certo il primo che ha fatto dell’esclusività il suo marchio di fabbrica, che anzi è sempre stato il gioco della moda. Era anche riuscito nell’impresa di vendere magliette e pantaloncini a un pubblico perlopiù “basic” utilizzando un’immagine pubblicitaria chiaramente gay, un’operazione francamente geniale, ma l’ossessione con cui Jeffries ha perseguito la sua idea di gioventù e bellezza fino a sconfinare nella discriminazione rivelano una miopia di fondo che oggi nessun brand può più permettersi.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.