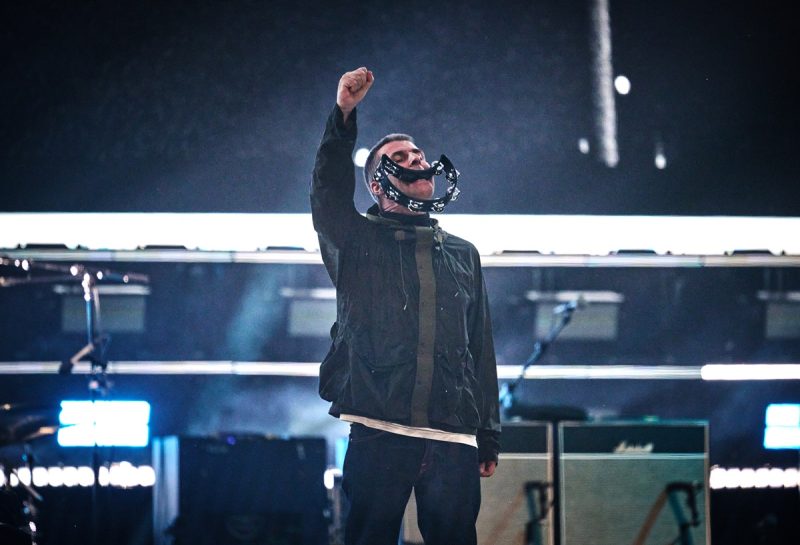Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Yuri Ancarani dimostra che il cinema sperimentale esiste ancora
Una conversazione con l'artista e regista di cui ha appena inaugurato una grande mostra personale al Pac di Milano, Lascia stare i sogni, un'occasione unica per vedere tutti i suoi film.

Ha inaugurato il 4 aprile Lascia stare i sogni, la personale di Yuri Ancarani al PAC di Milano curata da Diego Sileo e Iolanda Ratti. Ancarani, artista e filmmaker (Ravenna, 1972), ha realizzato a partire dalla fine degli anni Ottanta un corpus di lavori tra video e film che ad oggi fanno di lui uno dei più affascinanti esploratori di quel territorio espanso dell’immagine-movimento. Dai primi cortometraggi video, ai successi di film come The Challenge (2016) e il recente Atlantide (2021) presentati rispettivamente nei festival di cinema di Locarno e Venezia, il suo sguardo è stato ospitato ormai in tutti i più importanti musei, biennali e spazi istituzionali, lavorando a una continua commistione tra cinema documentaristico e denso lavoro sull’immagine, una ricerca volta ad esplorare territori apparentemente poco visibili nella vita quotidiana oppure lontanissimi dell’esperienza della maggior parte del pubblico. Realtà nelle quali Ancarani si addentra sempre con il suo sguardo in prima persona. Abbiamo parlato con lui a proposito dei temi toccati dai suoi film, ma anche di formati audio-video e della sua ultima fatica Il popolo delle donne (2023) presentato per la prima volta per la mostra al PAC: un’intensa lezione sul tema della violenza di genere tramite la testimonianza di Marina Valcarenghi, storica attivista e psicoterapeuta milanese.
ⓢ Cosa stai guardando in questo periodo? Ci sono film che ti hanno particolarmente sedotto di recente?
Sarò sincero; la cosa che ho visto di più ultimamente è una serie sugli zombie che ho scovato tra quelle di Netflix.
ⓢ Ti sei confrontato anche tu con il tema, anche se immagino che la serie sia anni luce distante dal tuo Whipping Zombie.
Sì infatti è totalmente un’altra cosa: immaginati uno di quegli horror d’azione dove gli zombie corrono. Devi sapere che incontrai Dario Argento mentre stavo girando Whipping Zombie (2017) e mi raccontò che insieme a George Romero anche loro andarono ad Haiti a far ricerca per il film Dawn of the Dead (1978), là vennero a conoscenza di quel rituale che documento nel mio film. Argento e Romero visitarono un ospedale dove c’era un area dedicata agli “zombie”: ossia individui privati della loro identità e impiegati come schiavi per lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero. Ma per gli haitiani il diventare zombie era una maledizione ben peggiore perché per le loro credenze significava vivere per sempre lavorando, senza poter mai morire. La morte era in realtà una benedizione che coincideva con l’andare in paradiso. Se ci pensi, questa idea di una schiavitù lavorativa eterna, più che una leggenda è condizione sociale non così lontana dalla realtà.
ⓢ Pensi che oggi non ci sia più molto margine d’innovazione, oggi, e neppure spazio per fare cinema d’autore anche in grandi studi e produzioni?
Non mi sembra di trovare più la stessa capacità di un tempo di costruire prodotti di valore. Penso ad esempio all’evoluzione di una casa di produzione come la A24: hanno fatto un lavoro eccellente ma ho la sensazione che poi arrivati a un certo punto i meccanismi degli Oscar facciano perdere la visione a chiunque, conformando molto i linguaggi. In realtà è la “forma” di quei film a essere sempre la stessa: anche la proposta di nuovi temi sociali apparentemente condivisibilissimi, sono trasmessi con modalità da propaganda e ritmi da videogame.
ⓢ Come dicevi tu, ci siamo assuefatti attraverso le piattaforme di streaming a produzioni, formati e narrazioni estremamente didascalici, per non parlare dell’aspetto sonoro… Al contrario tu hai sempre ponderato molto la tridimensionalità dei tuoi lavori.
Mi interessa molto cercare di riprodurre un’esperienza di scoperta, e coinvolgere i visitatori su più livelli. Trovo deludente anche da spettatore essere sempre accompagnato per mano, ed essere in fondo “costretto” a provare quel sentimento lì, in quel punto lì della trama. Da questo punto di vista è interessante riflettere sul fatto che nella scuola di cinema e televisione più anti-Hollwoodiana che esista, quella fondata da Fidel Castro a Cuba, s’insegni che il cinema non debba empatizzare con lo spettatore, il pubblico deve provare in autonomia i propri sentimenti rispetto alla storia e ai personaggi, non deve essere costretto ad entrare in empatia con il protagonista come se fosse un automatismo, altrimenti si abitua a provare passivamente delle emozioni che non gli appartengono.
ⓢ A proposito di rivoluzione; Il popolo delle donne, il film che presenti per la prima volta nella mostra al PAC è una lezione in questo senso, anche perché parte da una presupposto oggi rivoluzionario: la capacità di ascoltare.
È un film di 50 minuti, fatto sì di immagine, ma soprattutto di voce. Milano ha sempre avuto una storia di militanza e di attivismo radicale, ora ci siamo forse un po’ rimbecilliti. Ho passato molto tempo a Venezia per la lavorazione di Atlantide e ho avuto a che fare con tutti di questi ragazzini con un livello d’istruzione anche molto basso. Dal momento che avevo a che fare con minorenni, è stato necessario il supporto di una serie di professionisti che si occupavano di psicanalisi, per capire l’atteggiamento di Daniele, e degli altri protagonisti. Lì è nata un’amicizia con Marina Valcarenghi, ottantenne milanese che da giovane organizzava con il fratello il Festival Popolare al Parco Lambro. Marina dirigeva la rivista Re Nudo, ha lavorato per una sacco di tempo sui diritti della donne, portando nelle carceri di Opera e Bollate nei reparti di isolamento maschile la psicanalisi, parlando con stupratori, assassini e studiando come pochi altri in Italia in tema della violenza di genere. Spesso durante i nostri incontri emergevano questi argomenti per niente facili anche solo da ascoltare, e dato che sono sempre stato interessato a muovermi in territori pericolosi ho pensato di restituire questa sua conoscenza in un film, che a differenza di altri miei lavori non riguarda tanto “un luogo” ma un argomento.
ⓢ Oltre all’esplorazione di quelli che hai definito “territori pericolosi”, vedendo i tuoi lavori si coglie sempre la presenza costante del tema della potenza a varie intensità di manifestazioni.
Temo più che altro che il desiderio di potenza faccia parte dell’imprinting nel pensiero maschile ed è quello che poi crea tutti i disagi, anche quelli di strettissima attualità storica e politica e che ci mantiene estremamente retrogradi sotto molti punti di vista. Subiamo costantemente fin da bambini l’idea di dover essere tutti vincenti, tutti potenti. È il prodotto di una costruzione culturale: la società t’impone di essere un vincente come uomo, quella sensazione che magari puoi provare da adolescente facendo le gare in motorino e che poi andando avanti da adulto l’unica cosa che puoi fare per soddisfarla è quella di stare su un divano e sentirti un vincente tifando una squadra di calcio per esempio. Questa mostra è una specie di serie ad episodi dalle parti di Black Mirror, che grazie al display museale vengono presentate nella loro continuità. Come se ci fosse nell’aria un tema non immediatamente esplicitato.
ⓢ Se dovessi cercare di dare un perimetro a questo tema “sospeso”?
Sicuramente quello della mascolinità tossica, anche inconsapevole. Così come sono inconsapevoli i bambini che uccidono una rana a sassate per vedere cosa succede, fino ad arrivare ad altre e se si può più estreme forme di mascolinità tossica. Direi che da sempre che la mia ricerca muove da questa constatazione. Nel percorso del PAC, nella sala che dà sul giardino sono visibili i miei primi lavori video, fatti in un periodo completamente diverso da ora, a budget zero quando giravo per la notte con la telecamera in mano, senza un team di lavoro, contaminati tantissimo dal mondo televisivo, dal mondo del videoclip. Nella loro ingenua freschezza sono malinconici, romantici, fatti con un altro spirito e senza aspettative, eppure anche lì si possono cogliere elementi che riportano al quel tipo di cultura maschile.
ⓢ Quei primi lavori trattengono oggi anche una straordinaria testimonianza dell’immaginario Tondelliano post-Weekend Postmoderno.
Totalmente, tra l’altro recentemente con il mio team mentre ripercorrevamo questi dodici video per immaginare nuovi modi di proporli, ci siamo accorti che attraverso quei lavori ho raccontato tutto della Riviera senza mai davvero toccare due luoghi fondamentali: la balera e la discoteca. Ho capito che quegli spazi per me non rappresentavano un lavoro o un soggetto d’analizzare ma erano l’esperienza pura della vita, del divertimento.
ⓢ Pensi di volerci tornare prima o poi sul tuo immaginario romagnolo?
Sicuramente il tema del clubbing devo riprenderlo in mano, regolarmente ne parlo con il mio produttore ma mi rendo conto che è molto complicato ricostruire quel momento e quel tempo della Riccione degli anni ’90.
ⓢ C’è una differenza nel vedere i tuoi lavori all’interno di una sala cinematografica oppure, come più spesso avviene in luoghi dedicate all’arte?
La più grande differenza è che al cinema ti concentri unicamente su quel film che viene proiettato, mentre nel museo quella stesso lavoro è accompagnato da una moltitudine di altri elementi e questo innesca un processo di relazioni, dialoghi e percorsi tra più lavori, sono due mondi profondamente diversi.
ⓢ Quale dei due contesti prediligi?
Il museo. È ancora uno spazio che richiede una certa postura, dove entri con certe aspettative e con un’attenzione differente, persino sacrale a volte. Trovo più interessante quel tipo di contesto ed è una sensazione che recentemente mi ha anche confermato l’esperienza di Atlantide proiettato al MAMbo di Bologna: le persone lo stanno amando, ed evidentemente ha incontrato l’esigenza del pubblico di vederlo in un certo modo: solo la prima settimana abbiamo registrato 7000 ingressi. L’altro grande problema è che le nuove sale cinematografiche di oggi sono terribili, sono luoghi per lo più respingenti. In più l’esperienza sonora delle maggior parti delle sale non rispettano i parametri sonori del mix originale. La richiesta di impostare l’audio a 7 decibel, il più delle volte non viene rispettata dalle sale e quando assisto alle proiezioni mi rendo conto che l’audio è a 4.5, tre decibel in meno, in più sono modificati, tenendo tutti i livelli bassi e il centro alto, perché al centro c’è la voce.
ⓢ Detto questo ti piacerebbe se i tuoi film fossero mandati in onda su reti tv nazionali, penso chessò, su La7 o Rai3?
Per me andrebbe bene, perché quello che trovo interessante delle immagini in movimento è la loro fluidità, che riesce anche a mettere in discussione il concetto di opera d’arte. Oggi l’arte ha il dovere di essere messa a disposizione di tutti, può andare ovunque. Del resto Il Capo è andato in tv in prima serata su RS1 che è la prima rete della Svizzera italiana. Sembra strano per noi abituati ai palinsesti nostrani ma del resto per loro il “cinema di montagna” è un genere importante, quindi c’era un presentatore che introduceva il lavoro e alla fine una sorta di commento. La cosa affascinante è che il fatto risale al 2010, quando il film era appena uscito, quindi mi fu richiesto non tanto per la sua presunta “artisticità” ma proprio per il tema che trattava.
ⓢ Quindi non c’è posto migliore di un museo oggi per vedere il cinema ed evadere dal mercato dell’intrattenimento?
Assolutamente: i musei sono dei veri bunker dove si fa resistenza!