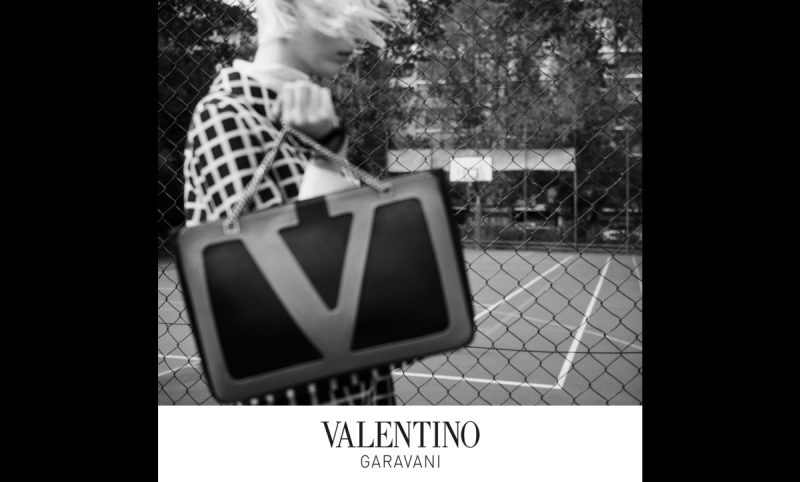L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
John C Jay, dalle strade di New York a piazza Cordusio
Intervista al Presidente e Global Creative di Fast Retailing, il gruppo che con l’apertura italiana di Uniqlo e le due successive a Barcellona e Madrid, continua nella sua strategia di consolidamento fuori dal Giappone.

Mentre la telecamera è fissa su un muro scalcagnato della metropolitana di New York, una voce di sottofondo, sembra piuttosto giovane, racconta le giornate passate a giocare a basket per le strade della città; in un altro video, l’obiettivo è fermo su una strada di passaggio sotto a un ponte. Entrambi durano poco più di trenta secondi l’uno e in entrambi, da qualche parte nell’inquadratura, c’è un adesivo di Nike. Sono le prime installazioni di una campagna che ha segnato la storia della pubblicità, ovvero Nike NYC City Attack, si possono rivedere su YouTube e sebbene il più delle volte si tratti di video abbastanza sgranati, raccolgono ancora oggi i commenti nostalgici degli appassionati. La voce di molte di quelle prime clip è di Bobbito Garcia, dj, host radiofonico e personaggio di culto nella scena degli sneakerhead newyorkesi, prima che questi diventassero materiale da prese in giro feroci. Dal 1990 al 1998 Garcia conduce infatti uno show su una piccola emittente radio, dove insieme al dj Stretch Armstrong parla liberamente di hip hop, New York e tutto quello che ci gira intorno. Da The Stretch Armstrong & Bobbito Show passano a fare freestyle Big L, Jay Z, Nas e Notorius B.I.G. fra gli altri. È il programma di culto in un momento in cui si sta costruendo un culto ben specifico della città ed è il programma che rappresenta al meglio una comunità che è locale e ben radicata.
Lo ascolterà anche John C Jay, che nel 1993 è un giovane creativo con alle spalle un’esperienza da Bloomingdale’s e ora in forza presso la prestigiosa agenzia Wieden + Kennedy, e che proprio quell’anno verrà spedito a Portland a lavorare per Nike. Il co-fondatore del marchio Phil Knight, infatti, è preoccupato che Nike stia perdendo rilevanza nella scena underground newyorkese, così John organizza quello che lui chiama un piccolo “swat team” per perlustrare le strade alla ricerca di tutto quello che di interessante stava accadendo. È dall’incontro con Bobbito che nasce il concept di City Attack, e cioè quello di scegliere degli ambasciatori autentici per promuovere un prodotto. Sarebbe facile, oggi, intravedere in quell’intuizione la genesi delle più fastidiose derive del fenomeno degli influencer, ma in quelle prime clip per Nike c’era davvero un approccio sperimentale, che ha poco a che fare con lo streaming delle vite di tutti o i post sponsorizzati che sarebbero venuti poi. Quelle clip segnalano invece un’immersione totale in una scena performativa, delineano i confini di una cultura street che nasceva in luoghi e tempi circoscritti e che solo molto tempo dopo sarebbe diventata di massa, individuano sulla mappa i luoghi in cui bisognava esserci, quelli che bisognava conoscere per sentirsi parte di qualcosa. «Entra nel profondo di una città, mostrati rispettoso, sii umile e disposto a imparare, così quando inizierai a collaborare con qualcuno, ti verrà riconosciuto il fatto che conosci e rispetti l’autenticità di quella cultura», consiglia oggi John C Jay a chi vuole avventurarsi nell’impresa di pubblicizzare qualcosa ai tempi di Instagram.
Lo incontro a Milano, in occasione dell’inaugurazione del primo negozio italiano di Uniqlo in piazza Cordusio. Dal 2014, infatti, è Presidente e Global Creative di Fast Retailing, il gruppo guidato da Tadashi Yanai che oltre a Uniqlo possiede J Brand, Comptoir des Cotonniers e Princesse Tam-Tam fra gli altri e che, con l’apertura italiana di settembre e le due successive a Barcellona e Madrid, continua nella sua strategia di consolidamento fuori dal Giappone. «La maggior parte del marketing arriva in un posto e inizia a fare pubblicità, mentre da Uniqlo spendiamo gran parte del nostro budget a farci domande. Chi sono le persone interessanti in questa città? Non quelle famose, quelle interessanti. Chi sono le persone che creano cultura e hanno un futuro a Milano? Cosa stanno dicendo del loro quartiere, della loro città e quindi cosa possiamo imparare da loro? Questo modo di agire viene dalla mia esperienza di City Attack», continua. Così lo store di piazza Cordusio è pensato per celebrare le due identità che si incontrano, quella del marchio e quella della città, e molte realtà e creativi milanesi, acquisiti e d’origine, hanno trovato spazio al suo interno, da Olimpia Zagnoli a Odd Garden, da One Block Down al brand di borse Medea.
«Chi sono le persone che creano cultura e hanno un futuro a Milano? Cosa stanno dicendo del loro quartiere, della loro città e quindi cosa possiamo imparare da loro? Questo modo di agire viene dalla mia esperienza di City Attack»
Ma cosa rende Uniqlo adatto al mercato globale? «Stiamo emergendo solo ora come un marchio globale, non lo siamo ancora. Siamo orgogliosi di essere un grande marchio giapponese, e il nostro obiettivo è diventare un grande marchio giapponese e globale. Per questo Milano è così importante: possiamo imparare dalla ricca storia di design e cultura di questa città e provare a immaginare come Oriente e Occidente si fondono, come vecchio e nuovo si fondono», mi dice, anche se il vero punto di forza del marchio è un altro ancora, a dirla tutta. Uniqlo è conosciuto per il cachemire a buon prezzo, certo, ma ha anche un’allure utilitario che piace a una categoria molto trasversale di persone, dai più fashionisti a chi cerca abbigliamento comodo e senza logo. Secondo John C Jay, è proprio quell’elemento democratico che lo rende fortissimo e particolarmente adatto ai tempi che viviamo: «La maggior parte dei marchi oggi parla alle élite, agli influencer con milioni di follower e vuole che siano loro a trasmettere il messaggio alle “persone normali”. Noi non parliamo mai di “persone normali”, ci riferiamo alle persone e basta. L’abbigliamento quotidiano è al centro della filosofia di Uniqlo. E questo perché nel 1998, quando ho iniziato a lavorare con Yanai, l’abbigliamento casual non era affatto popolare in Giappone, i nostri genitori non indossavano jeans e pantaloni khaki come in America. Allora ci siamo chiesti: “Come facciamo a democratizzare il casual?”». Senza contare i cambiamenti delle abitudini di consumo, soprattutto dei più giovani. Quel sentirsi parte di qualcosa, oggi, spesso si esprime nella pretesa che i marchi prendano posizione sulle questioni che attraversano la società per ragioni che non siano, beh, la volontà di vendere i propri prodotti.
Così Uniqlo si è effettivamente ritagliato uno spazio abbastanza originale nel panorama contemporaneo e anche le collaborazioni più sofisticate, come quelle con Christophe Lemaire e JW Anderson, non finiscono per sembrare stonate. «Io ho sempre cercato di fare il mio lavoro all’interno di un contesto culturale. Quando si dice che qualcosa è cool, che cosa si intende? Significa che qualcosa è interessante in quel momento, perché si trova esattamente al centro di un determinato tempo, luogo e cultura. È lo Zeitgeist. Penso che Uniqlo sia in una posizione perfetta per lo Zeitgeist di questo momento, per il modo in cui i giovani pensano ai vestiti, al valore, alla sostenibilità, al consumismo, per tutti questi motivi. E non sono solo i giovani». A quel punto mi racconta di quando dovevano lanciare i pantaloni khaki sul mercato giapponese e ne mise un paio sul tavolo di Tadashi Yanai. «Che cosa vedi?, gli ho chiesto. Un paio di pantaloni casual, stilosi, che più persone dovrebbero indossare. E tu cosa ci vedi?, mi ha risposto lui. Io gli ho risposto che ci vedevo Bobby e John Kennedy che si rilassano facendo sport inseguiti da due cocker a cui hanno appena lanciato un frisbee per aria. Contesto, contesto, contesto. C’è un grosso spazio tra la storia che vuoi raccontare e un prodotto che vuoi vendere. E quello spazio è la cultura di riferimento». Don Draper sarebbe stato d’accordo.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.