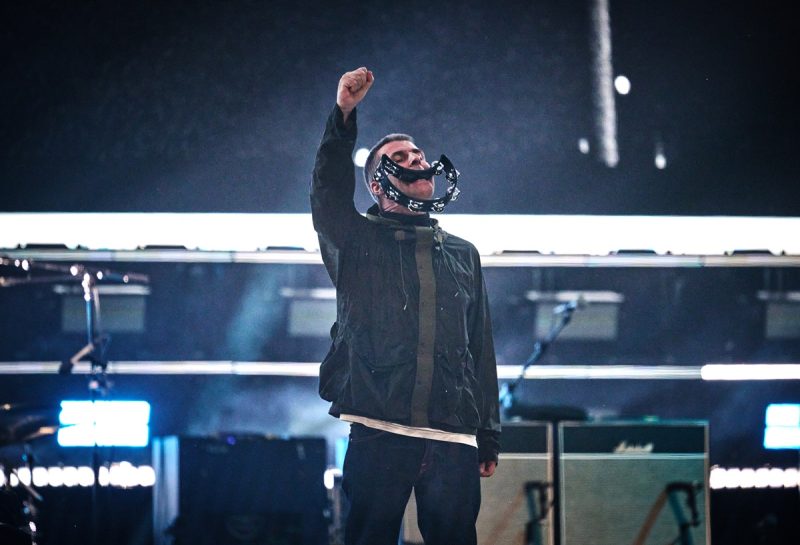Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
David Szalay e i piccoli drammi dell’uomo di oggi
Dialogo con lo scrittore canadese che ha frammentato la forma romanzo per raccontare storie ancorate al presente. Dal numero di Studio ora in edicola.

Ci sono romanzi che, forse, funzionano bene quando ti senti costretto ad abbandonarli. È un tipo di abbandono, questo, non dettato da disinteresse o insoddisfazione, ma dal contrario, e cioè da un eccesso di efficienza, di forza, come un coltello troppo affilato o un fuoco troppo caldo. Te ne accorgi solo riprendendo poi il libro dall’abbandono e facendoti forza, e andando avanti, e superando il fastidio. È una situazione in cui mi sono trovato quando uscì Tutto quello che è un uomo (Adelphi, traduzione di Anna Rusconi), il primo libro di David Szalay a venire pubblicato in Italia. Ero stato inizialmente attirato da molte cose: il fatto che fosse stato finalista del Man Booker Prize nel 2016, una bella foto di Luke Smalley in copertina, una bandella che parlava in modo un po’ vago di «nove uomini, in diverse età della vita, dall’adolescenza alla vecchiaia. Un continente, l’Europa oggi, fotografato in una luce cruda quasi senza ombre». Bello. E poi, ancora meglio: «I nove fanno quasi tutte le cose che i maschi sono soliti fare: inseguono donne, le abbandonano, tentano un affare improbabile, cercano un luogo dove vivere un esilio decente, chiacchierano, sognano un’altra vita». Infine: «Ciò che abbiamo davanti si rivela per quel che è, in tutta la sua perturbante evidenza: il nostro tempo, quello che viviamo ogni giorno, in forma di romanzo».
Era tutto giusto e tutto vero, scoprivo a mano a mano che sfogliavo le pagine, ma in quella descrizione ne mancava una parte fondamentale della scrittura di David Szalay e di Tutto quello che è un uomo, proprio la parte che mi fece poi abbandonare per alcuni mesi il libro in un angolo della casa: e cioè che Szalay, nel raccontare questi uomini, specialmente con i loro monologhi interiori e le descrizioni di quello che vedono, ha un’abilità tanto rara quanto efficace nell’essere crudo, nel mostrare la miseria dell’esistenza in un modo quasi disgustoso nella sua desolazione. Il secondo dei nove protagonisti, ad esempio, un post-adolescente depresso e incapace, è lo squallido hotel di Cipro, in cui conosce, e squallidamente scopa, una madre e una figlia inglesi, entrambe obese. Più avanti, un triste uomo di loschi affari di mezza età bulgaro accompagna la giovane e bella fidanzata a Londra, per venderla in tre giorni di prostituzione di altissimo bordo, in compagnia del suo grosso e scemo eppure buono personal trainer, un ex militare privo di sogni o prospettive. Oppure un giovane giornalista danese, affamato di carriera, non esita a pubblicare in prima pagina la relazione che un amico politico mantiene con una donna sposata, riuscendo perfino a sentire un brivido di eccitazione nel fango moralistico, e nonostante la sua vita sentimentale si trovi nella stessa, medesima, condizione.
Le scene che Szalay scrive sono come set teatrali, circoscritte a pochi giorni, pochi personaggi e panorami non troppo ampi, e la loro funzione è quella di essere dei diorama di tristezze e dolori quotidiani e ordinari. I drammetti al cui centro ci sono loro non sono incredibili, non sono straordinari. «È esattamente una cosa a cui miravo», mi dice lui a proposito di queste piccole infelicità. «Voglio che le storie che scrivo siano completamente integrate nel mondo contemporaneo con un linguaggio contemporaneo, e allo stesso modo voglio che sembrino storie che parlano di persone contemporanee, perché solo in questo modo provocheranno un responso emotivo profondo, nel pubblico». È curiosa e interessante questa devozione di Szalay al contemporaneo, e non ha a che fare soltanto con il linguaggio e gli argomenti che attraversano i suoi libri – gli ultimi due, non i primi, comunque non tradotti in Italia: Tutto quello che è un uomo e Turbolenza – ma anche con la loro struttura: se il primo è una raccolta di nove storie in ordine di maturità del protagonista, in Turbolenza sono dodici, ognuna rappresenta una tratta aerea, e si tengono tutte insieme dall’inizio alla fine. La protagonista del primo segmento, che vola da Londra a Madrid, incontra il protagonista del secondo, che da Madrid andrà a Dakar. Nel corso di questo racconto, il secondo farà la conoscenza, diretta o più ambigua, di chi poi troveremo ancora nella terza storia, che da Dakar ci porterà a San Paolo, e così via. I capitoli di Turbolenza sono corti, spesso meno di dieci pagine, il ritmo è sincopato e rapido, sempre a proposito di contemporaneità.
C’è stata una ricerca alla base di tutto, naturalmente, per Szalay, che in un’intervista pubblicata dal Paris Review nell’estate 2016 si chiedeva: «Cos’è un romanzo? Ti inventi una storia e poi racconti quella storia. Semplicemente non capivo come o perché dovesse avere un senso». La soluzione trovata, appunto, è quella di frammentare la forma-romanzo in diversi segmenti che non rappresentano semplici racconti, ma sviluppano un intreccio più complesso. «Lo scopo», mi dice parlando della struttura di Tutto quello che è un uomo, «era creare qualcosa che fosse, come poi è stato, più grande della somma delle sue parti, qualcosa che formasse una struttura più larga». Non è stato un intervento decostruttivo per il puro gusto di mettere mano all’architettura del romanzo: «Quello che mi attraeva», continua, «era il fatto che speravo fosse un modo innovativo di parlare di tempo, invecchiamento, mortalità».

Da un lato i libri di Szalay colpiscono per la crudezza dell’umanità che mostrano, eppure dall’altro, guardandoli con un occhio filologico, si fanno invece apprezzare per l’originalità dei meccanismi messi in scena. Non soltanto, come spiegato, nella struttura episodica eppure coerente dall’inizio alla fine, ma anche grazie ad altre trovate, sparse nel testo, di diversa natura e di diverso ambito, e che rendono i testi movimentati, paradossalmente divertenti. Szalay gioca con l’allineamento del testo, che talvolta passa a destra anziché a sinistra a comunicare un’ulteriore pausa, un momento contemplativo; con gli spazi bianchi, che possono essere utilizzati come passepartout intorno a una frase da isolare al centro della pagina; con le onomatopee, come la trascrizione di un’aria ascoltata alla radio, che si sparpaglia in diverse righe: zum zum / zum zum zum lallà / zum-zum-zum; con la continua citazione dei nomi propri di marchi e brand: quando un personaggio si ferma a un distributore per rifornire la sua auto, non sceglie della generica benzina ma della V-Power Nitro+, e la macchina in questione è precisamente una Nissan Qashqai. «Soprattutto in Tutto quello che è un uomo ho lavorato molto per far sì che il modo in cui il testo è disposto sulla pagina fosse un ulteriore strumento espressivo. È una cosa che viene fatta da sempre in poesia, e non vedo perché non si possa fare con la prosa».
La bandella di Turbolenza, come se mi avesse letto nel pensiero, è giustamente più drammatica del romanzo precedente: «Gli uomini e le donne di Turbolenza», si legge, «vivono in aria – come, sempre più spesso, molti di noi. E, come molti di noi, sanno che dall’aria non si può sperare di proteggersi: nell’aria, soprattutto, non si può sperare di nascondersi». Come nel libro precedente, il dialogo è utilizzato da Szalay in modo abbondante eppure inutile ai fini dello sviluppo della storia. Al contrario, i dialoghi comunicano l’assenza di contatto e di vicinanza tra i personaggi, sono ponti spezzati. Quello che davvero succede, invece, succede nella mente dei protagonisti, nei monologhi interiori e nei ricordi. «È vero», dice lui, «è un aspetto della vita che mi interessa molto, come molti tra i più importanti eventi della nostra vita non sono affatto “eventi”, nel senso che prendono la forma di cambiamenti sottili, quasi impercettibili, nei nostri pensieri e nel nostro modo di sentire». Szalay schiva il paragone più ovvio che gli lancio addosso, quello con Bret Easton Ellis, «certamente è un esempio di scrittore che sembra essere preoccupato da alcuni temi che preoccupano me», e cioè il contemporaneo, e cita come ispirazione un nome più inaspettato, ma solo superficialmente: Henry James. Ed è facile pensare alla triste parabola di Isabel Archer di Ritratto di signora, rileggendo di «cambiamenti sottili, quasi impercettibili».
Tuttavia, in entrambi i romanzi c’è un’inaspettata redenzione finale: al centro c’è un’esperienza di malattia e morte imminente, comune in ambedue i finali, attesa però con calma e serenità. «Mi sono accorto soltanto dopo aver finito Turbolenza di quanto fossero simili», racconta Szalay. E c’è un che di spirituale, in quella serenità: «È qualcosa che credo abbia a che fare con la mortalità, qualcosa che la nostra mortalità ci chiede, in un certo senso». Le ultime pagine sono improvvisamente senza i tormenti, le tensioni, i dolori di quelle precedenti. Come quando, in aereo, raggiungi la quota di crociera, si spengono le spie. Puoi chiudere gli occhi.