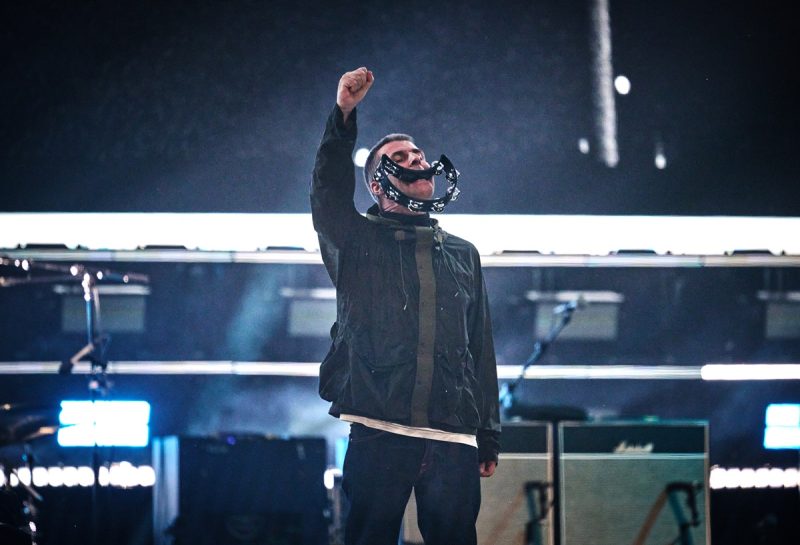Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Staccare la spina a una serie di grande successo fa venire in mente Jerry Seinfeld quando si rifiutò di fare una decima stagione della sua sit com Seinfeld, anche se gli avevano proposto centinaia di milioni di dollari. «Volevo finire la serie con lo stesso hype raggiunto negli anni», aveva detto Seinfeld, «Volevo chiuderla in un momento di forza. Volevo che il finale fosse aggraziato». Ecco, niente salti fonziani sullo squalo, niente guest star per ravvivare l’ambiente, niente addii del cast originale, per Succession (il finale della serie è disponibile su Sky e NOW). Serie che entrerà nei corsi di sceneggiatura insieme a Mad Men e Sopranos. Serie che è già diventata una miniera di meme.
Per tutte le quattro stagioni non si può non pensare al pezzo che uscì nel 2021 sul New Yorker, un profilo dell’attore Jeremy Strong (Kendall Roy, eroe sisifesco della saga ispirata ai Murdoch) dove si capiva l’ingrediente principale del grande boom della serie: mantenere la confusione tra commedia e drama. «Dopo la prima stagione mi ha detto una cosa del tipo: “ho paura che penseranno che si tratti di una commedia”», dice Kieran Culkin – che interpreta il fratello Roman Roy – parlando di Strong. «E io gli ho risposto: “io penso che questa serie sia una commedia”». Strong è noto per prendere quasi troppo seriamente i suoi ruoli. In generale la vita. Nei video del magazine Gq in cui viene chiesto a una star di presentarsi con i “10 oggetti di cui non puoi fare a meno” – la gente di solito porta creme per il viso, tavole da surf, ricordi dei primi film – Strong porta una pila di libri tra cui La Recherche di Proust, Rilke, Knausgard, T.S. Eliot e testi junghiani. Il produttore della serie, Adam McKay, regista passato dalle commedie demenziali con Will Ferrell a filmoni satirico-moralisti come Don’t look up e Vice, dice: «È proprio per questo che abbiamo scelto Jeremy per quel ruolo. Perché non lo interpreta come una commedia. Lo interpreta come se lui fosse Amleto».
Con la fine della quarta stagione, e di tutta la serie, ci rendiamo conto che in queste 39 puntate abbiamo continuato a guardare Shakespeare, cioè, siamo stati assorbiti da quell’incapacità degli anglosassoni di lasciar andare la tradizione del Bardo, le sue strutture morali e i suoi piccoli dubbi mentali. Dubbi che diventano cose gigantesche nella mente dei personaggi, spesso andando contro il proprio benessere. «Ma adesso, nella divisione del regno, non appare chiaro quale dei duchi egli stimi di più, perché le parti sono state fatte con tale equilibrio che, per quanto si consideri, non si può vedere una preferenza per l’uno o per l’altro», si legge nel Re Lear. E noi ancora non sappiamo quale fosse il figlio o la figlia preferita da Logan Roy – interpretato dal fantastico Brian Cox – o selezionata per portare avanti il potere di Atn e della Waystar. Certo, sono passati un po’ di secoli da quando Re Lear venne scritto, in mezzo c’è giusto qualche rivoluzione industriale, la fine dell’ancien régime, Freud, la bomba atomica, il nazismo, il modernismo letterario, l’esplosione del capitalismo globalizzato, gli iPhone, eccetera eccetera, ma restano le stesse strutture nel modo in cui la narrativa racconta le dinamiche interpersonali e, soprattutto, quelle dei dubbi interiori. «Essere o non essere, questo è il dilemma?». Quanti momenti della serie sono attimi di silenzio in cui i protagonisti, e non solo, restano a pensare e poi fanno esattamente il contrario di quello su cui pochi minuti prima erano convintissimi? Un comportamento molto poco mediterraneo, molto poco dantesco, molto poco goldoniano.
Shiv, interpretata da Sarah Snook, la sorella che a un certo punto della serie decide di voler anche lei diventare Ceo dopo aver detto varie volte di non aver alcun interesse nell’azienda di famiglia, preferisce alla fine che il fratello perda, preferisce punirlo per il suo carattere piuttosto che andare avanti con il loro piano prestabilito. Torna dal marito, che odia, e abbandona il fratello, che ama. Molto Shakespeariano. Così come lo è il nichilismo finale di Roman, che apparentemente sembra il personaggio più post-moderno, quello con le battutine da screenshottare e condividere su Instagram, ma che è, in fondo, un folletto da Sogno di una notte di mezza estate in chiave nichilista – «Se noi ombre vi siamo dispiaciuti / immaginate come se veduti / ci aveste in sogno, e come una visione / di fantasia la nostra apparizione», dice Puck – e infatti l’ultima scena in cui vediamo Roman, lui sorride, un sorrisetto che ci dice la commedia è finita, è stato tutto un sogno. «Non siamo niente… okay?», urla Roman verso la fine.
Quest’interpretazione, probabilmente inconscia negli storyteller anglosassoni, è solo una parte dell’analisi che si può fare di Succession, ma ne traccia comunque l’impostazione. Certo, possiamo dire che i soldi sono solo un McGuffin, e che alla fine nessuno dei personaggi, nemmeno i perdenti del grande Monopoly freudiano-aziendale, finiscono in strada, anzi i miliardi in banca aumentano per tutti. Ci può esser il messaggio che alla fine i giganti esuberanti del Big Tech in gorpcore, come lo svedese Lukas Matsson, interpretato da Alexander Skarsgård, battono i media televisivi tradizionali. O che il secolo americano è finito e viene mangiato dagli europei. Si può anche vedere l’effetto iper-satirico quasi Black Mirror sulla caratterizzazione del presidente filo-nazista, molto più intelligente di Trump, quasi demonico. Ci si può vedere la critica un po’ marxista dei potenti che piagnucolano ma continuano a tenere le fila del mondo e a scegliere il “prossimo leader del mondo libero” nel loro salotto. E si può parlare del bisogno che hanno gli americani di crearsi una casata reale, così come avevano provato a fare con i Kennedy, nella loro storia così poco sedimentata così manchevole di monarchia, rituali e regge, e di cercarla nelle lotte fratricide tra nepo-baby figli di self-made-men. Ci si può vedere la vittoria del maschilismo – Shiv alla fine perde ma si piega al marito vincente – e ci si può vedere anche la vittoria del leccaculo contro gli eredi designati, il lavoro (sporco) contro il diritto di sangue, che è il succo del capitalismo e del sogno americano. I momenti di tenerezza, come riguardare i video del padre ancora vivo, o la scena in cui i tre fratelli giocano facendo un bibitone vomitevole da far bere a Kendall – che sembra un momento di Freaks & Geeks, di America da sobborghi, da film di John Hughes – servono a confonderci che loro sono esseri umani, e non figuranti di una commedia, o di una tragedia shakespeariana.