La nuova serie della creatrice di Girls è piena di difetti ma ha un pregio che da solo quasi basta a redimerla: rende bene l'idea di che cosa terribile siano le relazioni oggi.
C’era una volta a Hollywood è il primo romanzo di Quentin Tarantino. O è la sua diciottesima sceneggiatura. O la diciassettesima, se le differenze non bastassero a tenere separati libro e film. Se avessi il talento per le immagini pulp di Tarantino («con la lampadina rossa in bocca e la faccia priva di espressione, sembra un incrocio tra un robot e una bambola gonfiabile», scrive di Debra Jo, la “pussycat” della Manson Family, in una scena che nel libro c’è ma che manca nel film in cui Debra Jo è interpretata da Margaret Qualley) direi che libro e film sono gemelli siamesi: il libro però è il gemello inquietante all’inizio e cattivo alla fine. In questo gemello-libro c’è un Rick Dalton molto simile a quello del gemello-film, solo che questo è bipolare e il suo alcolismo non è patetico ma angosciante. In questo libro c’è un Cliff Booth che somiglia assai a quello del film, solo che questo non è affascinante ma inquietante: si è fissato con Delilah di Tom Jones perché gli piacciono le canzoni che raccontano di uomini che uccidono le mogli. In questo libro l’ultraviolenza sta tutta in un paio di righe, cosa inquietante di per sé perché chi scrive è Quentin Tarantino, lo sappiamo noi e lo sa lui, e il film, cioè il libro, è C’era una volta a Hollywood, la scena finale la conosciamo noi e la conosce lui. Che succede? L’ultraviolenza è l’espediente di meta-finzione di Tarantino, il segnale che ci ricorda che è tutto finto e che it’s-so-much-fun-JAN-get-it. Non sarà mica lo stesso trucco usato nel film? Farci credere di sapere cosa sta per succedere per poi far succedere la stessa cosa, ma in un modo diverso? C’è da preoccuparsi perché è ovvio che Tarantino sa che noi sappiamo: non si disturba a descrivere perché sa che l’immagine è già nella nostra testa. Cliff che ripara l’antenna sul tetto della casa di Rick ha i muscoli di Brad Pitt. Sharon Tate ha il volto di Margot Robbie o di Sharon Tate. Steve McQueen ha la faccia di Damian Lewis o di Steve McQueen. Tarantino scrive un mondo che è il nostro e che è il suo, che quindi conosciamo due volte e che perciò non serve descrivere. È per questo che gli avanza tanto spazio, tanta energia e tanto tempo per descrivere le minuzie della vita hollywoodiana di ogni formato, colore e strato, rivolgendosi direttamente al lettore e riuscendo comunque a scrivere un romanzo.
Il libro è il gemello cattivo e inquietante del film perché cancella l’interpretazione della sua storia come “lettera d’amore al cinema”. Siccome la storia è la stessa e i personaggi sono gli stessi, non c’è dubbio che quello che vale per il libro valga anche per il film. Ma il libro aggiunge senza sostituire, arricchendo di dettagli che una volta visti non si possono ignorare. Questa è una storia di falliti e di perdenti, di pezzi di merda e di teste di cazzo. Cliff odia Bruce Lee perché non vede differenza tra un artista marziale di Hong Kong e i soldati giapponesi contro i quali ha combattuto nelle Filippine durante la Seconda Guerra Mondiale. Rick odia gli hippie perché è «un attore dell’epoca di Eisenhower catapultato nella Hollywood di Dennis Hopper». Charles Manson odia il mondo intero perché non ha avuto la sua audizione e perché i Beach Boys gli hanno rovinato Cease to exist. Allo stesso tempo Tarantino ammette che questi uomini (o uomini come questi) sono stati i protagonisti dei suoi anni formativi e quindi sì, in un certo senso aveva ragione Mereghetti quando diceva che C’era una volta a Hollywood è un film fatto da un bambino viziato che vuole farci sapere che i suoi giocattoli sono i più belli. È così, però in un modo diverso da quello che intendeva Mereghetti: quella di Tarantino è un’ammissione di debolezza, il riconoscimento che nessuno si sceglie la generazione precedente alla sua. Questi sono i miei giocattoli, magari sono vecchi, sicuramente sono brutti, comunque sono i miei giocattoli. E ovviamente Tarantino è un bambino viziato: nel libro c’è una scena in cui il padre adottivo di Quentin, che era davvero il musicista di nome Curtis Zastoupil, si fa firmare un autografo da Rick Dalton con dedica al marmocchio cinefilo che lo aspetta a casa, un bambino che si chiama come si chiama in onore di un personaggio di Gunsmoke, che è lo show televisivo che ha ispirato il Bounty Law di cui Rick è stato la star. L’ultima volta che ho letto una cosa del genere, Stephen King si faceva salvare la vita da Roland Deschain de e ne La Torre Nerra.
Non che la questione del conflitto generazionale si risolva così. Nel film era appena accennata in Debra Jo che spiega a Cliff che:«Ovviamente io non sono troppo giovane per scopare te, ma tu sei troppo vecchio per scopare me». Nel libro questo tema è esasperato, ogni scambio di battute tra Rick e l’enfant prodige Trudi Frazier è il calco del confronto tra una generazione troppo svelta a capire e una troppo impacciata a spiegare: mentre Trudi (che ha otto anni ma ne dimostra dodici) legge la biografia di Walt Disney e la trova “affascinante”, Rick (che alla fine degli anni ‘60 porta ancora il ciuffo imbrillantinato) non riesce a raccontarle la trama di A cavallo di un mustang selvaggio senza scoppiare a piangere. «Vedi, ogni volta che c’è uno scontro tra due che vogliono comandare, è puro Shakespeare», fa dire a Sam Wanamaker, che ha davvero diretto il pilot di Lancer, prima che Tarantino riscrivesse la serie in una storia di vendetta intergenerazionale con un espediente metanarrativo utile a ribadire il punto. È un commento, quello di Wanamaker, in cui sta tutto il finire degli anni ‘60, decennio chiuso nel più shakespeariano dei modi: inondato dal sangue che cola dall’eccidio di Cielo Drive. E il Paese dove «ai civili era stata risparmiata la dura realtà del conflitto», e il cui cinema per questo era rimasto «immaturo e rivolto in modo frustrante all’intrattenimento di tutta la famiglia» quando scoprì che anche le donne incinte all’ottavo mese muoiono ammazzate.
C’era una volta a Hollywood è il diciottesimo romanzo di Quentin Tarantino. O il diciassettesimo, secondo lo stesso ragionamento di prima. Letto questo libro è difficile capire se le sceneggiature di Tarantino sono quel che rimane dei suoi romanzi dopo l’editing o se i suoi romanzi sono sceneggiature in cui ha lasciato tutto quello che gli piaceva. L’uovo o la gallina. Ci sono però indizi che portano a pensare alla grafomania di Tarantino, quindi a una sua origine da romanziere: C’era una volta a Hollywood è lungo 400 pagine ed è tratto da un film che dura 2 ore e 41 minuti e prima di diventare una sceneggiatura è stato un romanzo al quale il regista ha lavorato per cinque anni (… e quindi è il film a essere tratto dal romanzo?). Questo è un aneddoto che torna spesso nella carriera di Tarantino: Bastardi senza gloria è stato anch’esso un romanzo in lavorazione fin dal 1998 prima di diventare una sceneggiatura. Dei dieci film fin qui diretti da Tarantino, solo tre (Le iene, Kill Bill – Vol.1 e Grindhouse) durano meno di due ore. E per nove di questi dieci film (ai tempi de Le ienefama e soldi non bastavano a pagare la prolissità) si è detto che il tagliato era il doppio della durata, il girato tre volte tanto. Tarantino ha detto più volte di soffrire del “contrario del blocco dello scrittore”, ha sempre ripetuto che il monologo interiore serve anche nelle sceneggiature perché queste si leggono e i film si vedono. Spesso mi è capitato di pensare che Tarantino fosse Aaron Sorkin più Martin Scorsese, se Sorkin non fosse nato a Manhattan e non si fosse laureato in una quasi-Ivy League.
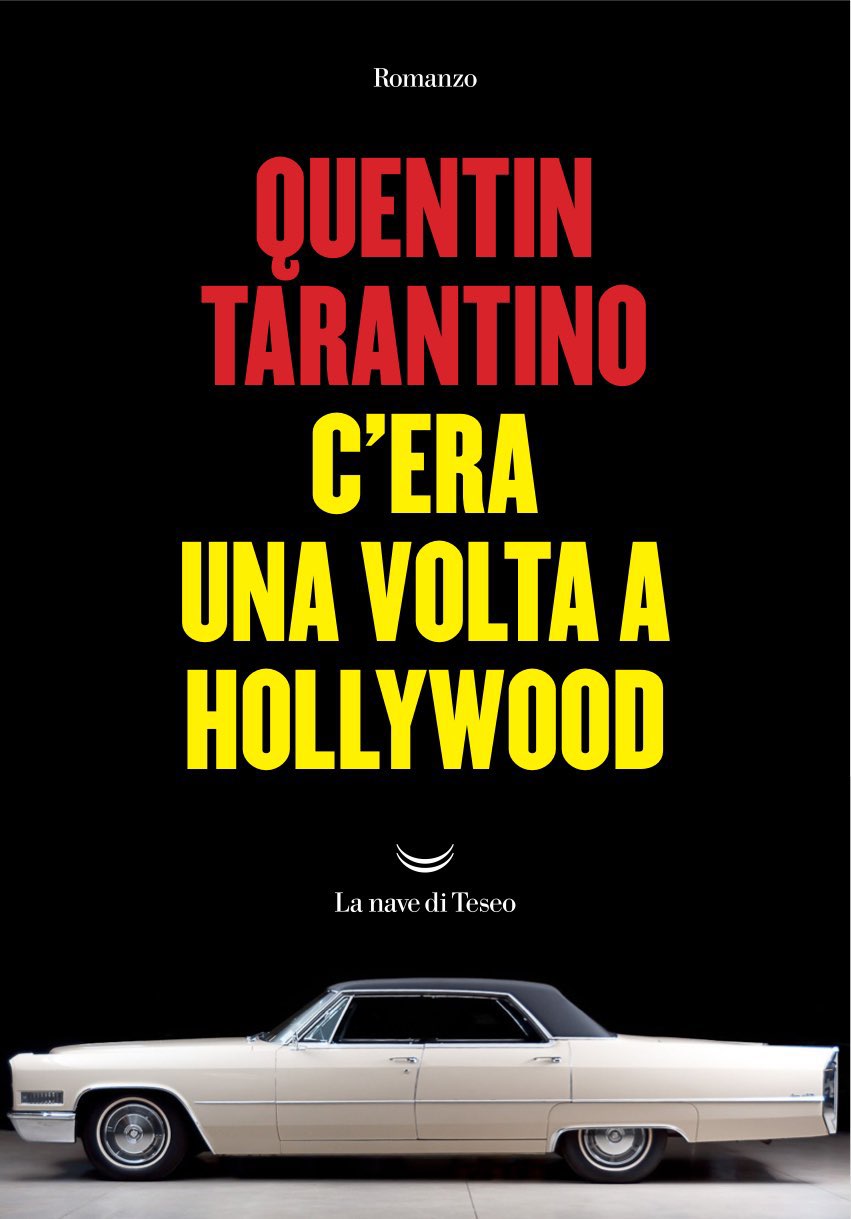
A proposito di aneddoti: questo libro è la prova che l’arte di Tarantino non è né il cinema né la letteratura, il suo mestiere né la sceneggiatura né il romanzo. Tarantino vive per gli aneddoti (l’unica alternativa che conosce è l’epica), gode con ciò che succede attorno ai fatti conosciuti e alle persone famose. Tarantino è davvero Mr. Brown che racconta il vero significato di Like a virgin di Madonna. Il libro è innanzitutto una raccolta di aneddoti su una delle tante vere Hollywood che sono esistite negli anni: <<A tutti gli attori della vecchia guardia che mi hanno raccontato storie impagabili sulla Hollywood di quel periodo>> scrive nelle dediche iniziali. E che importa del vero e del falso in un libro che impiega sei pagine per recensire Io sono curiosa e farci capire che ha ragione Cliff, che il vero cinema è la somma di realtà e finzione? «Va ritenuto pornografico solo ciò che non è riscattato da alcun valore sociale», decise il giudice Paul R. Hays: tutto il resto è arte e/o libertà. Anche perché da quelle parti è tutto vero e tutto falso allo stesso tempo, proprio come la storia di Rick al posto di Steve McQueen ne La Grande Fuga, proprio perché «Hollywood alla fine della fiera è un cazzo di paese», come dice Cliff.
C’era una volta a Hollywood non è né un romanzo né una sceneggiatura: è una novelization, che in italiano si dice romanzamento. Prima della videocassetta era l’unica maniera per portarsi a casa un film ed era lettura obbligata per il tipo di artista di cui Tarantino è la forma perfezionata: quello che non ne ha mai abbastanza. Ci sono sempre vuoti da riempire o universi da espandere o un pezzo di sceneggiatura tagliato che offre spunto narrativo, c’è sempre un grande artista o un bravo professionista o un vecchio tanto disperato/un giovane abbastanza affamato pronto a farlo: le novelization saziano questi appetiti, soddisfano queste necessità. Vedendolo in questo modo, il romanzamento era l’unico esordio letterario possibile per uno che ha costruito una carriera, una leggenda, un mito sulla capacità di mettere assieme grandi artisti e bravi professionisti, di rendere arte ciò che fino a un attimo prima al massimo era mestiere, di trasformare l’ingordigia in ricerca, il quinto quarto in alta cucina. «Arte ma in un modo diverso», come Sharon descrive la trasformazione operata dal marito Roman al discreto romanzo di Ira Levin intitolato Rosemary’s Baby. Forse con questo libro Tarantino intende ripetere il miracolo che gli è riuscito con i suoi film: prendere gli scarti di produzione dell’industria del cinema e farne arte ma in un modo diverso, prendere la forma di fiction più bistrattata e farne romanzo ma in un modo diverso.
C’era una volta a Hollywood non è un romanzo, non è una sceneggiatura e non è una novelization. Potrebbe essere il saggio critico che Tarantino non ha mai scritto ma che ha formato la sua carriera da quella volta che gli capitò di leggere la recensione di Bande à part scritta da Pauline Kael, ma sappiamo già che quello è il suo prossimo libro: si chiamerà Cinema Speculation, con esso sicuramente si esaurirà il contratto con Harper Collins e probabilmente sarà l’inizio della sua nuova carriera, quella di commentatore del cinema. Che è la stessa carriera che ha adesso, ma in un modo diverso.







