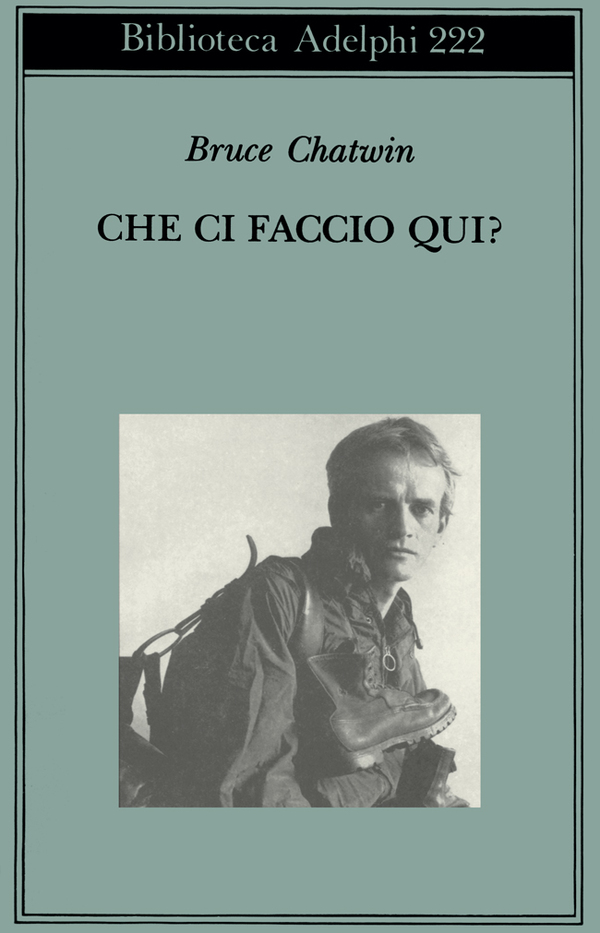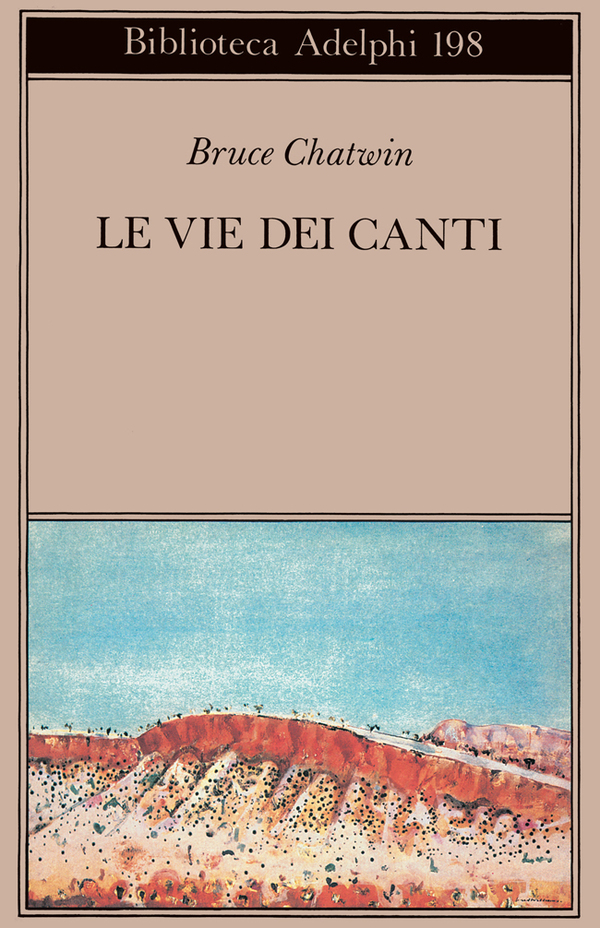Il 13 luglio del 1985 due miliardi di persone seguirono il più grande evento musicale della storia: oggi che un musical ripercorre la sua avventurosa organizzazione ci rendiamo conto di quanto sarebbe impossibile ripeterlo.
Riscoprire Chatwin
Adesso che l’inflazionato autore di libri di viaggi è finalmente passato di moda possiamo iniziare a leggerlo senza pregiudizi.

Il padre dell’antropologia moderna, Claude Lévi-Strauss odiava «i viaggi e gli esploratori». Il caporedattore del Sunday Times deve aver pensato qualcosa di simile quando, nel 1975, ricevette un telegramma da uno dei suoi cronisti della pagina culturale. Il telegramma, contenente solo quattro parole, recitava laconicamente «sono andato in Patagonia». Firmato Bruce Chatwin. Quel giorno di quarant’anni fa iniziava il lungo viaggio del “maestro degli irrequieti”, che avrebbe portato, nel 1977, alla pubblicazione del suo libro più famoso: In Patagonia.
Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Bruce Chatwin è morto di Aids nel 1989, a soli 48 anni. Ma il suo nome, probabilmente a causa della morte prematura, è diventato negli anni Novanta un marchio, legato a un impressionante fenomeno editoriale, soprattutto in Italia. Prendete la vostra Moleskine. Nella tasca dell’ultima pagina troverete un foglietto, una storia del taccuino, dove viene citato per filo e per segno un intero paragrafo di un suo libro, in cui lo scrittore professa il suo amore per quei vecchi carnet francesi, all’epoca introvabili. Da lì l’intuizione di una casa editrice milanese di creare uno dei brand più popolari degli ultimi tempi. Un altro esempio: qualche mese fa la casa di moda Burberry ha prodotto un’edizione di lusso dei romanzi di Chatwin, illustrati a mano e dal costo esorbitante. Un anniversario? Una commemorazione speciale? No. Il nome di Chatwin, a quanto pare, è sufficiente.
Nel 1985, dieci anni dopo quel celebre telegramma e quattro anni prima di morire, Chatwin non può immaginare niente di tutto questo. È appena arrivato per la seconda volta in Australia e sta scrivendo quello che rappresenta, con tutta probabilità, il suo capolavoro. Un’opera immensa, alla quale l’autore ha lavorato furiosamente per anni interi. «Suppongo sia un romanzo», dice al suo agente, Tom Maschler, «sebbene un tipo di romanzo molto strano». Oggi non avremmo nessun problema a definire quel “romanzo”, Le vie dei canti, una non-fiction. Ma per Chatwin questa catalogazione era tutt’altro che scontata. La questione della forma l’aveva assillato a lungo. L’idea originale era quella di imbastire il libro come una lettera fittizia inviata al suo editore italiano, Roberto Calasso, con il titolo provvisorio di Lettera da Marble Bar (la più calda cittadina australiana). Scartata questa ipotesi, Chatwin accarezzò la possibilità di scrivere un dialogo filosofico che avesse per titolo Of the nomads, “Sui nomadi”.
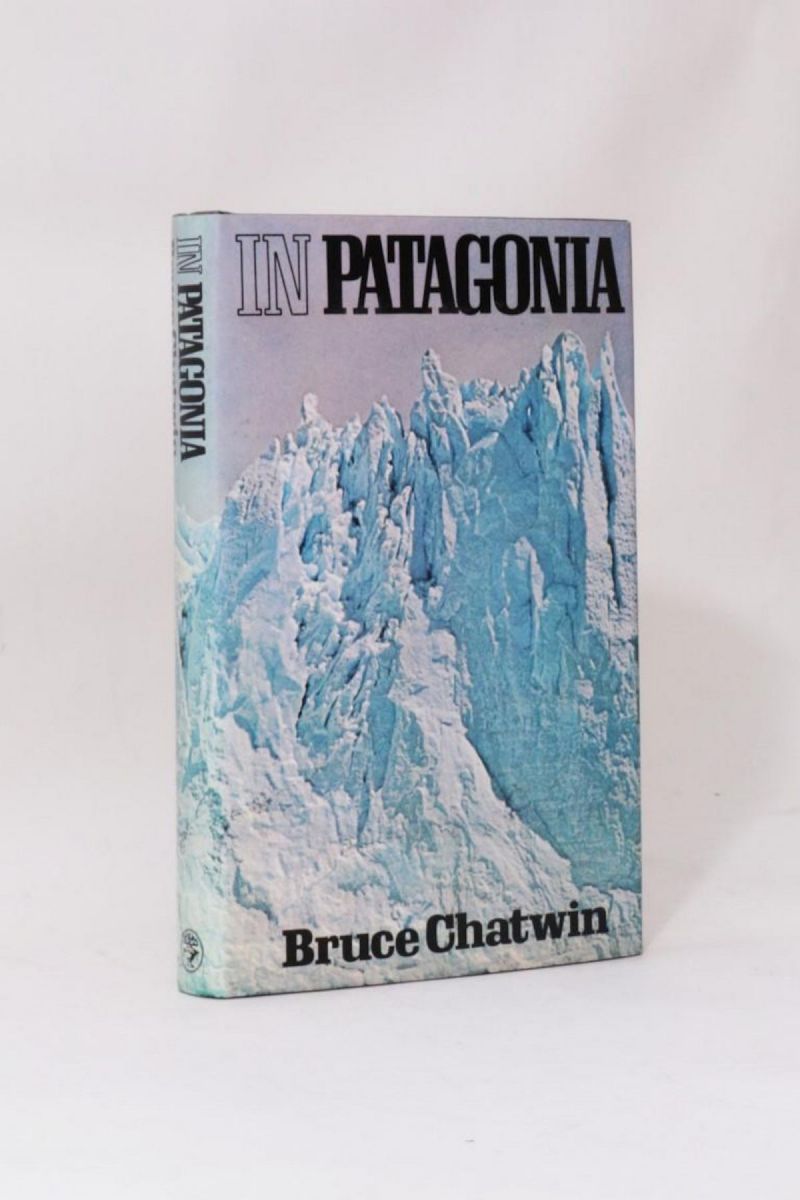
Dalla metà degli anni Sessanta, l’autore aveva lavorato ininterrottamente a un libro sul nomadismo. Dopo anni di riscritture, L’alternativa nomade era stato giudicato “impubblicabile” anche dallo stesso Chatwin, che aveva bruciato il manoscritto, ma aveva conservato i suoi taccuini di appunti. Ora, ai piedi del Monte Liebler, dentro una roulotte prestatagli da un amico, Chatwin cerca di mettere ordine alle citazioni, agli aneddoti e ai resoconti di anni di letture e peregrinazioni fissate sulle pagine a quadretti dei suoi celebri carnet Moleskine.
Avevo il presentimento che la fase ‘itinerante’ della mia vita si sarebbe presto conclusa. Prima che si insinuasse dentro di me il malessere della sedentarietà, pensai, dovevo riaprire questi taccuini. Dovevo mettere sulla carta un riassunto delle idee, delle citazioni e degli incontri che mi avevano divertito, che mi tornavano in mente spesso e che speravo avrebbero fatto luce su quello che per me è l’interrogativo primo: qual è la natura dell’inquietudine umana?
Chatwin si domanda se «l’orrore del domicilio» di cui scriveva Baudelaire, non rappresenti, per gli esseri umani, ciò che resta di un remoto impulso migratorio, un istinto «affine a quello degli uccelli in autunno». Per dimostrare questa intuizione, lo scrittore delinea nel suo libro un affresco immenso, dove le storie di tutti i suoi viaggi, ogni racconto, episodio o conversazione, rappresentano una prova indiziaria a sostegno della sua tesi. E cioè che l’uomo è nato per viaggiare: «La selezione naturale ci ha foggiati – dalla struttura delle cellule cerebrali alla struttura dell’alluce – per una vita di viaggi stagionali a piedi in una torrida distesa di rovi o di deserto».
Detto così, senza aver letto le quasi quattrocento pagine che compongono Le vie dei canti, l’ipotesi può sembrare «pazzerella» (è la parola usata da Salman Rushdie in una critica del libro). Sarà utile fare qualche esempio, partendo da un assunto universale: in principio, tutti gli esseri umani erano nomadi. Che fosse cacciatore, raccoglitore di cibo o pastore, per migliaia di anni l’homo sapiens ha vagato sulla Terra seguendo dei percorsi di migrazione, proprio come gli animali.
L’agricoltura, invece, è un’invenzione relativamente recente, risalente all’8000, forse 8500 a.C. Gli storici la chiamano rivoluzione neolitica, la prima delle “rivoluzioni agricole”, durante le quali gruppi di agricoltori stanziali uccisero, assoggettarono o scacciarono cacciatori e pastori nomadi. «Un’apocalittica migrazione di popoli in cui contadini invasori spazzarono via i cacciatori-raccoglitori indigeni», scrive lo scienziato Jared Diamond in Armi, acciaio e malattie, che nel 1998 gli è valso il premio Pulitzer. Diamond, nei primi capitoli del suo libro, stabilisce in maniera inequivocabile la filiazione tra nascita dell’agricoltura e guerre di conquista, confermando indirettamente le intuizioni avute da Bruce Chatwin.
Gran parte dell’opera di Chatwin può essere letta come una serie di variazioni su un’idea fissa. Del resto, lo spirito nomade sembrava avercelo nel sangue. Figlio di un marinaio inglese dagli occhi azzurrissimi (come un altro avventuriero, Corto Maltese), Chatwin ha descritto più volte la «fantastica sradicatezza» dei suoi primi anni di vita.
I tempi mi comunicavano tutta la loro frenetica agitazione: il fischio del vapore in una stazione avvolta nella nebbia; il duplice colpo delle porte dei vagoni che si chiudono; il ronzio degli aeroplani, i riflettori, le sirene; il suono di un’armonica su un marciapiede di soldati addormentati.
La sua casa, durante tutta la Seconda guerra mondiale (era nato nel 1940), era stata una grossa valigia nera. Quando non era in braccio a sua madre, in giro per le stazioni e i porti della Gran Bretagna tartassata dai bombardamenti nazisti, viveva dalle sue zie a Stratford-on-Avon, la cittadina natale di Shakespeare. Lì era cresciuto ascoltando le storie dei parenti di suo padre, «vagabondi innamorati dell’orizzonte che avevano sparso le loro ossa in ogni angolo del globo». Aveva anche imparato che il suo cognome deriva dalla parola anglosassone Chette-wynde, “sentiero tortuoso” o “cammino serpeggiante”. «Cominciò a germinare nella mia testa l’idea che tra la poesia, il mio nome e la strada ci fosse un nesso misterioso», scrive nelle prime pagine de Le vie dei canti, dove racconta delle sue passeggiate shakespeariane in compagnia delle zie.
Narratore di favole, Chatwin lo fu fin da bambino. «In collegio», confessa, «avevo la mania degli atlanti e venivo regolarmente messo al bando per le storie incredibili che raccontavo». In Under the sun, la raccolta di lettere curata dal biografo Nicholas Shakespeare e dalla vedova di Chatwin, Elizabeth, quest’ultima smentisce affermazioni e racconti del marito, soprattutto nelle note a margine. Leggendole, vengono in mente le correzioni fatte dal figlio di Barney Panofsky in La versione di Barney. La vicenda ha avuto una certa eco (se n’è parlato anche qui da noi) e ha rappresentato un’occasione ghiotta per i detrattori di Chatwin, che a quanto pare abbondano in Inghilterra. Ma quest’ultimo non ha mai nascosto che raccontare storie è sempre stata «l’unica occupazione concepibile per una persona superflua come me». La lettera, dopotutto, è un genere letterario come un altro; il grado di verosimiglianza lo sceglie l’autore. Nella prefazione alla raccolta Che ci faccio qui?, l’ultimo libro pubblicato mentre era ancora in vita, ci teneva a specificare che i suoi erano racconti, poiché «per quanto la narrazione possa avvicinarsi ai fatti, c’è stato un intervento della fantasia».
Bruce ed Elizabeth si erano conosciuti alla casa d’aste Sotheby’s di Londra, dove un Chatwin appena diciottenne aveva cominciato a lavorare come fattorino. Il loro matrimonio aveva sconvolto amici e parenti; americana di buona famiglia lei, inglese bisessuale e mezzo spiantato lui, i due sembravano incompatibili. Ma erano compagni di viaggio e condividevano tante passioni. A Sotheby’s, nel giro di poco di tempo, Chatwin aveva fatto carriera, riuscendo a diventare esperto di quadri impressionisti e antichità greco-romane. Eppure il lavoro non lo entusiasmava. L’atmosfera del mondo dell’arte gli sembrava simile a quella di un obitorio.
Una mattina del 1965 si svegliò e scoprì di essere cieco. Dopo qualche ora riacquistò la vista dall’occhio sinistro, ma il destro rimase offuscato. Un oculista lo rassicurò, non si trattava di un danno organico, piuttosto era una reazione psicosomatica. «Forse ha guardato i quadri troppo da vicino», gli disse. «Perché non prova con i vasti orizzonti? Magari in Africa». Il futuro scrittore non se lo fece ripetere due volte. Andò in Sudan, dove rimase parecchie settimane. Arrivato all’aeroporto di Khartoum gli occhi erano già guariti. Ingaggiò una guida, un cacciatore nomade della tribù Beja, che lo fece sentire «sovraccarico» e «inadeguato». Si fece accompagnare nel deserto.
Di notte, mentre vegliavo sotto le stelle, le città dell’Occidente mi parevano tristi e aliene, e le pretese del mondo dell’arte assolutamente idiote. Qui invece avevo la sensazione di essere tornato a casa.
L’alternativa nomade si è già impossessata di lui. Al suo rientro in Inghilterra lasciò il lavoro, si iscrisse ad archeologia all’università di Edimburgo, ma qualche tempo dopo abbandonò gli studi. «Il cambiamento», scrisse in quel periodo a un amico, «è l’unica cosa per cui valga la pena vivere». Iniziò a collaborare al Sunday Times e nel frattempo cominciò a prendere forma l’idea di scrivere un libro su quello che aveva visto in Africa. «Una sorta di ‘Anatomia dell’irrequietezza’ imbastita intorno al detto di Pascal sullo starsene quieti nella propria stanzetta». È il nucleo dello studio sui nomadi, il libro «impubblicabile» che finirà per essere incluso in Le vie dei canti.
Vent’anni dopo, nel 1985, in quella roulotte perduta in mezzo all’Australia, il suo viaggio è quasi giunto alla fine. Chatwin è gravemente malato. La diagnosi finale (Aids) arriverà solo l’anno successivo, ma lo scrittore sa già che non gli resta molto da vivere. Cerca di convincere i suoi famigliari – e forse anche se stesso – di aver preso una strana forma di malaria africana. Anzi no, un fungo, un rarissimo fungo del midollo spinale, contratto durante il suo ultimo viaggio in Cina. Il vizio di raccontar(si) storie è duro a morire. Chatwin tenta il tutto per tutto: finirà il libro e poi si consegnerà ai medici.
Gli diedi una forma leggibile nell’afa di quei giorni estivi, avvolto in scialli, rabbrividendo di freddo davanti al forno acceso della cucina. Fu una corsa contro il tempo.
L’impresa riesce e il libro viene pubblicato nel giugno del 1987, diventando immediatamente un best-seller. Le vie dei canti vende talmente bene da mettere in crisi il suo autore. «Sono entrato, dopotutto, nel novero degli scrittori da buttare?», si domanda qualche mese prima di morire. Muore a Nizza il 18 gennaio 1989.
Oggi, a quarant’anni esatti dal suo primo viaggio in Patagonia, Bruce Chatwin, lo scrittore ucciso dal marketing, l’inflazionato autore di libri di viaggi, è finalmente passato di moda. Il momento è propizio, quindi, per poterlo leggere e rileggere. Adesso c’è solo bisogno che una nuova generazione di lettori scopra il valore di questo straordinario narratore di favole.

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.