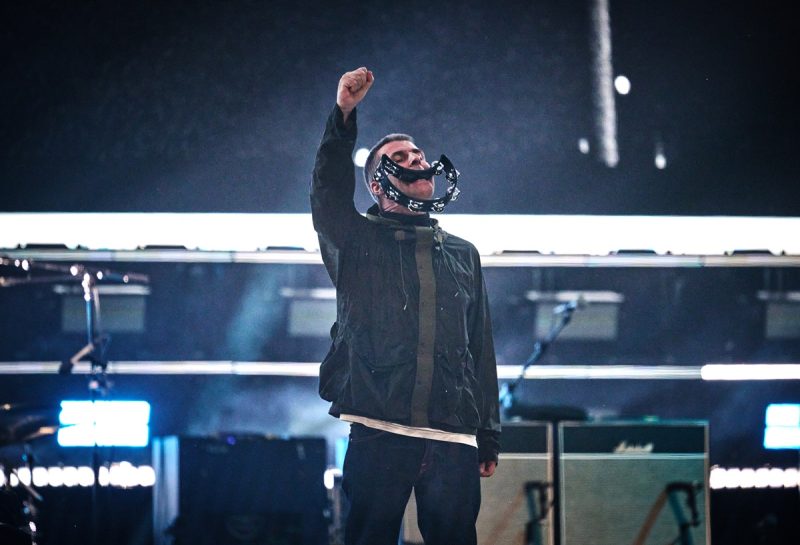Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Per Radu Jude fare cinema è fare casino
Dal numero di Rivista Studio in edicola, intervista al regista di Non aspettarti troppo dalla fine del mondo, il film che, come ha scritto il New York Times, «ha portato al cinema il caos di TikTok».

Radu Jude potrebbe essere uno dei personaggi di Non aspettarti troppo dalla fine del mondo, il suo ultimo film (in Italia è uscito il 14 novembre), apprezzatissimo nel circuito dei festival e recensito benissimo praticamente da tutti. Jude parla proprio come i suoi personaggi: tanto e velocemente, ama le digressioni e gli aneddoti buffi, i collegamenti spericolati e le intuizioni improvvise. Durante questa intervista, la parola che gli ho sentito ripetere più spesso è “montaggio”. La sua mente, dice, funziona come una sala montaggio. Una convinzione che, chi l’ha visto lo sa, spiega perfettamente quel film assurdo ed entusiasmante che è Non aspettarti troppo dalla fine del mondo.
ⓢ Dopo la vittoria al Festival di Locarno, del tuo film si è parlato come di una sorta di unicorno: un film estremo, autoriale, stranissimo, underground che vince uno dei premi più prestigiosi che ci siano. Questo tipo di cinema non è morto, allora, ho letto in tante recensioni di Non aspettarti troppo dalla fine del mondo. Ti ritrovi in queste descrizioni?
Oggi tutti piangono la morte del cinema, che sia mainstream, commerciale, indipendente, underground. Secondo me, quelli che piangono sono degli egocentrici che pensano al loro cinema soltanto. Io sono rumeno, quindi ti parlo della Romania: per noi negli anni ’90 era quasi impossibile riuscire a vedere, e quindi discutere, un film indie americano. Con questo voglio dirti che nella mia parte di mondo non si sono mai visti e discussi così tanti film, e così diversi tra loro. Quindi il cinema è morto dappertutto tranne che da noi? Non credo. Certo qualcosa il cinema lo ha perso per strada, in questi anni. Ma è inevitabile, qualsiasi processo prevede la perdita. Recentemente mi sono trovato a chiacchierare con un maestro del cinema rumeno, ha 65 anni, non ti dirò chi è. E mi ha detto che secondo lui il cinema è morto nel momento in cui chiunque si è ritrovato in tasca una cinepresa e si è messo a riprendere. E io gli ho chiesto: “Ma non pensi sia una cosa grandiosa, questa?”. Quindi questa è la mia risposta alla tua domanda: il cinema è più vivo che mai, solo che non è la stessa cosa alla quale siamo abituati a pensare quando pensiamo al cinema.
ⓢ Parliamo del film. È effettivamente uno dei più strani che abbia mai visto, anche solo dal punto di vista formale. È una specie di film-mostro, un Frankenstein assemblato con pezzi di corpi diversi. La prima parte è una cosa tra il road movie e il cinema verità, il racconto dell’estenuante giornata di una videomaker lungo le letali strade rumene. La seconda è una specie di mockumentary-fiction sulla pubblicità progresso. Sparsi qua e là ci sono video TikTok e spezzoni di un vecchio film rumeno, Angela va avanti. Come t’è venuta in mente tutta questa roba e come hai capito che poteva tutta stare in un film solo?
Innanzitutto sono partito da esperienze personali. All’inizio della mia carriera ho fatto un sacco di lavori per gli studios rumeni, adesso quei lavori li definirei sfruttamento ma all’epoca… Non ero abbastanza consapevole, ero giovanissimo ed ero innamorato del cinema ed estasiato all’idea di lavorare nel settore. Poi mi sono messo a lavorare per la televisione, ho fatto pubblicità. In quel periodo venni a sapere di un ragazzo, un assistente di produzione, morto in un incidente stradale: per giorni aveva detto ai suoi capi che era stanco e loro gli avevano risposto “prenditi un altro caffè, beviti un’altra RedBull”. Alla fine di un turno di 16 ore ha fatto l’incidente ed è morto e nessuno è stato condannato. Fondamentalmente il film comincia da qui e prosegue così. Sono tutte idee “vecchie”, che ho raccolto e conservato, alcune risalgono a 20 anni fa. A me serve sempre tempo per capire che una cosa che mi è capitata o una persona che ho incontrato nel passato non erano soltanto un aneddoto ma un’anticipazione di quello che sarebbe venuto in futuro.
ⓢ Pensi sia per questo che il film ha toccato così profondamente le persone che lo hanno visto? Tutti quelli con cui ne ho parlato si sono detti divertiti, sfiancati o infuriati, al termine della visione. Viene dal fatto che è basato su pezzi della tua biografia, che racconti cose reali, vere?
Questa convinzione che il bollino di “fatto realmente accaduto” renda un’opera un contenitore di verità, io non ci credo. Una storia è tale non se è vera ma se è rilevante. Ogni immagine può essere presentata sia come documento che come finzione e mantenere intatto il suo significato. Ma mi rendo conto che ormai viviamo in un mondo in cui distinguere tra queste due cose è difficilissimo. È una questione di fiducia, che se ci pensi è la questione fondamentale della nostra epoca: quanto e come e perché ci fidiamo di una “fonte”. Se non affrontiamo il tema della fiducia, continueremo a vivere in questo mondo dominato dalla propaganda, in cui basta presentare un documento come finzione per farlo diventare finzione, e una finzione come documento per farla diventare documento.
ⓢ L’immagine può essere documento o finzione, documento e finzione. Tu, allora, come ti definisci? Un regista “documentarista”, un regista di fiction, uno che sta al confine tra questi?
Credo esistano due tipi di regista. Il primo: il regista preoccupato dalla purezza, dal rispetto nei confronti del linguaggio-cinema. Il secondo tipo: il regista “casinista”, che lavora di collage e di montage, che “cuce” assieme regie di altri. Godard, Welles, Rossellini, quest’ultimo tra l’altro è stato la mia principale ispirazione per Non aspettarti troppo dalla fine del mondo. Che infatti è un film-collage, composto da storie, estetiche, consistenze, linee temporali diverse. Anche perché la mia mente funziona come un collage. Quando ho iniziato a lavorarci, sono partito dalla seconda parte del film. Quella che poi è diventata la prima parte era in realtà un altro progetto al quale stavo lavorando, e a un certo punto ho deciso di cucirle assieme perché pensavo raccontassero ognuna una metà dello stesso mondo. Dopodiché ho scelto come protagonista Ilinca Manolache, e mi sono ricordato di questo avatar TikTok, questo Bobita (una sorta di versione degenerata, se possibile, di Andrew Tate, nda), che lei aveva creato durante la pandemia, e ci ho messo dentro anche quello. Poi ho rivisto, per caso, Angela va avanti e mi sono detto: perché non provare a fare questo supermontaggio, e vedere come lo stesso punto nello spazio – una donna in una macchina per le strade della Romania – viene rappresentato in diversi punti del continuum temporale? E se questo non ti sembra casinista abbastanza, ora ti dico come scrivo i dialoghi. In realtà io non li scrivo, li colleziono: ho un’assurda quantità di citazioni che prendo da libri, foto, film, meme, barzellette, migliaia e migliaia di pagine, dalle quali di volta in volta estraggo quello che credo mi torni utile per un film.
ⓢ Da quello che mi hai detto, mi pare di capire che le definizioni di cinema d’essai e di regista underground non ti convincano.
Per me qualunque artista, ma in realtà chiunque faccia qualsiasi cosa, lo fa per il mondo intero. Sono sicuro che anche voi che fate la rivista vorreste che fosse letta da tutto il mondo. Io questo film lo offro a tutti, anche se so che la maggior parte delle persone lo rifiuterà. Non è un problema, questo, per me. Però ci tengo a dirlo perché in Romania sono considerato un elitario, uno che fa film per alcuni e non per tutti. Ma non è così. Sai, come ti dicevo, in passato ho lavorato per la tv, per una delle più grandi emittenti private rumene. Un giorno ebbi questa discussione con un dirigente, che mi accusava di voler fare “programmi intelligenti”. E che c’è di male, gli risposi. C’è di male che noi facciamo i programmi per il pubblico, mi disse lui. Ma io mi rifiuto di considerare stupido il prossimo. Ecco perché non mi piacciono tanto le definizioni come indipendente e commerciale, mainstream e underground: perché spesso servono a definire, innalzandolo o svilendolo, il pubblico, non le opere.
ⓢ Perché hai deciso di inserire un “film nel film”? Guardandolo, mi è quasi sembrato che tu abbia usato Angela va avanti, un film di 40 anni fa infuso di una certa tenerezza e limitato dalla censura, per stemperare la brutalità di Non aspettarti troppo dalla fine del mondo.
È vero, di primo acchito il film sembra anche questo: un riflessione su un presente brutale e il ricordo di un passato non così brutale. Ma poi penso sia inevitabile capire qual è la tesi del film, cioè che tutti i film non sono la realtà ma, nella migliore delle ipotesi, una rappresentazione della realtà realizzata in un regime che può essere politico, sociale, personale. Il presente è brutale, e hai ragione, ma la brutalità è uno degli attributi dell’onestà. Uno sguardo onesto sul mondo restituisce sempre un’immagine brutale. Angela va avanti è un film tenero, è vero, ma realizzato in un’epoca assai più brutale della nostra. Ma non si vede, quella brutalità, perché, appunto, tutti i film sono rappresentazione, e quella rappresentazione era anche conseguenza della censura. È proprio per questo che ho voluto inserirlo nel mio, di film: per creare questa dialettica e spingere le persone a contemplare il fatto che ogni immagine è una messa in scena e che la cosa più importante da sapere è cosa, e chi, c’è nel retroscena.
ⓢ È uno sguardo da indagine storica, questo, più che da opera cinematografica.
Io guardo anche al presente come fosse storia, mi piace riprendere le cose come fossero già storia. Mi viene sempre in mente Balzac quando diceva che voleva essere lo storico della Francia contemporanea. Non diceva di voler raccontare storie ma la storia, capisci? La mia ambizione è un po’ questa: avere la capacità di guardarmi attorno e capire quale delle cose che stanno succedendo adesso avrà importanza anche nel futuro. E poi a me il passato interessa perché tutti viviamo questo rapporto dialettico con il passato, no? Secondo me è molto più vero che il presente cambia il modo in cui vediamo il passato che il passato dà forma al presente che viviamo. Il passato cambia in continuazione.
ⓢ Il tuo è stato definito il primo film influenzato da TikTok. Sei d’accordo? E che rapporto hai con i social?
So benissimo che i social possono essere un posto pericoloso, che standoci dentro perdiamo l’innocenza e la privacy. Ma so anche che sono parte di questo mondo e che custodiscono un potenziale immenso. Io li vedo come una forma di cinema vernacolare, dire quasi primordiale, inteso come mescolanza di testo e immagine. Quando faccio questo discorso alle persone mi viene sempre risposto che se i social sono davvero un mezzo di espressione, sono primitivi, grezzi. Ma certo, anche il cinema all’inizio era primitivo, grezzo. Io ci credo davvero nella possibilità che TikTok, Instagram, possano ancora diventare strumenti artistici.
ⓢ Dei social, nel film, si ritrova quell’atteggiamento “niente è sacro, tutto è profano”. E anche profanabile: è un’opera che fa un amplissimo uso della volgarità e del black humor. Visti i tempi in cui viviamo, non hai paura di essere frainteso, di rischiare la cancellazione?
Vedi, io non ho una vera e propria opinione sul politicamente corretto. Vado caso per caso, e certe volte penso che essere politicamente corretti sia sacrosanto e altre volte penso sia una stronzata. Forse è questa la mia risposta alla tua domanda sull’underground: se underground lo consideriamo un sinonimo di estremo, di provocazione, allora penso che la ragione per cui ci sembra diminuito o addirittura scomparso è che non vogliamo più avere rapporti con l’estremità, non ci piace più essere provocati. Personalmente, voglio essere un artista, ma in generale una persona, allo stesso tempo progressista e contraddittorio. Credo che il mio lavoro non consista nell’accettare un’ideologia ma nello scovare contraddizioni, anche nell’ideologia alla quale decido di aderire. Perché se non fai questo allora non sei un artista, non fai arte. Fai propaganda.
Questa intervista è tratta dal nuovo numero di Rivista Studio si intitola “Digital Underground“, chetrovate in edicola e sul nostro store (qui). Se la rivista vi piace e volete abbonarvi, potete farlo andando qui.