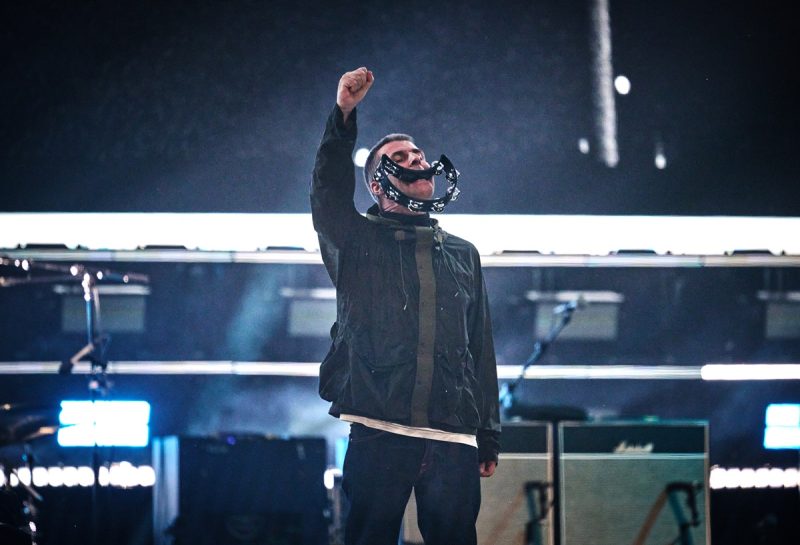Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Mitski e la musica per soffrire
Il suo nuovo album, Laurel Hell, arriva dopo una crisi in cui aveva deciso di abbandonare per sempre la carriera musicale: per fortuna ha cambiato idea.

L’hanno dimostrato Blanco e Mahmood a Sanremo con “Brividi”: la musica più potente è quella che fa soffrire. Gli artisti che amiamo di più sono quelli che possiamo sfruttare come colonna sonora del nostro struggimento. Il nuovo album di Mitski, esperta creatrice di musica per stare male, richiama alla mente immagini dantesche: si chiama Laurel Hell, inferno d’alloro, come vengono chiamate le pericolose distese d’alloro che si trovano sugli Appalachi meridionali. «I fiori sono splendidi, simili a dei piccoli rododendri, ma le piante sono velenose, hanno radici basse e intrecciate impossibili da superare», spiega lei nelle interviste. Alla fine del video di “Working for the Knife”, dopo aver bighellonato all’interno di un auditorium brutalista ed essersi liberata della sua divisa da cowboy – un modo per esprimere il suo rifiuto nei confronti di Be the Cowboy, l’album precedente, quello del successo mainstream – e dopo essersi dimenata sul palco come impazzita, un po’ sensuale un po’ disperata, davanti agli applausi immaginari di un pubblico che non c’è, in pantalone di seta e reggiseno rosso (niente più musica, si sente soltanto lei che ansima), si sdraia per terra esausta. Parlando con Rolling Stone, descrive così quella scena: «Io sono questa… continuerò a farmi male e non smetterò, perché non so fare nient’altro». In un’altra intervista, si lamenta del nuovo album: «Come ci si sente a pubblicare di nuovo un disco? È terribile. Assolutamente terribile. Mi sono sentita tipo “Oh Gesù, ci risiamo”. Pensavo di divertirmi e invece adesso non è più divertente». L’ostinata intensità con cui Mitski continua a detestare il successo ricorda quella di Alice, la scrittrice protagonista dell’ultimo romanzo di Sally Rooney, Beautiful World Where Are You, un personaggio che rispecchia le posizioni della stessa autrice nei confronti della fama (ne aveva parlato con noi già nel 2019, qui).
Nel 2019 Mitski aveva annunciato che l’ultima data del tour sarebbe stata la sua esibizione finale, il momento dell’addio. Era l’8 settembre, il festival Summerstage a Central Park era sold out. I suoi fan, particolarmente morbosi (basta guardare i commenti ai video: alcuni la chiamano “mamma”, altri “dio”, alcuni la trattano come una martire che si auto-condanna ad essere triste per poter continuare a fare musica triste) impazzirono e cominciarono a riversare sui social la loro disperazione. «Temo che, se non riuscissi a staccare un po’ al più presto, la mia identità e il mio benessere comincerebbero a dipendere troppo dalla mia carriera, dall’essere sempre in gioco», rispose lei su Twitter. E dopo aver aggiunto: «È ora di essere di nuovo umana» si cancellò da tutti i social.
Social sui quali Mitski, suo malgrado, ha sempre riscosso un certo successo. All’inizio della sua carriera li usava con una generosità e una naturalezza che, una volta persa, non ha più saputo (o voluto) riconquistare: l’attenzione che ricevevano certi suoi post ha inibito per sempre la sua spontaneità. In un’intervista pubblicata dal Guardian qualche giorno fa, si è definita un «buco nero in cui le persone sentono di poter scaricare tutta la loro merda, che sia bisogno di amore, odio o rabbia…». I suoi tentativi di sparire dai social e liberarsi dall’ammorbo di fan troppo appiccicosi si sono rivelati vani. Alcuni suoi singoli del 2018 come “Nobody” e “Washing Machine Heart” sono diventati virali su TikTok e lei – di nuovo suo malgrado – è stata incoronata la queen delle “sad girl”, una specie di sorella grande di Billie Eilish, ritrovandosi a fare da sottofondo ai video di quindicenni in lacrime.
Dopo quel famoso concerto a Central Park, Mitski ha lasciato New York e si è trasferita a Nashville per rifarsi una vita. Proprio in quel momento è esplosa la pandemia. Chiusa in casa senza uno scopo, ha iniziato a soffrire: «Ero piena di rimpianto e dolore perché pensavo che forse avevo commesso un grosso errore», racconta. «Avevo lavorato così duramente per arrivare a quel punto della mia carriera e stavo buttando via tutto». Di quel periodo ricorda che trovava impossibile ascoltare la musica di altre persone, o persino guardare un film, senza piangere. A un certo punto deve anche essersi resa conto di avere un obbligo contrattuale con la sua etichetta, la Dead Oceans. E allora, dopo aver fatto mille scene da drama queen dicendo addio al mondo della musica, ecco il nuovo album: su Slate Carl Wilson ha dato un’ottima definizione di queste 11 canzoni: secondo lui funzionano come «la famosa illusione della figura ambigua del coniglio-anatra, come è stato spesso il caso nel lavoro di Mitski: a seconda di come le si ascolta possono parlare del dolore romantico o dell’agonia di una vita pubblica creativa». In entrambi i casi, si soffre.
Leggendo le settemila interviste uscite per lanciare l’album e il tono grave con cui Mitski non fa che parlare della sua crisi, non ho potuto fare a meno di pensare al bellissimo mockumentary del 2010 con Joacquin Phoenix, I’m Still Here. Il film, diretto da Casey Affleck, racconta la vita dell’attore Joaquin Phoenix a partire dal momento in cui, evidentemente vicino all’apice del successo, annuncia la decisione di abbandonare per sempre la carriera cinematografica. Stufo di essere «il burattino dei registi», Phoenix decide di darsi all’hip hop, con ovvi risultati (volontariamente involontariamente) comici. Durante tutto il periodo delle riprese l’attore rimane nel personaggio, sia in privato che nelle apparizioni in pubblico, compresa la famosa intervista con David Letterman, che poi viene inclusa nel film. Non credo sia il caso di Mitski, il suo momento di crisi spirituale e creativa è sicuramente autentico e soprattutto, come dimostrano i bellissimi video che accompagnano l’album (“Stay Soft” è forse il migliore: primo commento «grazie a dio Mitski ha inventato la musica») non ha intaccato il suo aspetto fisico né la sua igiene personale. C’è qualcosa che accomuna questi due artisti tormentati, però: il mix di empatia e repulsione che suscitano. Perché se da una parte soffrire le pene dell’inferno per la propria crisi artistica è un privilegio, dall’altra è confortante sapere che esistono dei grandi artisti che non fanno altro che lamentarsi del loro lavoro, proprio come noi, persone normali.