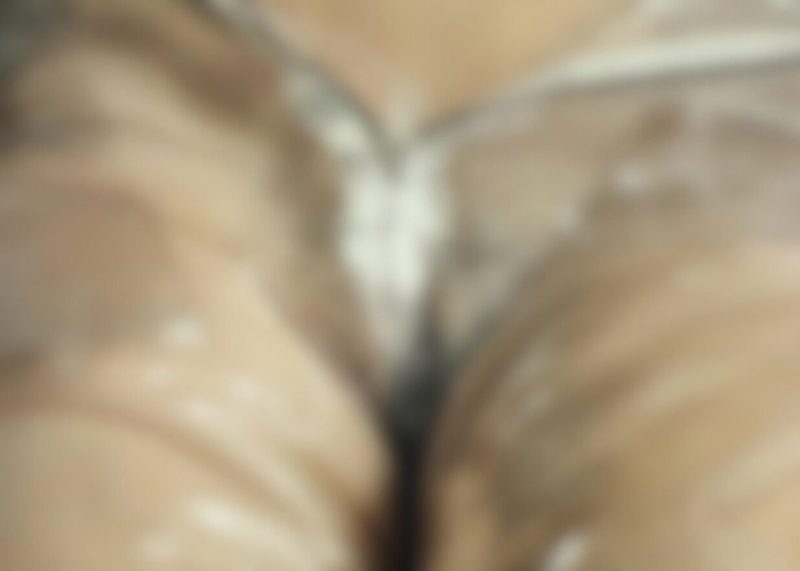Prende ispirazione da una giacca cult indossata da Liam, quella di Berghaus, di cui è volto pubblicitario.
“La parte croccante di una lasagna”. “Oops! Mi è caduta la crostata al limone”. “Un’anguilla che risale il fiume Po”. “Ricordo di un panino alla mortadella”. “La patata che voleva essere un tartufo”. La lingua che parla Massimo Bottura sta lì ad accarezzare la vanità degli iniziati – io so, io ho assaggiato, io sono membro devoto del culto – e seduce tutti gli altri.
Perché quelle parole messe così in fila fanno l’effetto, anche a chi non le ha mai sentite prima, di una pesca a strascico dentro una storia italiana che appartiene a tutti. Una storia che racconta la cucina della nonna e le madeleine di provincia, il successo ma ancora di più gli inizi, le ambizioni, gli errori, i sogni, i ricordi e il futuro mischiati insieme. Lui le parole sembra scriverle su una lavagna di scuola, mentre parla senza tenere ferme le mani. Le sceglie una per una, e consapevolmente non smentisce quello che la vulgata ha deciso: è il più colto dei cuochi in circolazione, è lo chef intellettuale, è il saggista del foie gras, il filologo del bollito (no: del bollito non bollito, sempre secondo il lessico botturiano). Un po’ in questo profilo ci sguazza, un po’ sta sempre lì a ricordarti da dove viene, la fiera origine locale, il chilometro zero senza bisogno di certificarlo, ti dice che è un uomo fatto dei portici di Modena, dei sapori della cucina economica, dei rapporti di buon vicinato, del fiume che sta a due passi, della pianura tutta attorno.

Il giorno che Massimo Bottura apre a Studio la porta del suo ufficio, nell’isolato subito dietro la targa dorata con incise le parole magiche «Osteria Francescana», è già successo quel che doveva inevitabilmente succedere: il World’s 50 Best Restaurants ha stabilito che il suo ristorante è il migliore del mondo, dunque lui il miglior cuoco, non si sbaglia. Ha appuntato la medaglia d’oro qui, nella profetica via Stella (tre quelle Michelin raccolte in precedenza), dietro questa porta che nemmeno ti accorgi cosa nasconde, anche se tutti sanno. (Sanno con discrezione di paese: arrivando qui a piedi, ho chiesto indicazioni ai passanti. Ciascuno faceva intendere che sì, naturalmente so dov’è «l’Osteria», e però al tempo stesso preferiva lasciare il dubbio, dirlo a bassa voce, quasi a non farsi sentire.) Il giorno che Massimo Bottura apre a Studio la porta del suo ufficio è quello che noi definiremmo di portata straordinaria, per lui invece è «ordinaria amministrazione». Una produttrice americana sta valutando dove girare una scena di Master of None, la serie Netflix di e con Aziz Ansari (il comico globale del momento, lui arriverà nel pomeriggio) che vede qui ambientata una puntata della seconda stagione: hype alle stelle, considerato il successo della prima. Qualche giorno più tardi è atteso Mark Zuckerberg prima del tour che passa da Palazzo Chigi e dal Vaticano: l’Osteria Francescana è il terzo lato naturale di questo triangolo di istituzioni italiane. La settimana successiva sarà la volta di capi di Stato che tengono in mano le sorti dell’Europa.
La prima parola che pronuncia Massimo Bottura, incalzato dai collaboratori con i loro aggiornamenti, è «paranoia». Può arrivare anche qui, in via Stella? «Non deve. La cosa fondamentale è vivere la quotidianità, anche se eccezionale, rimanendo ben piantati per terra. Però nella quotidianità non ci si deve perdere. Stare coi piedi per terra significa essere l’esempio per tutti i ragazzi che lavorano per te – e siamo quarantasei adesso – che si tratti di pulire la strada o di scegliere il pesce, di essere gentile coi vicini o di ridere e scherzare in via delle Rose, dove andiamo a giocare a calcio. Se non lo fai, perdi di vista il tuo obiettivo: creare una famiglia e soprattutto vivere dentro una famiglia. Ma nella quotidianità non puoi perderti: altrimenti entri in cucina e pensi che il tuo ruolo sia tagliare una carota, saltare una cipolla, spiattare un piatto. Il tuo ruolo invece è continuare a sognare, a immaginare quale sarà il tuo futuro. Se non lo fai, non riesci a capire che cosa verrà nei prossimi anni. E più il sogno è folle, più dici sarà impossibile, più ti rendi conto che puoi realizzarlo». La follia come tratto individuale, non più collettivo. «Oggi il problema, soprattutto in Italia, è che nessuno crede più nei propri sogni, o forse siamo rimasti in pochissimi a farlo. Abbiamo perso l’identità: è questa la nostra vera, enorme crisi, mica quella economica.
 Il punto è che nel tuo futuro devi sempre vedere futuro, noi invece abbiamo gli occhi al passato. Quel che è fatto è fatto, non è importante, non ci si può perdere nella nostalgia. È così che cerco di vivere ogni cosa. Per dire: so che ho costruito, anzi salvato, la scuola di agricoltura e preparazione al mondo del lavoro e della cucina di Castelfranco Emilia, ma questo è già successo. Ora penso che, a partire da quel progetto, posso creare un’università per i contadini e i cuochi del futuro. I primi potranno imparare a capire meglio i sapori, i secondi a ritrovare il contatto con la terra. Anzi, di più: sogno che il cuoco del futuro entri in cucina con le mani sporche di terra». Il Cuoco del Futuro è un’entità che sembra visitarlo spesso, mentre tu pensi di averlo già lì davanti a te. «La nostra forza motivazionale è l’arte, è la musica. È la cultura. L’ingrediente più importante per il cuoco del futuro è la cultura. È la cultura a permetterti di leggere il tuo passato in chiave critica e non nostalgica, meglio: che ti fa scindere il passato nelle sue parti migliori e nei momenti critici, per portare nel futuro il meglio di quello che è venuto prima. Che cosa facciamo ogni giorno? Comprimiamo dentro bocconi masticabili le nostre passioni. Billie Holiday nella mia testa è “Autumn in New York”, un piatto dove ho messo una mela, che poi è la Grande Mela. E poi c’è il poetico del sud dell’Italia. C’è “Working Class Hero” di John Lennon. Tutto dipende da dove vuoi andare, l’importante è che tu abbia la cultura per capire cosa stai facendo. Oggi ci perdiamo dentro i telefonini, io continuo a preferire i libri. Riadattando la battuta di Sergio Leone: quando un uomo con la cultura incontra un uomo col telefonino, il secondo è un uomo morto».
Il punto è che nel tuo futuro devi sempre vedere futuro, noi invece abbiamo gli occhi al passato. Quel che è fatto è fatto, non è importante, non ci si può perdere nella nostalgia. È così che cerco di vivere ogni cosa. Per dire: so che ho costruito, anzi salvato, la scuola di agricoltura e preparazione al mondo del lavoro e della cucina di Castelfranco Emilia, ma questo è già successo. Ora penso che, a partire da quel progetto, posso creare un’università per i contadini e i cuochi del futuro. I primi potranno imparare a capire meglio i sapori, i secondi a ritrovare il contatto con la terra. Anzi, di più: sogno che il cuoco del futuro entri in cucina con le mani sporche di terra». Il Cuoco del Futuro è un’entità che sembra visitarlo spesso, mentre tu pensi di averlo già lì davanti a te. «La nostra forza motivazionale è l’arte, è la musica. È la cultura. L’ingrediente più importante per il cuoco del futuro è la cultura. È la cultura a permetterti di leggere il tuo passato in chiave critica e non nostalgica, meglio: che ti fa scindere il passato nelle sue parti migliori e nei momenti critici, per portare nel futuro il meglio di quello che è venuto prima. Che cosa facciamo ogni giorno? Comprimiamo dentro bocconi masticabili le nostre passioni. Billie Holiday nella mia testa è “Autumn in New York”, un piatto dove ho messo una mela, che poi è la Grande Mela. E poi c’è il poetico del sud dell’Italia. C’è “Working Class Hero” di John Lennon. Tutto dipende da dove vuoi andare, l’importante è che tu abbia la cultura per capire cosa stai facendo. Oggi ci perdiamo dentro i telefonini, io continuo a preferire i libri. Riadattando la battuta di Sergio Leone: quando un uomo con la cultura incontra un uomo col telefonino, il secondo è un uomo morto».
Alle pareti dell’Osteria ci sono i piccioni di Maurizio Cattelan, i volti in bianco e nero di Francesco Vezzoli, i punti precisi di colore di Damien Hirst. «C’è quel tondo nero di Bosco Sodi, quello davanti a cui ho fatto la foto. Ecco, non è nient’altro che “L’urlo di Munch”, ma qui è la terra a chiedere aiuto, a urlare: attenzione, sto morendo. Poi c’è la grande fotografia di Elger Esser con il Po che esonda. Guardando il bicchiere mezzo pieno, pensi che sì, ha allagato tutte le campagne, ma ha anche rilasciato le sue acque, ha irrigato la terra, l’ha preparata per il raccolto dell’estate. L’arte ti può mostrare le due facce della stessa cosa: la terra che vive contro la terra arida, nera, arrabbiata, che chiede aiuto perché è sfruttata dalla chimica dell’uomo. Vale lo stesso per la storia della vacca bianca, che abbiamo vissuto in Emilia negli anni Sessanta. Si è deciso, nel giro di due anni, di raddoppiare la produzione. La scelta è stata quella di sostituire tutte le bianche di Modena, le rosse di Reggio e le brune di Parma, ma si è rivelata una scelta sbagliata. Nel momento in cui c’è crisi non conta la quantità, ma solo la qualità. Anche oggi. Per questo l’Osteria ha successo: è sulla qualità che abbiamo sempre lavorato. Poi raccogliamo quello che dobbiamo raccogliere». Siano anche gli attestati di miglior ristorante del mondo. «I premi sono solo una parte del percorso, a patto che tu riesca a mettere a frutto quel poco di talento che hai. Di base c’è solo il duro lavoro. La tv mostra storie che servono a un format, a un’idea di narrazione. Forse ci sono anche nella realtà chef che prediligono un approccio violento nelle loro cucine, io di sicuro non sono tra quelli. Per me la cucina resterà sempre un gesto d’amore, ragazzini di diciotto anni che ti dedicano la loro vita non possono essere aggrediti o violentati in quel modo. La cucina è il luogo dove si crea, non il luogo della violenza. L’importante è avere chiara la direzione, altrimenti non riesci a gestire i ritmi. L’approccio dev’essere, ecco, direi… visionario».
«Forse ci sono anche nella realtà chef che prediligono un approccio violento nelle loro cucine, io non sono tra quelli»
Mi levo la curiosità di chiedere allo chef che seleziona e appende l’arte contemporanea nel suo ristorante cosa pensa dell’equivoco secondo cui – sempre per colpa di certa tv – il lato artistico della cucina oggi si riassumerebbe in un termine: impiattamento. «Che parola orribile». Ecco, mi basta. Su «quel poco di talento che hai» però non son d’accordo. Non se a dirlo è il signor Bottura. «Vedi, il talento quando c’è viene sempre riconosciuto. Anche nei posti piccoli. Quando ho cominciato la gente mi prendeva per pazzo, ma sono sempre andato avanti per la mia strada. Anzi, mi piace pensare che a leggere oggi queste parole sia un ragazzo che ha il mio stesso sogno e che come me vive in una realtà di provincia. Quelli bravi alla fine vengono fuori, guarda solo a Modena: Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari». Lui non ci si mette, ma è come se. «È quando il talento non c’è che è inutile insistere. Mi hanno sfinito col presunto talento di uno che, a detta della sua famiglia, era un bravissimo jazzista, “È il nuovo Miles Davis”, “A fare il magazziniere è sprecato”. Alla fine mi son messo lì, l’ho ascoltato, e ho detto: fai cagare. Se voglio sentire Miles Davis, tiro fuori un disco di Miles Davis. Copiare non serve. Devi trovare il tuo talento, il tuo tratto».
Obiezione, maestro: non bisogna guardare al passato con sguardo nostalgico, ma come la mettiamo con le madeleine? Non si può non definire tale la parte croccante della lasagna, che Bottura bambino rubava dalla teglia della nonna. Né la crema di coniglio che ho mangiato qui un anno fa: sì, anch’io finisco col cedere alla sindrome del piccolo fan che vuole spacciarsi per iniziato al suo lessico, al suo culto. Nascosta dentro un macaron, produceva l’emozione che insegna il critico Auguste Gusteau di Ratatouille, un solo boccone ti faceva esplodere nella testa il coniglio della nonna (questa volta la mia), il profumo dell’olio extravergine, del rosmarino, dell’arrosto sbruciacchiato. «Hai capito tutto, non devo spiegarti niente. È come la storia del parmigiano reggiano, un progetto a cui abbiamo cominciato a pensare quando nessuno lo stagionava per più di ventiquattro mesi. In un solo piatto abbiamo messo la storia dell’Emilia degli ultimi vent’anni, a cominciare dal parmigiano con ventitré anni di stagionatura. Che oggi si sono messi a fare tutti». È come guardare Novecento di Bertolucci, azzardo. «Esattamente. Capisci: è anche per questo che da Modena non me ne andrò mai». Per questo e per la signora che passa in bicicletta e gli lancia un «Ciao Massimo, ti ho visto in tv, bravissimo!». Per Modena coi suoi motori fenomenali, come canta De Gregori. «Non ho mai voluto comprarmi l’auto grossa, quando la Maserati mi ha chiesto di guidarne una mi son posto il problema. In provincia non ti perdonano certe cose, uno subito pensa: ecco, vedi, ha fatto i soldi e si è comprato il macchinone. Poi ho detto sai che c’è, va bene così».
 Quel «ti ho visto in tv» della signora in bicicletta è riferito al RefettoRio, il progetto nato a Milano con Expo 2015 e finito nella città delle ultime Olimpiadi. Sulla scrivania c’è il logo di Food for Soul, la sezione umanitaria (detto male) dell’Osteria Francescana, un’altra ragione (detto meglio) per credere che sei davvero seduto – parlando all’indicativo presente – di fronte al cuoco del futuro. «Quando ho visto qual era il tema di Expo – “Nutrire il pianeta” – mi sono chiesto: che cosa posso fare io, io che faccio questo di mestiere, se non usare tutto quello che ho, anche gli scarti, per dare da mangiare a chi non ne ha? La risposta è stata fin troppo scontata, anzi mi stupisco sia arrivata da me e non dalla maggior parte dei padiglioni dell’esposizione. Quello degli Stati Uniti, che non si è filato nessuno, in realtà era uno dei più interessanti, con i suoi orti a parete che si muovevano e in base alla luce del sole facevano maturare frutti e ortaggi, che poi venivano raccolti. Un’idea che risponde alle premesse, e in fondo la stessa alla base del bellissimo Bosco Verticale di Milano. L’architettura, come la cultura, può decidere anche il futuro dell’alimentazione: pensa se domani tutte le città fossero fatte di grattacieli su cui poter coltivare».
Quel «ti ho visto in tv» della signora in bicicletta è riferito al RefettoRio, il progetto nato a Milano con Expo 2015 e finito nella città delle ultime Olimpiadi. Sulla scrivania c’è il logo di Food for Soul, la sezione umanitaria (detto male) dell’Osteria Francescana, un’altra ragione (detto meglio) per credere che sei davvero seduto – parlando all’indicativo presente – di fronte al cuoco del futuro. «Quando ho visto qual era il tema di Expo – “Nutrire il pianeta” – mi sono chiesto: che cosa posso fare io, io che faccio questo di mestiere, se non usare tutto quello che ho, anche gli scarti, per dare da mangiare a chi non ne ha? La risposta è stata fin troppo scontata, anzi mi stupisco sia arrivata da me e non dalla maggior parte dei padiglioni dell’esposizione. Quello degli Stati Uniti, che non si è filato nessuno, in realtà era uno dei più interessanti, con i suoi orti a parete che si muovevano e in base alla luce del sole facevano maturare frutti e ortaggi, che poi venivano raccolti. Un’idea che risponde alle premesse, e in fondo la stessa alla base del bellissimo Bosco Verticale di Milano. L’architettura, come la cultura, può decidere anche il futuro dell’alimentazione: pensa se domani tutte le città fossero fatte di grattacieli su cui poter coltivare».
Il Refettorio di Milano è stato l’unione di cucina, architettura, arte, «in un posto che era volutamente decentrato, non stava nel cuore della fiera. Lì ci ha detto di andare Papa Francesco, nelle periferie, dove c’è davvero bisogno». Il passaggio a Rio sembra naturale. «Siamo arrivati in una zona dove non c’era niente, baracche, topi, la povertà vera. Ci siamo messi a lavorare con un’organizzazione di San Paolo, la gente di Rio è più dispersiva, ha il sole, il mare, prende le cose come vengono, San Paolo rispetto a Rio è come dire Milano contro Roma. Il primo giorno, con la struttura pronta, scopro che mancavano gli attacchi dell’acqua, del gas, dell’elettricità. E allora abbiamo improvvisato. Ci siamo attaccati col tubo al palazzo di fianco, abbiamo preso bombole e generatori, ci siamo messi a cucinare. Mi rendo conto solo adesso che ne parlo di quanto questa esperienza mi ha cambiato. Un giorno io e Gustavo Cedroni, l’architetto, ci siamo presi una pausa, avevo la testa sovraccarica, troppi stimoli, dovevo staccare. Siamo andati a Copacabana a fare una cosa che non faccio mai: tagliarmi i capelli, io me li spunto da solo con la macchinetta quando serve. E niente, siamo lì con questo barbiere argentino con la cintura da gaucho, solo con le forbici al posto dei coltelli, e vediamo che subito dietro il suo negozio c’è un tatuatore. Presi da quel momento incredibile ci siamo fatti questo». Alza la manica della polo e mi mostra la scritta “No More Excuses”. «Niente più scuse, era quello il senso del mio viaggio, del mio lavoro in quel momento».
 Racconta le storie della gente di Lapa, cuore povero carioca. «Lì dove stavamo noi battevano decine di trans. Due di loro un giorno vengono e mi dicono: vogliamo cambiare vita. Bene, dico io, ci son da fare le pulizie in cucina, vi aspetto qui domattina. Il giorno dopo si presentano con la maglietta bianca e il fazzoletto in testa, da quel momento cominciano a guadagnare grazie a un lavoro dignitoso, ad avere due pasti sicuro al giorno. E poi i bambini che venivano a mangiare e lasciavano le impronte sui grandi tavoli di legno grezzo, così li ho voluti, tavoli dove potessero restare i segni dei piatti, del cibo, delle mani. Sopra di loro c’era l’“Ultima cena” ripensata da Vik Muniz, fatta tutta di cioccolato, gliel’ho chiesta così perché è il prodotto di quella terra. Tutti devono avere accesso alla bellezza». Il Refettorio come modello replicabile all’infinito. «Si potrebbe aprire ovunque, stiamo pensando a Los Angeles, a New York, a tutte le periferie del mondo… Al Museo del Domani di Calatrava mi ha colpito un numero: 860, ovvero i milioni di persone che oggi non hanno da mangiare. Lo stesso pannello mostrava che entro cinquant’anni saranno la metà. Mi sono chiesto: quanti, tra questi, ne avremo sfamati noi?».
Racconta le storie della gente di Lapa, cuore povero carioca. «Lì dove stavamo noi battevano decine di trans. Due di loro un giorno vengono e mi dicono: vogliamo cambiare vita. Bene, dico io, ci son da fare le pulizie in cucina, vi aspetto qui domattina. Il giorno dopo si presentano con la maglietta bianca e il fazzoletto in testa, da quel momento cominciano a guadagnare grazie a un lavoro dignitoso, ad avere due pasti sicuro al giorno. E poi i bambini che venivano a mangiare e lasciavano le impronte sui grandi tavoli di legno grezzo, così li ho voluti, tavoli dove potessero restare i segni dei piatti, del cibo, delle mani. Sopra di loro c’era l’“Ultima cena” ripensata da Vik Muniz, fatta tutta di cioccolato, gliel’ho chiesta così perché è il prodotto di quella terra. Tutti devono avere accesso alla bellezza». Il Refettorio come modello replicabile all’infinito. «Si potrebbe aprire ovunque, stiamo pensando a Los Angeles, a New York, a tutte le periferie del mondo… Al Museo del Domani di Calatrava mi ha colpito un numero: 860, ovvero i milioni di persone che oggi non hanno da mangiare. Lo stesso pannello mostrava che entro cinquant’anni saranno la metà. Mi sono chiesto: quanti, tra questi, ne avremo sfamati noi?».
Domando se Massimo Bottura può concedersi una pausa. «Mi basta tirare fuori i Velvet Underground, c’è tutto, Lou Reed, la voce quasi stonata di Nico, la copertina di Andy Warhol». Che poi è una banana, dico io, c’è pure il cibo. «Sì, e della banana ho scoperto che non si butta via nemmeno la buccia. A Rio il primo giorno non avevo niente. Mi ero portato dall’Italia la pasta, c’erano delle uova. Poi ho visto tutte le bucce di banana scartate, con le banane avevamo appena fatto un gelato. Le ho prese, le ho affumicate, le ho passate in forno con un po’ di bacon per dare sapore: è nata la carbonara con le bucce di banana». Si torna a Lou Reed. «Rileggevo di recente il pezzo di Lester Bangs su Rolling Stone. “Lou Reed è il mio eroe, perché incarna tutte le cose più malate che riesco a immaginare. Il che credo dimostri solo i limiti della mia immaginazione”. Ecco, non porre nessun limite all’immaginazione. Sta tutto qui».