Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a aprile in redazione.

Teju Cole – Tremore (Einaudi)
Traduzione di Gioia Guerzoni
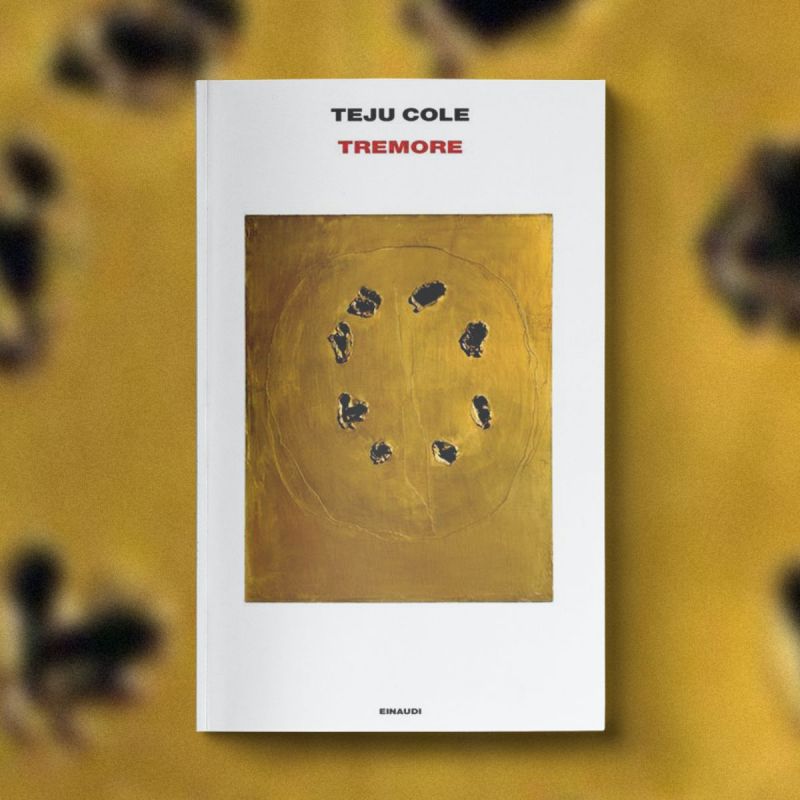
In questi anni ci siamo ubriacati di non fiction, cioè di literary non fiction, cioè di romanzi che non erano romanzi, di esperimenti narrativi che parlavano con la lingua dei saggi, di libri di esperienze e riflessioni che non avevano nessuna trama, se non lo scorrere del tempo. Alcuni erano (sono) grandi libri. Altri solo episodi dimenticabili di una moda che sembra già mostrare la corda. Tra i primi c’è sicuramente Città aperta di Teju Cole, uscito nel 2011 (nel 2013 in Italia per Einaudi) all’inizio di questa ondata, un non-romanzo digressivo fatto di passeggiate, riflessioni, critica d’arte e un abbozzo di trama incentrato sulle relazioni di potere tra sessi. Tra i modelli alti (altissimi) che erano stati chiamati in causa per quel libro c’era uno dei padri se non “il” padre di tutta l’ondata non fiction: W.G. Sebald, insuperabile maestro di opere inclassificabili che mescolano appunto storia con la maiuscola e storie minori, passeggiate, schizzi autobiografici e frammenti di finzione. La cosa curiosa, sorprendente, è che Teju Cole rifaceva, se così si può dire, Sebald, un professore universitario tedesco emigrato in Inghilterra e fissato con la Seconda guerra mondiale, da una prospettiva completamente diversa, quello di afroamericano, anzi più africano che americano (nato a New York, cresciuto in Nigeria, ritornato a New York per l’università), nato nel 1975, e fissato invece con la questione dell’identità. Negli ultimi dieci anni Cole non è sparito, lo abbiamo visto pubblicare prefazioni e articoli di critica d’arte (soprattutto sulla fotografia) sul New York Times e altri spazi prestigiosi della cultura globale, lo abbiamo seguito anche su Instagram, dove pubblica strane foto abbastanza astratte, ma non abbiamo letto un seguito di quell’opera così osannata fino al 2023 e a oggi in Italia, momento in cui esce Tremore. Siamo dalle stesse parti di Città aperta, con forse un gradiente di costruzione romanzesca in più. In Tremore, la storia di una coppia americana (Tunde e Sadako, uno di origine nigeriana, l’altra di origine giapponese) viene attraversata da viaggi, opere d’arte, discorsi, musiche, pagine Wikipedia, vicende storiche. Leggendolo ho pensato ricorrentemente a due cose: la prima è che niente come questo tipo di narrativa ai suoi massimi livelli riesce a rappresentare lo scorrere del tempo e l’affastellarsi di pensieri ed esperienze e quindi a imitare la vita; la seconda è che c’è ancora uno spazio letterario, seppur piccolo, in cui il linguaggio fa affacciare il lettore su quello che sembra un laboratorio di ricerca, ed è sempre un’esperienza vivificante. (Cristiano de Majo)
Chetna Maroo – T (Adelphi)
Traduzione di Gioia Guerzoni

In un momento in cui il tennis è dappertutto, e che essendo dappertutto è diventato non solo sport e sacrificio e disciplina ma soprattutto estetizzazione, moda, frivolezza, ecco un romanzo che, bastian contrario, fa girare tutto attorno allo squash. Eccetto quel famoso memoir è difficile trovare libri che sappiano tenere in equilibrio lo sport e la grande letteratura: un po’ di titoli ce li avrei anche in mente, ma sono appunto sempre quelli, e cioè Friday Night Lights di Bissinger, Giorni Selvaggi di Finnegan, Cavalli di razza di Sullivan, Tennis di John McPhee (in Italia, direi Arpino, Codignola, e poi leggerei Brera all’infinito). Capita spesso con sport individuali, in cui c’entra molto il pensiero del singolo che riverbera o riecheggia nel vuoto che ha intorno, quindi il tennis, e lo squash funziona allo stesso modo. Il titolo T di Chetna Maroo sta a indicare le linee tracciate sul parquet del campo. Lo squash è il prisma attraverso cui passano tutte le storie di questa novella (140 pagine), e cioè quella di Gopi, undicenne inglese di origine indiana, delle due sorelle maggiori, del padre, delle zie, degli zii, della comunità. Gopi è brava a squash, bravissima. Così brava che il padre – vedovo da pochi giorni, all’inizio della narrazione – decide che il successo sportivo di quella figlia è l’unica cosa che conta. È un uomo timido e imbranato a vivere, e trascura la famiglia per distrazione, non per malizia. E vorrebbe cercare altri amori, e svincolarsi dalle norme oppressive della comunità. Lo squash è in ogni pagina, diritti e smorzate, allenamenti e partite, vecchi VHS e storie leggendarie su Jahangir Khan: eppure, tra tutti questi colpi e tutto questo sudore, riverbera sempre la letteratura, la tenerezza della crescita. Gopi migliora sempre di più, il suo squash si trasforma: da ossessione diventa, a poco a poco, centro di gravità di un nuovo equilibrio di famiglia. (Davide Coppo)
Lize Spit – Non ci sono (edizoni e/o)
Traduzione di Valentina Freschi, Elisabetta Svaluto
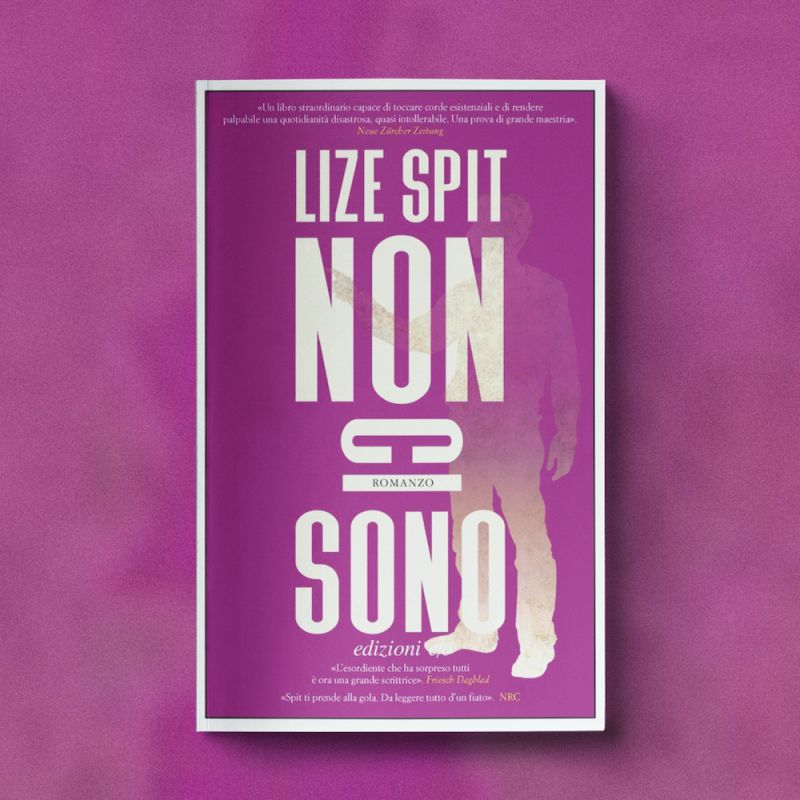
Consiglio di iniziare questo libro, non brevissimo, all’inizio di un weekend o quando sapete di avere qualche giorno libero, perché credo sia impossibile leggerlo in modo equilibrato senza sprofondare nel binge-reading. Parla di una coppia di giovani fidanzati, Leo e Simon, entrambi creativi (lei aspirante sceneggiatrice, lui graphic designer di una delle agenzie di comunicazione più cool di Bruxelles), che si sono messi insieme all’università e convivono già da dieci anni. Sono entrambi un po’ stranini, ma è normale: hanno dovuto superare tutti e due un grosso lutto. La madre di Leo è morta in un incidente quando lei era adolescente, quella di Simon muore di cancro mentre lui è all’università, poco dopo che i due si sono conosciuti (il loro primo appuntamento ufficiale è il suo funerale). Tolti i rispettivi padri, assenti o inutili, sia Leo che Simon non hanno una famiglia. E quindi, questo loro amore, che vivono un po’ ossessivamente, è l’unico posto in cui trovano conforto e sicurezza. Fino a che qualcosa cambia, e Simon inizia a comportarsi in modo sempre più strano. Comportamenti che Lize Spit (36 anni, pochi di più dei suoi protagonisti), descrive alla perfezione: non mi ha stupito leggere in un’intervista che anche lei ha convissuto per 12 anni con una persona che soffriva di fasi maniacali e crisi psicotiche. In questo senso, per la sua capacità di tenerti attaccato e di generare uno stato d’ansia perenne, si potrebbe dire che Non ci sono di Lize Spit è la versione libro della serie Netflix Baby Reindeer. Ma l’angoscia che riescono a provocare nel lettore e nello spettatore – quella che provi guardando un horror, o un thriller – non è l’unica cosa in comune che hanno queste due storie. Come scrivevo qui, Baby Reindeer si distingue per la delicatezza e la precisione con cui descrive la malattia mentale: Non ci sono fa esattamente lo stesso, anche meglio (perché si spinge più in là, raccontando anche il dramma del ricovero in clinica psichiatrica e degli psicofarmaci). Proprio come la serie, il libro riesce a restituire perfettamente l’ambiguità e l’ambivalenza del rapporto che si sviluppa tra due persone quando c’è di mezzo la malattia. Anche qui c’è qualcuno che, si evince molto presto, ha un grave problema mentale, ma c’è anche qualcuno che gestisce quel problema nel modo peggiore possibile, proprio come spesso, purtroppo, succede nella realtà. Recupererò senz’altro anche il primo romanzo della scrittrice belga (Si scioglie, uscito nel 2017, sempre con e/o), assicurandomi di poter leggere per tutto il giorno.
Max S. Bennett, Breve storia dell’intelligenza (Apogeo)
Traduzione di Virginio B. Sala
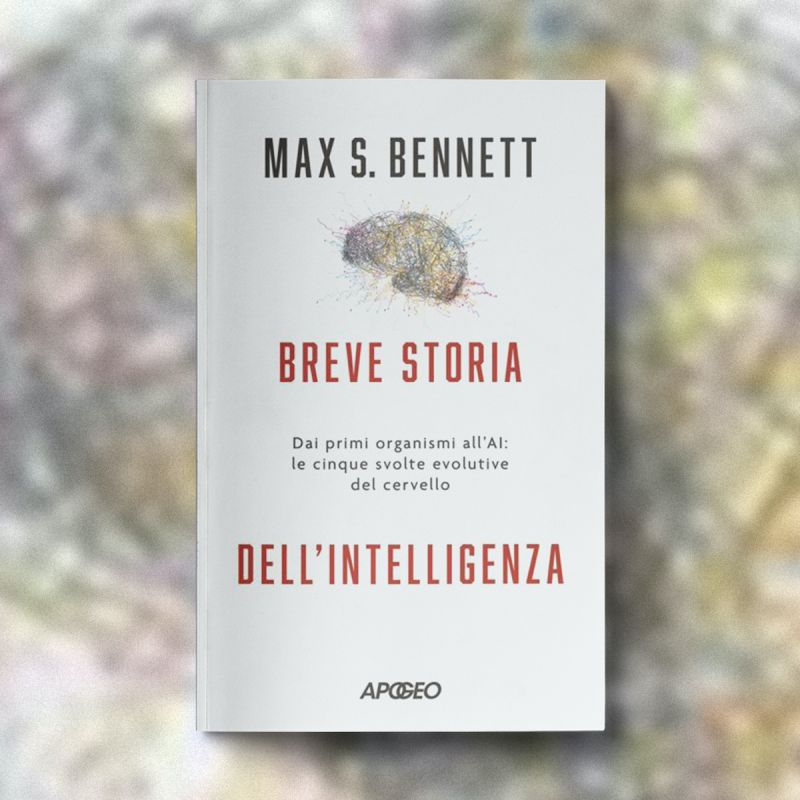
Quello di Bennett è un libro che si potrebbe definire positivista tanto nell’impostazione quanto nell’intenzione. Da convinto sostenitore dell’apocalisse come conseguenza di una singolarità tecnologica che si avvicina veloce, era da anni che non mi capitava di leggere un libro sulla tecnologia scritto da un punto di vista speranzoso, persino ottimistico sulla stessa. Fatto tanto più sorprendente se si considera che Breve storia dell’intelligenza non è tanto un libro sulla tecnologia quanto uno sull’umana intelligenza. Non solo uno storia del cervello umano, che comunque Bennett seziona usando parole e numeri e grafici per spiegare esattamente quale parte fa quale cosa e come il Regno animale sia stata fondamenta dell’Antropocene. Breve storia dell’intelligenza è soprattutto una testimonianza dell’umano ingegno, storia del passaggio del testimone dall’universo all’essere umano, come scrive l’autore in uno dei passaggi più ispirati del libro. Quattordici miliardi di anni di evoluzione: a leggere viene da pensare davvero che l’universo tutto sia un organismo e che proceda anch’esso, come tutti gli organismi, di svolta evolutiva in svolta evolutiva, di perfezionamento in perfezionamento, e che le tracce di questo immenso e lunghissimo percorso siano segnate tutte nel cervello umano, e che questo sia una mappa con ancora immensi spazi bianchi che una volta riempiti tutti ci porteranno non solo all’origine e al senso della specie ma anche a quello dell’universo stesso. Ed è inevitabile che Bennet arrivi alla fine a parlare della svolta evolutiva, del perfezionamento che si sta svolgendo stavolta non nell’imperscrutabile minuscolezza degli atomi o dei cromosomi ma in quella artificiale dei bit: la costruzione dell’intelligenza artificiale. Intelligenza propriamente detta, quindi un’entità assai più complessa dei chatbot-pappagalli (ChatGPT) e dei disegnatori copioni (Midjourney, Dall-E, etc.) con i quali ci balocchiamo ormai da anni. Quando Bennett racconta il tentativo dell’umanità di produrre una vera, letterale intelligenza artificiale, lo fa restituendo la ricerca tecnologica a quella dimensione originale, allo stesso pionieristica e utopica, che negli ultimi vent’anni si è persa quasi definitivamente. A leggere Breve storia dell’intelligenza viene voglia di essere lì, presenti, al compimento di un futuro che, Bennett sembra esserne sicuro, si compirà. E sarà non la fine della storia né quello dell’umanità, come spesso si è portati a pensare a leggere le cronache della Silicon Valley: sarà l’ultima svolta evolutiva, il perfezionamento definitivo, la prova che l’uomo ha davvero raccolto il testimone passatogli dall’universo. (Francesco Gerardi).
Immagine: William Turner, “Mercanti di schiavi che gettano in mare i morti e i moribondi. La nave negriera” (1840)

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.





