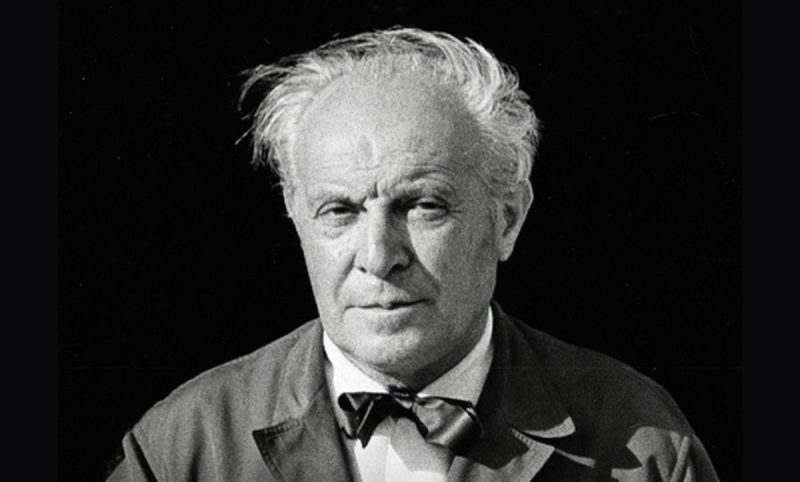È vero, la città non può perdere uno spazio così. Ma è vero anche che rabbia, nostalgia, indignazione non bastano. Milano deve raccogliere l'eredità del Leoncavallo per affrontare i suoi tanti problemi di oggi.
Da Superonda – Storia segreta della musica italiana (Baldini & Castoldi, 2016) a Remoria. La città invertita (minimum fax, 2019), fino a Exmachina (minimum fax, 2022), Valerio Mattioli ha sempre scritto libri che si fondano su un gesto ricorrente di inversione del mondo ufficiale, tracciando controcartografie, antitopie e geografie negative. Questo stesso procedimento trova una sorta di sintesi in Novanta. Una controstoria culturale, pubblicato da Einaudi nel 2025, dove Mattioli applica lo sguardo del “negativo” a un luogo nel tempo: gli anni Novanta italiani. Al centro del libro c’è la rete dei centri sociali, un glitch nella matrice urbana capace di rovesciare gerarchie, immaginari e polarità del tessuto cittadino, e di generare una cultura fatta di musica, riviste, fanzine, pratiche politiche e sperimentazioni che hanno segnato un’intera generazione. Il presente, però, si muove in direzione opposta: il recente sgombero di Askatasuna a Torino, la ferita ancora aperta del Leoncavallo e la progressiva chiusura o ridimensionamento di molti altri spazi rendono evidente quanto quell’eredità venga ancora rimossa o criminalizzata. In questo contesto, “Novanta” diventa anche una domanda aperta: cosa resta oggi di quella geografia parallela, e se sia ancora possibile immaginare spazi capaci di invertire il mondo invece di adattarvisi.
ⓢ Nel tuo libro sugli anni ’90 racconti i centri sociali come laboratori culturali, cosa rischiamo di perdere oggi, con la chiusura di realtà come Askatasuna e il Leoncavallo?
Questa è una di quelle domande che richiederebbe una risposta talmente lunga da diventare un piccolo saggio, che tra l’altro non sarei nemmeno la persona più titolata ad articolare. Quindi, tralasciando l’aspetto più propriamente politico e le battaglie che – ciascuno a vario modo e secondo le proprie sensibilità – gli spazi occupati e autogestiti portano avanti da decenni in Italia, mi limito a far notare come luoghi del genere rappresentano se non altro il proverbiale glitch nella matrice urbana. Detta in altri termini, sono la prova concreta di come un concetto come quello di “socialità” non per forza debba adeguarsi alle tristi, kitsch e noiose – oltre che costose – liturgie del fantomatico “mercato”, che hanno trasformato le nostre città in posti ancora più brutti, faticosi e respingenti di quanto già non fossero.
ⓢ Guardando agli anni ’90, quanto è stato centrale il ruolo dei centri sociali nel ridefinire l’immaginario giovanile italiano rispetto ai canali culturali “ufficiali”?
Molto. Buona parte dell’immaginario di quel decennio – dal rap alla scoperta di internet passando per la cultura rave e per una tale quantità di estetiche/linguaggi/esperimenti a 360 gradi che non saprei nemmeno da dove cominciare – è nata nei centri sociali, o quantomeno li ha attraversati e vi ha trovato riparo. E infatti, quando la “cultura ufficiale” se n’è accorta, la corsa a cavalcare il fenomeno è stata tanto plateale – e questo al netto di quelle esperienze che, nate all’interno dei centri sociali stessi, hanno a un certo punto deciso in prima persona di tentare la penetrazione del mainstream, dai gruppi musicali che uno dopo l’altro finivano su major, a figure come Gomma e Raf Valvola (tra i fondatori di una rivista cyberpunk militante come Decoder) che inauguravano una propria collana per Feltrinelli, a veri e propri casi mediatici come Luther Blissett, la cui cosiddetta “colonna bolognese” firmò per Einaudi un bestseller come Q nel 1999. Si è trattato di un processo lungo e chiaramente contraddittorio, ma a suo modo giustificato proprio dal peso che la “galassia antagonista” si conquistò nel dibattito culturale del periodo.
ⓢ Nel dibattito pubblico attuale, i centri sociali vengono spesso raccontati come un problema di ordine pubblico. Negli anni ’90 era diverso o è una narrazione che si ripete ciclicamente?
Ma figurati, erano un “problema d’ordine pubblico” anche allora. La lista sarebbe infinita: solo per restare agli esempi più celebri, vale per lo sgombero del Leoncavallo del 1989, per la fine dell’Isola a Bologna due anni più tardi, o – in maniera assai più tragica ed efferata – per le accuse di ecoterrorismo che nel 1998 trasformarono i famigerati “squatter di Torino” nel nemico pubblico numero 1, almeno se davi retta a La Stampa – intendo proprio il quotidiano dallo stesso nome. Il che per inciso ti fa capire perché, nei confronti dei cosiddetti “baluardi della libera informazione”, il sospetto fosse quantomeno diffuso, e direi anche ampiamente giustificato. Certe definizioni che trovavi sui giornali erano talmente surreali da risultare involontariamente comiche – peccato che fossero anche strumentali a una criminalizzazione dagli effetti molto concreti e reali, specie se non ti adeguavi a quella specie di idealtipo “centrosocialari = boyscout che sbagliano” su cui tanto insistevano non poche penne della sedicente “stampa progressista” (quella più spudoratamente di destra almeno aveva la dignità di dire chiaro e tondo quello che pensava). Il tutto, figurarsi, mentre sulle pagine culturali degli stessi giornali venivano decantate le mirabolanti imprese delle posse o del cyberpunk. È una contraddizione solo apparente e direi anche piuttosto indicativa: i centri sociali andavano bene solo nella misura in cui funzionavano come luoghi di intrattenimento e potenziale serbatoio di una non meglio precisata “industria culturale”. Qualsiasi rivendicazione dal taglio più smaccatamente politico, sociale, o anche banalmente esistenziale, veniva nella migliore delle ipotesi ignorata, oppure più direttamente repressa – e questo valse anche per quelle realtà che, da un certo punto in poi, adottarono una postura più aperturista nei confronti della sinistra istituzionale, la quale a sua volta vedeva nei “giovani dei centri sociali” poco più che carne da macello elettorale. Qualsiasi parallelismo con l’attualità è chiaramente del tutto involontario.
ⓢ I centri sociali sono anche archivi viventi: concerti, fanzine, reti, memorie. Secondo te l’Italia ha mai fatto davvero i conti con questa eredità culturale?
Direi di sì, nel senso che da sempre tenta in tutti i modi di farla fuori.
ⓢ Nel tuo lavoro emerge come molte scene musicali e artistiche degli anni ’90 siano passate dai centri sociali al mainstream. Oggi esistono ancora spazi capaci di svolgere quella funzione di incubatori?
Beh, se continuano a sgomberare spazi, direi che gli unici incubatori a rimanere saranno i fantomatici “incubatori d’impresa” dove i figli di miliardari potranno continuare a divertirsi nel tentativo di sperperare il patrimonio di famiglia con le loro Legoland startuppare, consapevoli che tanto a sistemare tutto ci penserà papà e che il patrimonio di cui sopra verrà facilmente rimesso in sesto alla prima operazione immobiliare – magari investendo in qualche malmesso quartiere di periferia da trasformare in nuova “oasi creativa” perché “ehi, è nel suo Dna: una volta qui c’era un centro sociale!”.
ⓢ Pensi che la difficoltà attuale dei centri sociali sia legata più a una trasformazione politica o a una trasformazione culturale e generazionale?
Mi pare evidente che ci sia un’intenzione politica dal taglio esplicitamente repressivo. In un’altra intervista azzardavo anche una lettura psicanalitica, che lascio a te decidere se prendere sul serio o meno. Il succo è questo: tu pensa a figure come Meloni, Salvini o anche Alessandro Giuli, l’ex militante di Meridiano Zero poi diventato vicedirettore del Foglio. Bene: tutti questi personaggi si sono formati proprio negli anni Novanta, e possiamo immaginare la frustrazione che devono aver provato nel vedere, in quelli che nella vita di una persona dovrebbero essere “i migliori anni”, un intero mondo che si divertiva, stava bene, inventava linguaggi e faceva festa, mentre loro stavano già a rimuginare su come intristire la vita propria e degli altri. Quindi adesso che sono al potere hanno finalmente la possibilità di vendicarsi, no? Forse è un caso di ossessione nei confronti del passato: devono fare i conti con la loro adolescenza buttata.
ⓢ Se gli anni ’90 sono stati un decennio di sperimentazione e apertura, come leggi il fatto che oggi si parli soprattutto di chiusure, sgomberi e fine di un ciclo?
Ma il ciclo degli anni Novanta è finito da un pezzo: per il ricercatore Gigi Roggero si chiuse addirittura già nel 1994, l’anno della grande manifestazione contro l’ennesimo sgombero del Leoncavallo, e probabilmente ultimo sussulto unitario di una galassia di per sé molto diversificata al suo interno. Poi c’è stato il 1998 della già citata campagna anti-squatter da una parte (quella che porterà ai suicidi di Sole e Baleno) e della cosiddetta Carta di Milano dall’altra (il documento-manifesto dei centri sociali più “dialoganti” con le istituzioni): due episodi simbolici – oltre che dolorosi assai – di quanto si fossero ulteriormente allontanati i percorsi di anime a conti fatti inconciliabili dello stesso movimento. E infine c’è Genova 2001, che per convenzione è considerata la pietra tombale di tutta una generazione. Da allora di cicli ce ne sono stati infiniti altri, ciascuno dei quali ha dovuto fare i conti con le peculiarità e le specificità del tempo presente. È chiaro che, per usare un inglesismo che piacerà molto agli startuppari di cui sopra, si va avanti per ebb and flow. Ma dagli anni Novanta sono passati trent’anni: mi sembra assurdo pensare che le forme e le modalità di quel decennio possano essere replicate immutate oggi.
ⓢ Nel libro racconti una cultura “dal basso” che spesso non chiedeva legittimazione. Oggi è ancora possibile immaginare spazi autonomi senza un riconoscimento istituzionale?
Chiedo scusa per la formula spudoratamente sloganistica, ma ecco: più che possibile, è necessario. Voglio dire, è proprio una questione di ossigeno, no? Anche perché “riconoscimento istituzionale” suona tanto come “bacio della morte”, se capisci cosa intendo.

Nato con scopi educativi, prima di essere commercializzato, il famoso gioco da tavola incarna da decenni il capitalismo immobiliare. Ma una nuova versione si propone adesso di ritornare al suo senso originario.