Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.
Autentico Carrère
Nel suo ultimo libro, Yoga, al centro di polemiche anche extra-letterarie, ha spinto l’acceleratore sull’autoconfessione, parlando di meditazione e di malattia mentale. Incontro con il grande maestro della non fiction contemporanea, dalla storia di copertina del numero in edicola.

Secondo il maestro tibetano Chogyam Trungpa, ognuno di noi dedica al presente solo il 20 per cento dell’attività cerebrale. Il restante 80, lo rivolgiamo al passato o al futuro in percentuali diverse. Nel suo ultimo libro, Yoga, Emmanuel Carrère scrive di appartenere alla seconda categoria, e di essere da sempre immune alla nostalgia. Più che un libro proteso verso il futuro, però, Yoga è il libro di un uomo che è stato travolto da un presente inaudito, ha trasformato in racconto quello che accadeva intorno a lui ed è sopravvissuto perfino a sé stesso. Nelle intenzioni iniziali, Yoga sarebbe dovuto essere un libretto «arguto e accattivante», una specie di saggio sulla meditazione. Carrère voleva affrontare l’argomento da un punto di vista differente, «da uno scaffale che non fosse quello dei libri di autoaiuto». Per prepararsi a scrivere aveva deciso di seguire un seminario di meditazione Vipassana, e di passare dieci giorni nel Morvan isolato dal mondo. Due giorni dopo essere arrivato, il 7 gennaio 2015, il ritiro è stato interrotto dalla notizia degli attentati terroristici a Parigi, e da allora tutto è cambiato per sempre.
«Tutto comincia con un’interruzione», ha scritto Paul Valèry, ed è proprio quello che accade in Yoga che, oltre che un libro sulla meditazione, è diventato così la storia del massacro di Charlie Hebdo, dell’uccisione dell’amico Bernard Maris e della scomparsa dell’editore Paul Otchakovsky-Laurens, il racconto di una depressione, della diagnosi di disturbo bipolare, di quattordici sedute di elettrochoc all’ospedale Sainte-Anne di Parigi, di un corso di scrittura a Leros per un gruppo di giovani migranti, dell’incontro con una cooperante americana tormentata, del sorriso di Marta Argerich mentre suona l’“Eroica” di Chopin, di una relazione estrema con una donna misteriosa, di un lento, esitante ritorno alla vita. Dalla sua uscita in Francia, lo scorso autunno, Yoga è anche il racconto mancato di un divorzio, una ellissi narrativa imposta dall’ex moglie in un caso editoriale circondato da accuse e polemiche. Nonostante tutto, di yoga, meditazione, tai chi e vrtti il libro un po’ parla, e la sua definizione di yoga Carrère la dà a pagina 70: «Yoga è l’arresto delle fluttuazioni mentali» (i vrtti, per l’appunto). L’unica altra definizione di “yoga” che ricordo in un romanzo è quella in Franny & Zooey di Salinger. È una citazione presa dalla Bhagavadgītā, il testo sacro degli Hare Krishna, scritta a mano su un foglio d’eternit attaccato alla parete della cameretta di due fratelli della famiglia Glass, Seymour e Buddy. «Non lasciarti andare a sbalzi d’umore nel successo come nel fallimento, giacché “yoga” vuol dire proprio umore costante». La legge Zooey in piedi davanti al telefono, prima di chiamare sua sorella Franny e cercare di consolarla raccontandole una delle più belle storie della letteratura, quella della Signora Grassa. Franny è una ex bambina prodigio in cerca di sé stessa; ha da poco scoperto la meditazione e il suo umore è tutt’altro che costante. Yoga invece è la storia di un grande scrittore che pensava di aver trovato la pace e invece ha toccato il fondo. Che ha cambiato la letteratura indagando sé stesso attraverso le vite degli altri e, in uno dei momenti più difficili della sua vita, anziché rinunciare a scrivere ha stretto il cerèchio, e ha usato il mondo per raccontare o per salvarsi (che forse è la stessa cosa).
ⓢ In Yoga, scrive: «La nostalgia non mi appartiene» («La nostalgie m’est etrangère», nell’originale francese), è davvero possibile, per un uomo e per uno scrittore, vivere senza nostalgia?
Anche se è composta da ingredienti simili, l’economia psichica di ognuno di noi è diversa. Personalmente so di avere tanti istinti irrazionali nella vita, ma non sono nostalgico. Non ho mai vissuto nel passato e, anche adesso che inizio a diventare vecchio, non rimpiango il tempo in cui ero giovane… va bene così.
ⓢ Com’è cambiato dai tempi di L’amico del giaguaro o di La settimana bianca? Si sente un uomo diverso e uno scrittore diverso?
Penso di essere cambiato moltissimo in questi anni e, anche se forse può suonare un po’ pretenzioso, penso di essere cambiato in meglio. Bisogna anche dire che non partivo da un livello molto alto… ma se mi guardo indietro vedo tutto il cammino che ho fatto, ed èè un cammino che mi ha portato a crescere. A un certo punto nel libro, parlando del mio editore, che era Paul Otchakovsky, lo scrivo: lui faceva parte di quelle persone che pensano siamo al mondo per migliorarci. Può sembrare una cosa scontata, ma non lo è affatto: ci sono persone per le quali diventare migliori non è uno degli obiettivi per cui si alzano al mattino. Hanno altre priorità, altre visioni. Quando dico “migliore” non intendo più gentile, più buono con gli altri, o almeno non soltanto: intendo piuttosto essere capaci di uno sguardo più aperto, più ampio sulle cose. Ecco io non penso di essere venuto al mondo per essere felice, quanto per saperne di più. Se uno vive con questa idea in testa, il tempo che passa è soltanto utile. Forse anche per questo motivo non sono nostalgico.

Foto di Bettina Pittaluga
ⓢ In Yoga racconta che nel 2017, nel bar di un albergo di Guadalajara, proprio Paul Otchakovsky la vide rispondere a delle mail dal tablet e si accorse che per digitare usava una mano sola, anzi un solo dito. Non poteva crederci: proprio lei, uno dei più grandi autori della sua casa editrice, aveva scritto tutti i suoi libri una lettera alla volta. Otchakovsky era sbalordito, e per tutta la sera parlaste a malapena d’altro; le girò l’indirizzo di un tutorial online di typing e sosteneva che, se avesse imparato a scrivere con entrambe le mani, il suo modo di scrivere sarebbe di certo cambiato. Ha imparato, poi, a scrivere con due dita?
Sì. Adesso non scrivo con dieci, ma diciamo con sei, otto dita contemporaneamente. Il problema, però, è che scrivendo con due mani faccio molti più errori, quindi il tempo che guadagno a scrivere con tutte queste dita poi spesso lo perdo a correggere. Quando si scrive con un dito soltanto, si procede molto più lentamente ma non si fanno errori di battitura. Curioso, no? Mi fa pensare a quel film di Lubitsch, Mancia competente, in cui il protagonista, non so più per quale ragione, si fa assumere come segretario da un miliardario. Solo che non sa scrivere a macchina: qualunque altro regista avrebbe girato la classica scena di uno che scrive, poi tira via il foglio, lo accartoccia e lo butta nel cestino tra mille altri, invece Lubitsch ci mostra il tipo che, per ogni lettera che batte a macchina, ne cancella una sul foglio. Una scritta, una cancellata, una scritta, una cancellata, e così via.
ⓢ Sta scrivendo, in questo periodo?
No. Mi riposo e mi preparo a traslocare. A scrivere riprenderò in autunno.
«Personalmente so di avere tanti istinti irrazionali nella vita, ma non sono nostalgico. Non ho mai vissuto nel passato e, anche adesso che inizio a diventare vecchio, non rimpiango il tempo in cui ero giovane»
ⓢ In Yoga, scrive: «La letteratura è il luogo in cui
non si mente». È davvero così? Non è piuttosto
in luogo nel quale crediamo a tutto?
Non credo alla purezza assoluta, in nessun campo. Quando scrivo che la letteratura è un luogo in cui non si mente, subito dopo aggiungo che in questo libro, come negli altri, ci sono comunque dei compromessi con la verità. Ci sono sempre, dei compromessi con la verità, in ogni cosa. L’importante – credo – sia provare a non barare, ovvero fare tutto quello che è possibile per rimanere onesti verso la materia che stiamo trattando. Attenzione: onesti non significa letterali. Se lavoro a un documentario, ad esempio, non userò mai tutte le scene che ho girato. C’è sempre un momento in cui raccolgo i materiali, li esamino, li seleziono, li monto e li compongo insieme: in quel momento, anche se tutti gli elementi sono veri, li sto disponendo, e così facendo, inevitabilmente faccio della fiction, della “finzione”. Scrivere è un po’ la stessa cosa: significa prima di tutto scegliere.
ⓢ Nei suoi libri precedenti ha abituato il lettore all’alternarsi di due tipi di narrazione. La narrazione su Carrère – individuale, autobiografica – e quella alla Carrère, dedicata al racconto della vita di altre persone. In Yoga, il filo del racconto è esclusivamente individuale: la meditazione, la depressione, il viaggio, la perdita di persone a lei molto care. Certo, ci sono altri personaggi, ma al centro c’è soltanto lei. Com’è stato scrivere un libro così personale?
In realtà anche Un romanzo russo era totalmente incentrato sulla mia storia; era autobiografico e, proprio come Yoga, si concentrava su un periodo di crisi. Mi è già capitato di dirlo altre volte: Un romanzo russo è un libro di cui per certi versi mi sono pentito. Racconta una storia molto personale, tra me e una donna, e lo fa in modo anche brutale. Forse se dovessi indicare un libro che “rimpiango” di aver scritto sarebbe questo. Anche se poi la donna l’ho rivista, ci siamo chiariti e riappacificati. Ma resta un libro in qualche modo violento, un libro “take no prisoners”, si direbbe in inglese, spietato verso il prossimo. Yoga è diverso, è un libro che mi è costato scrivere, ma appunto in questo caso era diverso, perché la guerra che conducevo era una guerra contro me stesso.
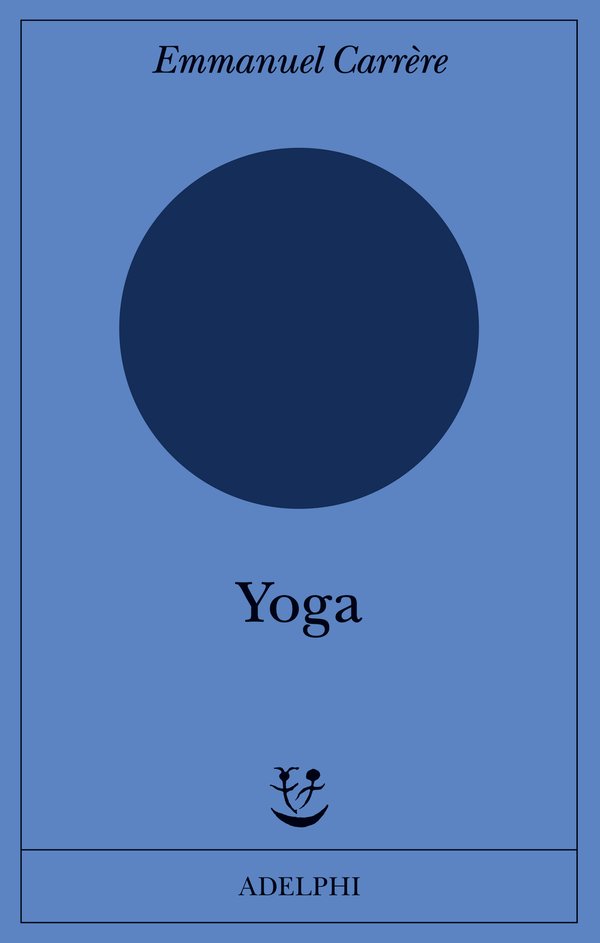
ⓢ Uno dei personaggi femminili più forti e presenti nel libro è una donna di cui non sappiamo nulla. E di cui nemmeno lei sa niente, perché dal vostro primo incontro avete scelto di restare due sconosciuti. Ha più rivisto «la donna dei gemelli» da allora?
No, l’ultima volta che l’ho vista è quella che racconto. La donna dei gemelli è una figura in cui ho fatto confluire diverse cose della mia vita, ma l’essenziale di quello che racconto è vero: la scelta che due persone fanno di vivere dei momenti insieme, di amarsi senza sapere nulla l’uno dell’altra. È una cosa molto particolare, che non mi era mai successa prima nella vita. In fondo ricorda un po’ quella dei due amanti di Ultimo tango a Parigi di Bertolucci, ma certo con conseguenze meno estreme. Una storia che mescola amore e morte, che ha significato molto per me in termini erotici e di relazioni umane. Un incontro che mi ha insegnato tantissimo, per il quale provo enorme gratitudine. Ma ecco, nemmeno verso questa storia provo nostalgia.
ⓢ «Gli scrittori che scrivono quello che gli passa per la testa sono quelli che preferisco, a cominciare da Montaigne, loro santo patrono». Chi sono?
Beh, ad esempio Proust: certo, la Recherche è un racconto con una sua storia, ma se amo così tanto Proust come scrittore è proprio perché è uno che ha costruito tutto, ha scommesso tutto proprio sullo scrivere quello che gli passava per la testa. Gli si rimprovera spesso una certa lentezza: io, al contrario, trovo che Proust sia uno degli scrittori più rapidi che siano mai esistiti. Le sue frasi sono estremamente lunghe, è vero, ma puntano sempre a catturare il più gran numero di cose nel minor tempo possibile, quindi ecco, il suo stile in questo senso è rapidissimo. Ci sono scrittori che avanzano a forza di frasette brevissime, di mezza riga, eppure sono lenti, perché mentre scrivono non si impossessano di nulla. Proust invece è rapido, è uno che procede per illuminazioni, e porta a casa un sacco di cose in poco tempo. E poi è divertente, uno degli scrittori più comici in letteratura insieme a Dickens. Un altro che scriveva quello che gli passava per la testa era Thomas Bernhard, e in qualche modo anche Bolaño faceva la stessa cosa.
ⓢ Ci sono dei contemporanei?
Non direi. Gli scrittori viventi che ammiro scrivono per altre ragioni, e in modo diverso. Houellebecq, ad esempio. Provo per lui una stima infinita, ma non scrive affatto quello che gli passa per la testa, Houellebecq è un vero romanziere del XIX secolo, che narra il preciso momento storico in cui si trova. Ha una visione del mondo, e intorno a questa visione costruisce il suo racconto. Diciamo che non m’interessa nemmeno quello che gli passa per la testa, perché il punto è un altro: quello che scrive parte da altro e ad altro vuole arrivare. Lo stesso vale per Svetlana Aleksievič, una scrittrice che ammiro immensamente: penso che se qualcuno le chiedesse di scrivere quello che le passa per la testa risponderebbe: «No, grazie, ho ben altro da fare. Occupatevi voi di questa roba qui, io ho delle cose più serie da portare a termine». Che poi non è più giusto o meno, è semplicemente una forma differente.
ⓢ Yoga in origine sarebbe dovuto essere un testo molto diverso, ma una seria di eventi imprevisti hanno stravolto la sua vita e anche il progetto del libro. Anche altri suoi libri, – lo stesso Romanzo russo, e soprattutto Vite che non sono la mia – sono delle inchieste sul genere umano condotte a partire da incontri fortuiti, disgrazie, calamità naturali. Qual è il ruolo del caso in quello che scrive?
Quando si scrive della pura fiction, si è l’unico capitano a bordo. I libri che scrivo, per la loro stessa natura, posso comandarli fino a un certo punto. Inizio a scrivere, ho un piano, un progetto in testa, ma mi aspetto sempre dei contrattacchi della realtà. Non barare significa anche accettare questi contrattacchi, accettare il fatto che la realtà reagisce a quello che stai scrivendo, e lo fa in un modo imprevisto, a volte spiazzante o addirittura violento. Se Yoga fosse stato un romanzo, non avrei certo mai immaginato che il mio ritiro di meditazione sarebbe stato interrotto dalla strage di Charlie Hebdo, o che sarei finito all’ospedale psichiatrico, o partito per Leros per seguire un workshop di scrittura con dei giovani migranti. Eppure è così che è andata, ed è così che il libro è costruito. Ricordo che, quando lesse il manoscritto de L’avversario, la storia di un uomo che mente a tutti per diciotto anni, che uccide la moglie, i figli e i genitori, il mio editore mi disse: «Quello che racconti è vero. Se tu me lo avessi proposto come un romanzo, ti avrei risposto che l’idea era interessante, ma che non poteva funzionare, perché non era credibile». Perché in fondo i romanzi sono obbligati alla verosimiglianza. Dobbiamo sentire, mentre scriviamo o leggiamo un’opera di finzione, che quello che succede potrebbe accadere davvero. E allora la scrittura per così dire documentaria lascia in qualche modo più liberi. Lo so, è un cliché dire che la realtà supera la fantasia, ma i pensieri per così dire originali mancano spesso di autenticità, mentre i cliché beh, quelli spesso sono veri.
«La scrittura per così dire documentaria lascia in qualche modo più liberi. Lo so, è un cliché dire che la realtà supera la fantasia, ma i pensieri per così dire originali mancano spesso di autenticità, mentre i cliché beh, quelli spesso sono veri»
ⓢ Il maestro di Iyengar yoga Faeq Biria, che nomina nel libro, dice che per iniziare a meditare servono almeno dieci anni di pratica assidua. Devi aver aperto il bacino, il torace, le spalle, allineato i bandha e i chakra, acquisito la padronanza di tutte le tecniche di pranayama, e soltanto allora inizia la vera meditazione. Si può dire la stessa cosa della scrittura? Dopo quanto tempo si diventa scrittori?
Ho iniziato a scrivere molto presto, a pubblicare abbastanza presto, ma solo a un certo punto ho trovato la mia voce. Forse il primo buon romanzo che ho scritto è stato I baffi, e poi c’è stato L’avversario, con cui ho preso un’altra strada. E in fondo ancora oggi, anche se a scrivere e pubblicare ho iniziato da giovane, mi sento comunque uno che ha cominciato tardi, e mi reputo uno scrittore piuttosto lento.
ⓢ Yoga è un libro sul potere della meditazione, ma anche sui suoi limiti. Per lei meditare è davveroutile?
Non so dire se sia davvero “utile”. Ma di certo è piacevole, molto piacevole. Non medito ogni giorno, ma negli anni è una cosa a cui sono rimasto fedele, un filo che tiene insieme varie epoche della mia vita. Stranamente, però, è proprio nei periodi in cui avrei maggiore bisogno di meditare che non lo faccio. Un po’ come Gandhi quando diceva: «Ho così tante cose da fare oggi, che devo meditare due ore anziché una». Forse nell’ ultimo anno, ho meditato più del solito. Ma credo sia stato perché avevo più tempo, semplicemente.
ⓢ Come ha trascorso quest’ultimo anno?
Ho passato la maggior parte del tempo a Parigi, dove c’era mia figlia Jeanne, e del tempo a Royan, nel sud ovest della Francia, con la mia compagna. Ricordo un autogrill deserto, in cui
mi sono sentito l’ultimo uomo sulla terra. Era
come se una telecamera mi riprendesse dall’alto, come se intorno a me non esistesse più niente. Non voglio sembrare cinico, è stato un periodo atroce e durissimo a livello mondiale per moltissime persone, ma il primo lockdown per me è stata un’esperienza anche affascinante. Non ho modificato di molto il mio modo di vivere, perché stavo lavorando al libro e avrei passato comunque gran parte del mio tempo chiuso in casa a scrivere. È stato proprio durante il primo confinement che ho finito Yoga, e in qualche modo quel tempo sospeso è stata la condizione ideale per portarlo a termine.

ⓢ Yoga è uscito in Francia a fine agosto 2020. Ha avuto un grande successo di vendite e ha suscitato parecchie polemiche. Qual è il suo rapporto con questo libro a quasi un anno dalla pubblicazione?
Ne ho preso le distanze abbastanza rapidamente, non per scelta ma per una ragione precisa: perché nel frattempo mi ero allontanato dal momento della vita che questo libro racconta. Yoga è la storia di una transizione a dir poco caotica attraverso cui sono passato. Non dico che non ce ne saranno altre, solo che adesso mi trovo in un tutto un altro posto, lontano da lì. Ma comunque è un libro con cui mi sento a mio agio.
ⓢ C’è una frase di Simone Weil che dice: «Due forze regnano sull’universo: luce e e pesantezza». Lo scrive ne L’ombra e la grazia, e i libri che scrive me l’hanno ricordata; sono spesso indagini spietate sul male e la condizione umana, ma capita si concludano in una sorta di illuminazione, di tregua, anche se illusoria e momentanea. Cos’è per lei scrivere? Andare in cerca di luce? O un modo di sopravvivere all’abisso?
Voglio farle un piccolo regalo [cerca qualcosa in una pila di quaderni alla sua destra, nda]. Come le dicevo sto per cambiare casa, e se c’è qualcosa di bello nei traslochi è proprio riscoprire cose che avevamo completamente dimenticato. Proprio l’altro giorno ad esempio ho ritrovato questa frase, che avevo appuntato su un quaderno molto tempo fa, quando lavoravo al mio libro su Philip Dick. È di un poeta vittoriano chiamato Coventry Patmore, un poeta minore piuttosto dimenticato anche lui. Eccola qui, dice: «A chi sa aspettare, ogni cosa si rivela, a patto che non rinneghi, nel buio, quello che ha visto nella luce». Incoraggiante, non crede?

Cantautore, polistrumentista, produttore, compositore di colonne sonore e molto altro. L’abbiamo intercettato, rilassatissimo, pochi giorni prima della partenza per il tour italiano ed europeo di Schegge, il suo nuovo disco, che lo terrà occupato tutta l’estate.







