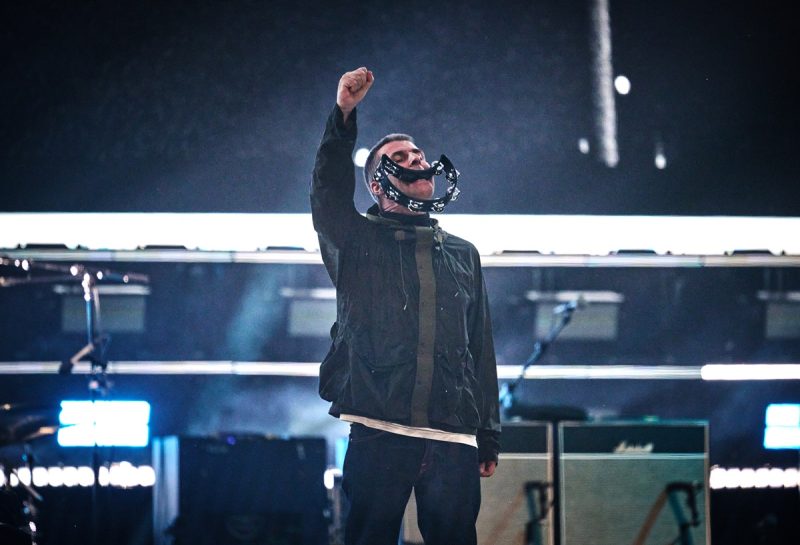Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Famiglie infelici e come ricordarle
Una conversazione con Andrea Canobbio, autore di La traversata notturna, in cinquina allo Strega 2023.

C’è una versione italiana e contemporanea dell’incipit molto abusato di Anna Karenina, quello che dice: «Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo». Sta nel libro La traversata notturna (La Nave di Teseo) di Andrea Canobbio, e dice: «Come sono difficili le cene delle famiglie infelici. Costretti a sedersi intorno al tavolo, ognuno al posto che l’abitudine o la gerarchia gli ha dato, sognando di alzarsi il più in fretta possibile». È dura descrivere un libro come La traversata notturna. Provo così: parla di un padre depresso e di un figlio-autore che cerca, attraverso i ricordi e i luoghi che custodiscono questi ricordi, di spiegarsi quella tristezza. Raccontato dall’autore, invece, suona così: «La storia dei miei genitori, della malattia di mio padre e di come tutto questo si intreccia con Torino, trasformata in una macchina della memoria che serve a rievocare i ricordi».
È arrivato alla finale dello Strega 2023 in un modo per me inaspettato, proprio per questa sua inafferrabilità. È bello, mi sono detto, che un libro così particolare – non voglio usare la parola “difficile”, perché la intendo in senso positivo, ma qualcosa di simile – possa arrivare a così tanti lettori. È un libro-smarrimento: fatto di digressioni, passeggiate, peregrinazioni, viaggi temporali e geografici. Sebaldiano, per usare un paragone e solo uno. Ipnotico: da quando i social hanno distrutto la nostra attenzione, è sempre più difficile stare “dentro” una storia senza uscirne continuamente, distratti e attratti da notifiche e altri schermi. Ne La traversata notturna questo non succede, e non perché ci sia, all’interno, chissà quale macchina drammatica in azione. È più invece il suo incedere che ti strega, la sua struttura labirintica che ti fa perdere, e tu, lettore, ti ritrovi a vagare pagina per pagina, esplorando il passato e la memoria dell’autore come un castello abbandonato. Andrea Canobbio è scrittore e anche editor di Einaudi. Una mattina di giugno l’ho chiamato per parlare di questo e altri libri.
ⓢ La traversata notturna parla della depressione di tuo padre, ma in un certo senso anche Torino è una protagonista. Io Torino non la conosco bene, però da lettore non mi ci sono sentito sperduto. Non è comune questa capacità di orientare il lettore.
La cosa determinante che ho sempre pensato è che la città del libro fosse una città immaginaria. Era una città che avevo nella mia testa, la Torino degli anni Settanta e Ottanta, la Torino dove avevo vissuto con i miei genitori. Come se fosse una città che avevo conosciuto solo io. Torino mi sembrava una città molto cupa e grigia, ma forse non lo era così tanto. Io ci aggiungevo questa coloritura della depressione che rendeva tutto nero.
ⓢ Poi c’è l’Italia, la Seconda guerra mondiale che segna l’amore giovanile dei tuoi genitori, la ricostruzione del Dopoguerra. La storia nazionale entra molto, in questo tuo romanzo, anche se all’apparenza non si vede.
La storia di mio padre ha ripercorso in un certo senso quella del Paese. Prima l’entusiasmo e l’energia della ricostruzione, del miracolo economico durante gli anni d’oro di mio padre, come ingegnere, marito, genitore. Poi questa parabola inizia a scendere, c’è la crisi degli anni Sessanta, e una certa sua scontentezza per il lavoro, in cui era sempre meno importante essere persone serie, rigorose, affidabili come lui. E la paura di non farcela, di non reggere più quei ritmi frenetici. Si arriva agli Anni di piombo. Questa espressione che usiamo è sinonimo di terrorismo, ma in realtà il piombo è il metallo della melanconia. La storia dell’Italia nel Dopoguerra descrive perfettamente l’ascesa professionale e umana di mio padre e la successiva discesa nella depressione.
ⓢ Mi è sembrato, La traversata notturna, anche un libro fuori dal tempo, che può vivere molti anni fuori da un preciso momento storico. Ha il respiro lungo, per così dire. È una cosa a cui hai pensato, durante la scrittura?
No, non è una cosa che ho cercato. Hai ragione, però: della melanconia in forma patologica si trovano tracce nei più antichi documenti della nostra civiltà. Da quando ho pubblicato questo libro un sacco di persone che conosco e che non conosco mi sono venute a dire: io in famiglia ho avuto il padre, la madre, il fratello, il cugino depressi. Non si vede ma ha una diffusione spaventosa. È un tema eterno, ma è necessario calarlo nella vita del nostro tempo per vederlo.
ⓢ Perché prima non la si chiamava depressione.
Questo è uno dei punti cruciali del libro. Perché l’idea della depressione come debolezza di carattere e fragilità quasi morale era un’idea radicata profondamente nella cultura. Fortunatamente le cose stanno cambiando. Parlo di sentire comune, non di scienza.
ⓢ È stata una cura, scriverne?
Questa è una delle domande che mi fanno sempre e ti rispondo come sempre: la scrittura è contemporaneamente ferita e cura. C’è un’attesa di efficacia terapeutica della scrittura che rischia di essere delusa. La terapia è un’altra cosa. Perché in realtà scrivendo non fai che riattivare quella ferita, e alla fine ti trovi spossato, esaurito, svuotato ma non guarito. Se la catarsi è questa, va bene chiamarla catarsi. Ma ho i miei dubbi.
ⓢ Per te cos’è allora il libro?
Era un modo per passare ancora del tempo con i miei genitori. E poi, in un senso decisamente magico, il pensiero di accompagnarli in un luogo lontano da me e rendere loro la libertà, lasciarli andare. Il significato della traversata notturna è questo, è la traversata che facevano i defunti sulla barca di Osiride nella mitologia egizia: venivano accompagnati verso un nuovo giorno, una nuova luce.
ⓢ Come esergo hai scelto una frase di Pavese e una di Ginzburg.
Una coppia ideale di genitori alternativi.
ⓢ Sono anche due scrittori che parlano con una voce simile. Tu ti senti in qualche modo uno scrittore italiano, che ha camminato sulla strada di una certa letteratura italiana?
Oh no. Io mi sono sempre sentito uno scrittore non italiano. Anzi mi hanno sempre detto che io non ero uno scrittore italiano tipico. Una volta Marco Belpoliti mi ha detto: tu sei uno scrittore europeo. Però io non l’ho preso esattamente come un complimento. Mi sembrava che volesse dire che non appartenere a una tradizione fosse un limite. A un certo punto del libro, però, costruisco per me una genealogia italo-francese: Calvino generò Queneau, Queneau generò Perec, Perec generò Leiris, Leiris generò Griaule.
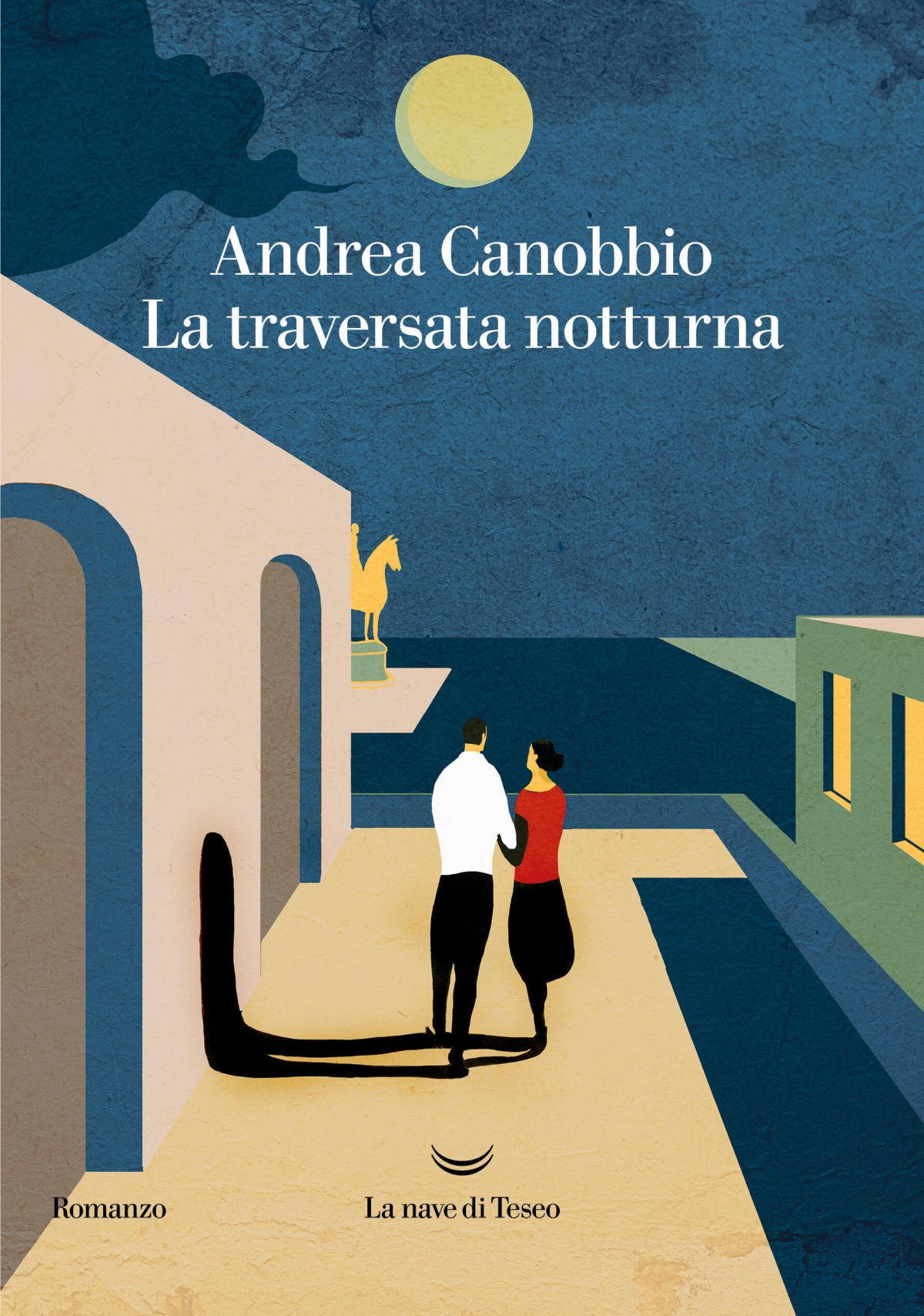
ⓢ Se non sbaglio Del Giudice diceva di sé di voler essere uno scrittore europeo.
In una certa misura oggi bisognerebbe pensare in senso più ampio a noi scrittori italiani come scrittori europei. Forse la tua generazione [i Millennial, nda] ci sta già pensando, non si pone nemmeno più il problema di appartenere a una tradizione italiana. Ma per me [Andrea Canobbio è nato nel 1962, nda] è diverso: io sono cresciuto negli anni Settanta, e allora questo era uno dei temi più importanti. Con le neoavanguardie degli anni Sessanta si era spezzato qualcosa, e tutti erano preoccupati di dove andava la letteratura italiana. Fondamentalmente non andava da nessuna parte perché non c’era più nessuno che scrivesse. Gli scrittori giovani erano così pochi che Celati, Del Giudice, Tabucchi e Tondelli hanno continuato a essere chiamati giovani scrittori anche quando avevano già 50 anni. Poi, una cosa importantissima che non viene detta abbastanza: già la mia generazione si è nutrita di traduzioni, di letteratura mondiale. Non siamo mai stati gli scrittori che leggevano i classici o i contemporanei solo del loro Paese.
ⓢ Il nuovo canone è costruito sulle traduzioni?
Assolutamente. Nella lingua che si usa. Quindi come minimo cerchiamo di allargare l’orizzonte e di considerarci europei.
ⓢ In Italia si scrive sempre di più di sé stessi, trovi?
Ma è chiaramente accidentale che quest’anno allo Strega ci siano tre libri autobiografici. Vedrai che l’anno prossimo sarà diverso. Gli scrittori italiani si dedicano soltanto ai memoir? No, direi proprio di no. E comunque è un’evoluzione presente anche in altri Paesi.
ⓢ C’è ancora una scrittura italiana, per te? Non per forza rappresentata da quello che vediamo allo Strega.
Non vedo dei caratteri nazionali nella scrittura di oggi. E non c’è niente di male.
ⓢ Non ti sembra ci sia una tendenza di mercato che premia i libri in cui i protagonisti sono in un certo modo vittime?
Proprio perché lavoro in una casa editrice, quando scrivo non mi interessa molto il discorso di cosa viene premiato dal mercato. Se non vivessi una scissione completa tra la mia vita da editor e la mia vita da scrittore, non scriverei più e non avrei mai scritto questo libro. Questo è un libro che io non pubblicherei mai, è troppo lungo! A parte gli scherzi: scrivere per me è uno spazio di libertà, e questo è esattamente il libro che volevo scrivere. E non credo che sia il libro di una vittima. Oppure sì: siamo tutti vittime della vita. Ma certamente non volevo fare del vittimismo.
ⓢ Come è cambiato lo Strega, visto dalla tua posizione?
Io ho partecipato nel Duemila, e oltre all’evento della cinquina e alla finale avevo fatto una sola altra cosa, una presentazione a Mantova. Da tre eventi siamo passati a ventisette, credo. Si è adeguato ai tempi ed è diventato un festival itinerante. Non è più soltanto un premio. È un’occasione unica, direi, per uno scrittore, di incontro con i lettori.
ⓢ In cui vincere conta meno?
Beh, io non ho nessuna possibilità di vincere, ma mi fa molto piacere andare in giro a parlare del mio libro.
ⓢ Cosa stai trovando interessante, oggi, con questo sguardo da editor e scrittore insieme?
La cosa che vedo adesso è una grande stanchezza. La pandemia ha avuto degli effetti pesanti sul mondo letterario. Tutti hanno scritto di più, ma non penso che in generale avere più tempo per scrivere – questa è la morale che ne traggo – faccia troppo bene agli scrittori. Forse avere meno tempo, ma essere più immersi nella vita fa meglio.