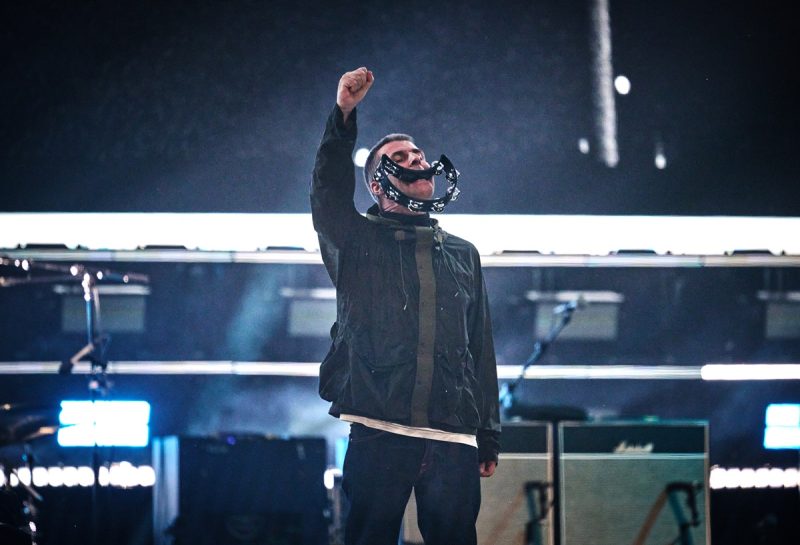Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Mi sveglio alle otto di mattina, e l’istinto di aprire Instagram è forte. Il telefono è sul comodino sopra la pila di libri, e penso che dovrei prendermi una sveglia analogica, ma non l’ho ancora fatto. Resisto: spengo l’allarme e metto giù il telefono. Devo pensare a lungo a ogni gesto da fare, come se fossi rallentato, o sotto l’effetto di una droga: è perché da un po’ di settimane sto cercando di disintossicarmi dai social e dallo smartphone, e se lascio che sia l’automatismo del mio cervello a decidere i movimenti, ci ricadrei subito. Porto lo smartphone con me in bagno, per fare la doccia. Lo appoggio sul piano del lavandino, accendo l’acqua, aspetto che si scaldi, e lo riprendo in mano un attimo, solo per togliere la modalità sonno, mi dico. Mi dico anche: devo solo mandare un Whatsapp alla mia ragazza, per salutarla. Ma il pollice va automaticamente sull’icona di Telegram, dove c’è il pallino rosso dei messaggi non letti. Mi domino, all’ultimo istante.
Un’ora dopo, sto leggendo un libro sul divano. Il mio cervello è ormai disfunzionale anche nel rapporto con i libri. Il volume che leggo è La traversata notturna di Andrea Canobbio, sono arrivato a pagina 410. È una lettura di piacere, non ha a che fare con il lavoro. Dalla libreria, messo di sbieco sopra altri libri, mi guarda un vecchio Einaudi di Bassani. L’ho comprato tre settimane prima. Lo prendo, leggo l’incipit, poi sfoglio qualche pagina per vedere come sono fatti i dialoghi, quali sono i tempi verbali usati. Mi serve, mi dico per giustificarmi, per un progetto di scrittura a cui sto lavorando, con certe similitudini tra i suoi personaggi e i miei. Lo rimetto via, devo concentrarmi sul libro di piacere. Leggo una pagina soltanto, poi mi cade l’occhio su un altro libro, questa volta di Daniele Del Giudice. Lo prendo in mano, penso che dovrei rileggerlo di tanto in tanto. Leggo una frase che avevo sottolineato anni prima. Lo rimetto giù. Riprendo il primo libro. Sono passati quindici minuti e non ho ancora letto con attenzione una sola riga.
Tutto questo non è una ricostruzione, ma la cronaca del mattino di domenica 19 febbraio 2023. È quello che succede al mio cervello da quando ho smesso (anzi: da quando sto cercando di smettere) di aprire Instagram, Twitter, Whatsapp e Telegram ogni minuto, come avevo fatto per anni, come facciamo tutti da quando ci siamo finiti dentro con tutte e due le gambe, fino al ginocchio e sempre più ingiù. È chiaro qual è il problema della mia attenzione spaccata dai social, un problema che in questa fase di detox si sta soltanto spostando dallo schermo dell’iPhone ai libri: l’impossibilità di abbracciare la concentrazione, la necessità bulimica di stimoli esterni, costanti, come una luce strobo che picchia senza sosta dentro al cervello.
Le giustificazioni che mi ripeto per rendere vana la mia resistenza sono del tutto simili a quelle che si dà un tossico: mi faccio una botta sola, una sigaretta sola, non esagero, che sarà mai, è solo stasera. Do solo un’occhiata veloce alle Stories. Rispondo al volo a quel meme appena arrivato nella chat di gruppo, poi metto giù il telefono, e torno a concentrarmi. E così via. Non succede solo con i social network: certe volte mi accorgo che ho digitato per la quarta volta in un minuto “repubblica.it” nel browser, e per la quarta volta in un minuto sto leggendo un titolo che parla di Giorgia Meloni, o Matteo Salvini, o della guerra in Ucraina, e me ne rendo conto soltanto in quel momento. Perché prima no? Perché ho continuato ad aprire la homepage di un quotidiano soltanto per guardarla e chiuderla un secondo dopo, e poi riaprirla come se me ne fossi dimenticato all’istante? Non lo so.
A fine 2022 ho letto questo articolo del New York Times che parla del “Luddite Club”, una piccola associazione di adolescenti di New York che hanno deciso di rinunciare allo smartphone, scegliendo di vivere con un flip phone – quei telefonini anni Zero o Novanta, tipo Startac, che sanno telefonare, mandare sms e non hanno internet. Questi teenager luddisti (che si ispirano cioè a Ned Ludd, personaggio popolare o inventato che secondo la leggenda scatenò una rivolta operaia contro dei telai meccanici in Inghilterra a fine Settecento, provando a opporsi alla Rivoluzione industriale) si ritrovano ogni settimana a Prospect Park senza bisogno di darsi appuntamenti via messaggio, nello stesso posto e alla stessa ora, e lì parlano, leggono libri, disegnano, oppure respirano a occhi chiusi e non fanno niente. Una di loro ha detto alla giornalista: «Da quando ho preso un flip phone, le cose sono cambiate in fretta. Ho iniziato a usare il cervello. Mi ha anche fatto osservare me stessa in quanto persona».
È difficile liberare il pensiero dalle catene a cui l’hanno costretto lo schermo e i social network nel giro di pochi anni. Una prova di quanto sia profonda questa schiavitù è l’urgenza di fotografare un manufatto artistico, un panorama o uno scorcio naturalistico quando ce lo si trova davanti. La sensibilità e lo stupore si sono messe al servizio dei like, e ci viene ormai automatico tradurre il valore estetico e sentimentale di una visione – un quadro di Carlo Carrà, le cascate della Marmora, la Scala dei Turchi ad Agrigento – nei possibili like che potrebbe prendersi la bellezza. La creatività lavora per l’algoritmo. Nel 2002 esce il libro di Richard Florida L’ascesa della classe creativa, in cui il filosofo la definisce la merce più importante del secolo appena iniziato. Vent’anni dopo ci accorgiamo che aveva ragione, Florida, sull’importanza della materia prima in questione, ma che le cose non sono andate bene né per la creatività né per la classe creativa: la prima non è stata coltivata, ma allevata in modo intensivo, e gli animali in batteria siamo diventati noi. Una frase di Anna Longo che ho trovato su Le paludi della piattaforma, il saggio di Geert Lovink uscito a dicembre 2022 per NERO, dice: «Una volta si sfruttava la forza del corpo per produrre beni; poi si è cominciato a sfruttare l’energia del desiderio per consumare beni; ora si sfrutta la creatività per produrre il sé come un bene».
Geert Lovink ha scritto un Vangelo al contrario per questi tempi devastati e imbecilliti, una cattiva novella sulla palude virtuale in cui galleggiamo. C’è, in fondo al libro, anche la parte costruttiva, ma è la descrizione del panorama in cui ognuno di noi può riconoscersi la parte più lunga, spietata e interessante. Mentre facevo i conti con quel che resta della mia capacità di concentrazione, leggevo quello che mi sembrava la miglior diagnosi che avessi mai trovato: «Siamo arrivati alla fase che Bernard Stiegler ha definito “miseria simbolica”», dice Lovink, «un’era di stupidità simbolica dovuta al processo decisionale automatizzato». Tutto il tempo passato a scegliere la caption giusta per una foto delle vacanze è riassunto qui: «Questa condizione si traduce in una crescente incapacità di ritenere le osservazioni e in una perdita nella capacità di teorizzare».
In un modo diverso dai social, anche Netflix è responsabile dell’esaurimento psichico di questi anni. Scrive Lovink: «Nel bel mezzo del lockdown, Netflix ha capito che gli utenti erano pronti per tornare a fare zapping: “Non sai cosa guardare? Scegli Play Something”. Potremmo chiamarla inflazione di suggerimenti, la tendenza a girare in tondo, nonostante l’offerta di contenuti in continua crescita». Praticamente: piuttosto che pensare a un pensiero veramente originale, venuto su dal niente, modellato con calma, preso per mano e portato da qualche parte che ancora non sai, piuttosto che tutto questo: guarda qualsiasi cosa. Un attacco al senso critico, al concetto stesso di preferenza e volontà. Va bene tutto, purché sia qualcosa. La cosa ironica è che, mentre ci troviamo poi sul divano pronti per immergerci in quella che negli anni Dieci veniva chiamata “Netflix and chill”, è impossibile raggiungere quel rilassamento. «L’irrequietezza impedisce un vero senso di svago e distrazione. Nonostante il desiderio di staccare la spina e di farci intrattenere, la mancanza di concentrazione è fin troppo reale».
Sempre Lovink, più avanti, parla di cosa succede quando ci immergiamo nel cosiddetto “chill”: «Quando ci sediamo sul divano e iniziamo a guardare video, accettiamo che non faremo nulla di ciò che avevamo programmato. Non abbiamo bisogno di ricaricarci. Abbiamo bisogno di sottrarci a una verità più scomoda: siamo diventati individui che accettano la sconfitta piuttosto che lottare». L’ode del divano è diventata un topos da social network: influencer producono merchandising che celebra una anticipata “anzianità”, il chiudersi in casa dopo una giornata lavorativa passata, anche quella, davanti allo schermo. I nostri amici chiedono, sulle loro Stories: «Mi consigliate qualcosa da vedere?», come se la distrazione andasse programmata con qualsiasi contenuto, anticipando il bisogno. Se il suggerimento non arriva, passiamo ore a cercare un film o una serie in un labirinto di suggerimenti “Scelto per te” e categorie create ad hoc. «Ci ripetiamo che i giorni avventurosi sono finiti. Dovremmo solo accontentarci di guardare le avventure degli altri dal nostro comodo divano».
Non c’è bisogno di uscire, e poi i centri sociali stanno scomparendo, le periferie vengono gentrificate, l’underground muore perché, in un sistema in cui tutto è rappresentazione, in cui la rappresentazione è definizione di sé, niente può essere taciuto e tenuto nascosto, e quindi è tutto overground. Mentre un tuo coetaneo siriano, sottopagato e senza assicurazione, sta pedalando attraverso la città per portarti in ascensore un burrito al salmone, vedi su Instagram il cartello di una digital activist contro un articolo di Repubblica. Non l’hai letto, non sei abbonato ai quotidiani online perché ormai fanno schifo, sono tutti video pruriginosi di animali e influencer. Su TikTok segui ironicamente la vita quotidiana trash di un’adolescente campana. Alle elezioni regionali amministrative del febbraio 2023 votano 4 elettori su 10. La collettività perde forza, la partecipazione politica attiva crolla. Le piattaforme si travestono da megafono politico, ma liofilizzano la complessità del messaggio e ti illudono che sia abbastanza. Anche questa è un’azione politica.
La cancel culture può essere vista come figlia dell’antropologia dei social: se prima, con la cultura internettiana del forum – piattaforma di discussione aperta all’incontro, allo scontro, alla discussione e alla ricerca di una sintesi – esisteva un sistema basato su un upvoting e un downvoting di un messaggio o un utente (per chi c’era: le stelline sotto il nome utente), i social hanno eliminato il principio del downvoting. Non è marketizzabile. Meta ha inventato la reaction arrabbiata, quella triste, che però, nei fatti, remano nella stessa direzione del like. Sui social puoi solo smettere di seguire, bloccare. Non c’è dialettica: se non mi piace un tuo contenuto, lo nascondo, ti blocco, decido di non vederti mai più. La dialettica si fa sempre più semplice, essenziale, salomonica.
Le paludi dei social ci trasformano in esseri essenziali, con pochi bisogni basilari. Sembra si stia avverando la previsione disegnata su certe felpe da boomer conservatore: la scala di evoluzione della razza umana da scimmia a Sapiens Sapiens fino alla nuova discesa in un uomo seduto alla scrivania chino davanti a un personal computer o a uno smartphone. Le piattaforme danno una dipendenza a tutti gli effetti, ma non esiste nessun discorso ufficiale – né esisterà mai, probabilmente – che prenda atto dei rischi e dei problemi che internet causa alla psiche. L’assenza di attenzione sembra quella dei decenni Settanta, Ottanta e Novanta verso il cambiamento climatico, prima della catastrofe finale.
Affacciàti alla finestra, scrutando verso il futuro, i segnali di speranza sono pochi. Certo, un internet pubblico, un web decentralizzato, smantellamento del monopolio. Bei programmi, ma con istruzioni difficilissime, sogni da Don Chisciotte, quasi. Eppure, più concretamente sembra che la dittatura dei social stia lentamente scemando. Anche Instagram, sempre più impegnato a rincorrere il modello TikTok, sta vivendo un lento “effetto-Facebook”: ovvero un esodo di utenti – che non corrisponde per forza a una disiscrizione – verso altri lidi. In uno degli articoli più letti del New York Magazine del 2022 il “trend forecaster” Sean Monahan, l’inventore del termine “Normcore” e anticipatore di una serie di tendenze, ha detto: «Mi sembra che la traiettoria degli anni Dieci si sia esaurita. I social media non sono più un posto in cui puoi essere creativo; tutto è stato esplorato». Ci dovremo arrivare passo per passo. Re-imparare una grammatica comportamentale perduta. La noia. La lentezza. L’inattività e la pigrizia. Io, per iniziare, dovrò comprarmi una sveglia analogica da mettere vicino al comodino. Partire da quella.
Questo pezzo è tratta dal numero 54 di Rivista Studio. Per acquistarne una copia, potete andare qui.