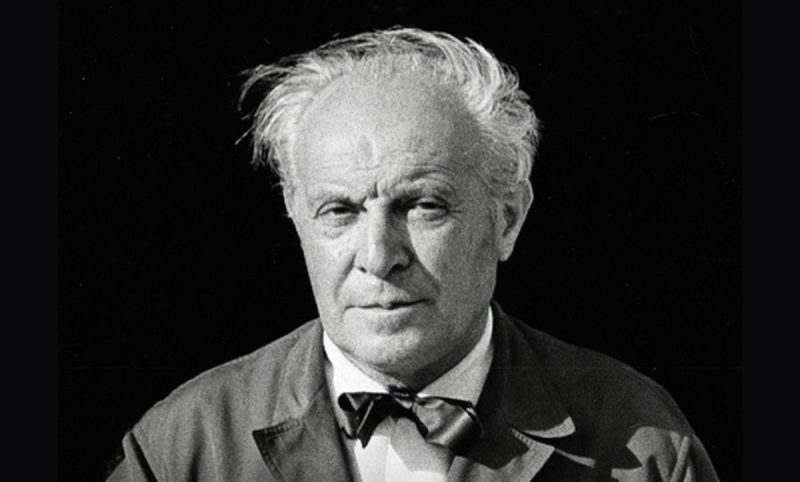Proprio come nel suo canale, diventato famosissimo durante la pandemia e attivo ancora oggi, sarà un posto dove studiare e rilassarsi insieme.
Questo articolo è parte della nostra serie estiva “Gran Turismo” , in cui le autrici e gli autori di Rivista Studio raccontano luoghi e città dal punto di vista del turista o di chi i turisti li subisce. È un modo, un po’ più leggero, per continuare a far vivere il nostro numero estivo, tutto dedicato al turismo: da come, negli ultimi anni, sia diventato un problema politico (overtourism), a come nonostante tutto, il viaggio continui a conservare una sua dimensione romantica. Lo trovate in edicola e sul nostro store online.
Cadaqués era il posto ideale per noialtri. Difficile da raggiungere. Una sola strada. Niente stazione. Niente treni. Un posto che conservava lo spirito della Spagna dei poeti e del contrabbando, la luce slavata dei dipinti, i bar pieni di fumo, il mare gelido e le cene improvvisate con alici, paella e vino bianco scadente. Una specie di Woodstock per aristofreak tardivi, che mescolavano club culture milanese, occhiaie da after e aspirazioni da artisti maledetti. Un avamposto che aveva il sapore di certi luoghi di frontiera, marginale e poetico, da raggiungere dopo tre ore di autobus da Barcellona, trascorse a osservare dal finestrino sporco di salsedine i vigneti bruciati dal sole. C’erano ancora le vecchie case degli “americanos”, i ruderi sulle alture, le spiagge frequentate da nudisti, gli scogli presidiati da punkettoni francesi e inglesi ubriachi. Il borgo era tutto una salita, le case tutte bianche e il porticciolo era totalmente invaso dalle piccole e coloratissime barche dei pescatori. Noi dicevamo che eravamo lì per Dalì, anche se poi nessuno era mai andato nemmeno una volta a visitare la casa-museo. Avevamo vent’anni e nessun senso del limite. Ci sentivamo banditi in rovina, con i nostri zaini sulle spalle, le camicie hawaiane, gli occhiai scuri e il collo sudato. Eravamo sporchi, sbronzi, troppo magri e inutilmente felici. O almeno così ci sembrava.
Cadaqués, 7 agosto 2000
La stanza ha un odore nauseabondo. Fede fuma sdraiato su un materassino gonfiabile, ha la maglietta degli Orbital bucata in due punti e gli occhi completamente ribaltati. Apre la bocca, ride, poi si gratta il collo e mormora: «Villalobos ieri sera era Dio. O Satana. Non lo so». Siamo tornati da qualche ora da un after all’Hostal, un ex convitto vista mare gestito da tre ragazze catalane e da un hippy con la coda che, dietro al banco del bar, preparava i cocktail in delle enormi bacinelle di plastica gialla. Villalobos ha messo i dischi dalle quattro alle nove del mattino.
Adesso tutto è fermo e siamo ricoverati in uno dei bungalow del campeggio con la bocca impastata e la lingua che sa di alluminio. Fuori c’è una temperatura folle. Dentro è ancora peggio. Non riesco a dormire, così mi alzo giro per la stanza confuso alla ricerca delle sigarette e mi soffermo su una copia del Corriere della Sera abbandonata sul tavolo sotto due lattine di Estrella vuote. Non so da dove venga. Chi l’ha portata qui? Forse Fede. O la fotografa di Torino che dorme nel bungalow di fianco al nostro. Lo prendo in mano. È di ieri ma decido di aprirlo lo stesso. Lo apro a caso, lo sfoglio e poi, all’improvviso, vedo la foto di una ragazza e un nome: Cristina Cetti Serbelloni. Morta. Ventinove anni.
Mi viene un conato, esco dal bungalow ma il mare è troppo blu e la luce mi fa male agli occhi. Poi rientro, vado in bagno, mi lavo la faccia e mentre mi guardo allo specchio, completamente sconvolto, nel riflesso dietro di me Fede, mi osserva e mi dice: «Stai bene?». Io non rispondo. Cerco il mio zaino e ci butto dentro alla rinfusa un paio di jeans, una maglietta, una felpa grigia con il cappuccio e una bottiglietta d’acqua mezza calda. Esco. Barcellona in autobus, poi treno per Milano. Non piango, non parlo, non chiamo nessuno a casa. Non dico a nessuno che sto tornando.
Milano, aprile 1996
La casa degli zii affacciava sul Parco delle Basiliche, ma dentro sembrava di stare in un altro secolo. Velluti, fiori dappertutto, tende pesanti che lasciavano passare solo spiragli obliqui di luce verde. Vicino alla finestra, ad osservarmi, il busto del nostro bisnonno, il poeta, Zanco Zerkovsky campeggiava su un tavolino rotondo in radica. Era un pomeriggio d’aprile e in salotto c’era solo Cristina con le gambe nude, raggomitolate sul divano, coperto da un telo di lino e mohair. Diceva che le prudeva tutto, «colpa delle fragole», mormorava, grattandosi il braccio con due dita laccate di bordeaux. Ne aveva mangiate una vaschetta intera in terrazza. Le avevano dato l’orticaria. «Non sono andata a lavorare per quello». Indossava una camicia oxford rosa Ralph Lauren con i bottoncini del collo slacciati e un paio di shorts color panna. Era bellissima anche così, con quei piccoli sfoghi rosa sulle braccia e un’espressione vagamente altrove, simile ad una di quelle ragazze francesi delle canzoni degli Air. Ascoltava i Duran Duran in sottofondo da uno stereo Bang & Olufsen incastrato tra porcellane e libri d’arte. Il volume era basso ma si sentiva chiaramente che il pezzo che stava andando era “Notorious”. Io sedevo in un angolo, su una poltroncina foderata di broccato con gli occhi fissi su di lei e un libro di poesie poggiato sulle ginocchia. Poi mi guardò e lasciò cadere il vecchio numero di Vogue che stava sfogliando e mi disse: «Tu hai la faccia di uno che si inventa le cose».
Moltrasio, 8 agosto 2000
L’MD durante il viaggio è svanita del tutto ma ho ancora la mascella tesa e la schiena che trema. In Stazione Centrale a Milano decido di non passare da casa e prendo un biglietto per Como. Arrivato a Moltrasio il lago è immobile e tutto sembra troppo pulito, incredibilmente calmo. Mi tolgo la Fred Perry. Nel mio zaino pieno di toppe dovrei avere una maglietta pulita, piegata male, di fianco alla copia del Corriere con dentro la foto di mia cugina. Trovo una T-shirt bianca senza scritte. Me la infilo. Mi sistemo i capelli con le dita. Non vado alla villa, salgo direttamente alla chiesa su in paese, a piedi, sotto il sole. Cammino piano. Respiro a fatica.
Quando arrivo stanno già iniziando. La chiesa è piena zeppa e dentro il fresco si mischia ad un odore di legno e incenso. Mi siedo in fondo. Sembro un naufrago. Nessuno mi guarda. In prima fila ci sono tutti: Zio Nando, Zia Zena e i miei cugini Gian Mario e Giorgio con le fidanzate. Le camicie bianche. Le lacrime silenziose. Mio fratello non c’è. È rimasto in Sardegna, come mio padre quando è morto il nonno. Stesso stile. Stessa distanza. Poi la cerimonia finisce, io esco per ultimo, tolgo i Ray-Ban per un attimo, poi li rimetto, perché il sole mi arriva dritto in faccia. La bara è portata fuori a braccio da sei uomini vestiti di nero, il rumore delle scarpe sul selciato, fiori bianchi sopra, gardenie, magnolie e orchidee ovunque. Sento i flash delle macchine fotografiche. Secchi, rapidi. Un clic dopo l’altro. I Serbelloni sono un nome in zona. La tragedia è una notizia. Giorgio mi fa un cenno da lontano: la testa in avanti, «Vieni». Prima fila. Appartenenza. Alzo la mano ma non vado, mi sposto, mi faccio largo tra due signore vestite di nero, – «Emorragia interna», dicono, «povera ragazza» – e scendo verso il molo. Al lido mi spoglio, tolgo la maglia, i jeans, le scarpe. Le appoggio una di fianco all’altra. Resto in boxer come un raver impazzito e cammino scalzo tra le crepe del selciato tra i cipressi ed i fiori freschi verso il lago. Entro in acqua. Cammino fino a non toccare più. Poi mi giro e resto fermo ad osservare il cielo azzurro con la testa piegata all’indietro.
Quando è arrivato il motoscafo ci sono salito ancora bagnato, senza dire niente, senza guardare indietro, mentre alle mie spalle sfumava il ricordo delle gardenie, delle Mercedes nere, dei necrologi con i nomi importanti. All’epoca nella cappella del piccolo cimitero c’erano solo Cristina e mia nonna. Oggi a venticinque anni di distanza ci riposa più di metà della mia famiglia.

Nato con scopi educativi, prima di essere commercializzato, il famoso gioco da tavola incarna da decenni il capitalismo immobiliare. Ma una nuova versione si propone adesso di ritornare al suo senso originario.