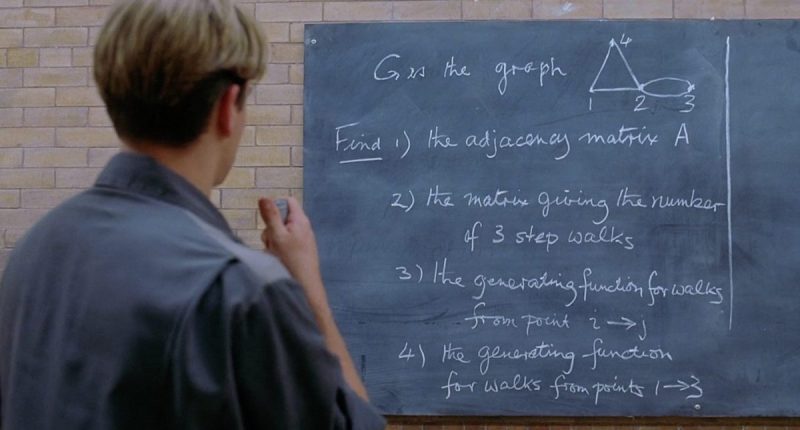La serie, con protagoniste Sarah Snook e Dakota Fanning, sembra un thriller ma in realtà è tutta una grande storia sulla sisterhood che vince sempre. E sull'impossibilità degli uomini di uscire puliti da qualsiasi situazione.
Pluribus è una serie che dà il meglio di sé a televisore spento. Per godersi al meglio la nuova opere del creatore di Breaking Bad Vince Gilligan, infatti, servono due cose: un abbonamento a AppleTV e un’app di messaggistica con cui mandare vocali a chi tra gli amici la sta seguendo.
Se per indole o abitudine trovo la programmazione settimanale delle serie infinitamente superiore all’esperienza del binge watching, questo è particolarmente vero per Pluribus. Se fosse uscita in blocco mi avrebbe privato del rito settimanale di spegnere la tv e far partire il primo vocale per questo o quell’amico. Talvolta esprimere pensieri complessi sul contrapporsi tra una mente collettiva aliena e “l’essere umano più triste rimasto al mondo” può dimostrarsi sorprendentemente complicato, specie quando ti sfuggono termini in inglese come “etilometro”.
Una premessa strepitosa
Pluribus infatti si regge su soli due elementi: una premessa strepitosa e la volontà di esplorarla senza mai ricorrere a soluzioni di comodo. Il punto di partenza è l’ennesima fine dell’umanità come la conosciamo. Solo che stavolta l’apocalisse non è esattamente un’invasione aliena né esattamente una distopia. Degli scienziati umani intercettano un segnale dallo spazio, riescono a interpretare e replicare il messaggio genomico che trasmette, solo che – ops – questo finisce per infettare l’intera umanità. Nasce così una mente collettiva che contiene tutte i ricordi personali dei miliardi di individui che ha contagiato, che condividono questa super coscienza onnisciente che controlla ogni singolo corpo.
La protagonista della serie è uno dei dodici individui che, per ragioni sconosciute, sono immuni al contagio. Mantiene quindi la sua individualità mentre deve affrontare la scomparsa repentina del mondo così come lo conosceva, che per giunta ha causato la morte dell’unica persona a lei cara. Già frustrata, depressa e insoddisfatta della sua vita, Carol Sturka si ritrova ad affrontare un lutto che la getta in una solitudine devastante, acuita dal dover interagire con questa sorta di alveare umano non violento, sorridente, incapace di mentire, che però non le nasconde che il suo fine ultimo è di trovare il modo di inglobare anche lei, volente o nolente. Si spalanca un potenziale narrativo infinito, tutto racchiuso nel confronto tra i limiti evidentissimi dell’individualità umana e un collettivismo estremo, che risolve istantaneamente una mare di problemi causati dalla natura umana, ma con la sensazione che nell’alveare umano non ci sia spazio non dico per il dissenso ma proprio per provare alcunché che vada oltre una contenta operosità.
Allegoria!
Di questo e di molto altro dunque si può parlare con gli amici, sicuri di arrivare sempre a discutere, argomentare, litigare. La premessa di Pluribus infatti è vaga abbastanza, o forse specifica abbastanza (dipende dai punti di vista), per passare le ore a cercare di capire di cosa sia l’allegoria. Del pensiero occidentale individualista contro quello orientale collettivista? Della percezione americano-centrica con cui ogni statunitense guarda al mondo? Oppure bisogna passare a un piano superiore (filosofico-religioso) o magari un più basso (socio-economico). E se Pluribus fosse una versione più articolata del celebre paradosso del carrello, in cui l’omino deve scegliere se deviare il treno per salvare un gruppo di persone legate ai binari sacrificandone una che, in teoria, sarebbe al sicuro o fare il contrario?
Per esperienza personale non importa chi sia l’interlocutore, dai massimi sistemi si finisce sempre per scivolare in un’analisi ben più individualistica (casualità?) sul grado di stronzaggine della protagonista. Sarà che io Carol la trovo poco o per nulla cattiva e grandemente comprensibile nelle sue mancanze, ma è di gran lunga il mio argomento di discussione preferito. Anche perché Vince Gilligan stesso ha costruito la serie attorno a Rhea Seehorn, cucendole addosso la disperazione di Carol, lasciandola da sola in scena per lunghi tratti a portare avanti la storia, dicendo chiaramente che la serie andrà avanti solo se l’interprete continuerà ad aver voglia di indossare i panni di questa donna non propriamente gradevole.
Ovvio che poi uno finisce a interrogarsi su come agirebbe se avesse a che fare con una mente collettiva molto incline a soddisfare ogni capriccio, ma alla fine si torna sempre a Carol, definita da molti come francamente insopportabile. Lo trovo di gran lunga l’aspetto più affascinante della serie, perché Carol ha in sé ciò che rendeva Walter White, Patrick Melrose o Jackson Lamb grandi personaggi: una personalità abrasiva, un cinismo abissale, una disillusione rispetto alla propria vita e al mondo. Tutti quei tratti negativi che rendevano questi personaggi grandi, rendono invece Carol una grande stronza.
Bella stronza
Succede proprio perché questi tratti sono raramente associati a un personaggio femminile, soprattutto a queste condizioni: Carol non è moglie, né compagna né madre, ma è una professionista di successo della cosiddetta industria creativa, autrice di una serie di romanzi best seller che però disprezza profondamente. È quindi intelligente, talentuosa, ma molto solitaria, perché non ha costruito la sua vita attorno a una famiglia. Un punto di partenza solitario che è quasi sempre prerogativa dei personaggi maschili, specie di quelli in cui stabilire dove corra la linea tra l’essere stronzi ed essere carismatici è particolarmente difficile.
Questa dissonanza Gilligan la gestisce particolarmente bene, perché parte dal mondo in cui viviamo noi ora, in cui a livello individuale e collettivo a una donna è consentito essere stronza sì, ma entro certi limiti. A differenza di Jackson Lamb, Carol cura la sua igiene personale e a differenza di un dottor House o di un Walter White è una persona sì depressa ma ad alta funzionalità sociale. All’inizio della serie la vediamo interagire con i fan del suo libro ed è semplicemente perfetta: falsa sì, ma deliziosa, complice, disponibile, paziente con i momenti d’imbarazzo altrui. Quando l’umanità diventa un collettivo reagisce molto male, spesso egoisticamente, ma mai completamente priva d’empatia. Per giunta non può nemmeno arrabbiarsi, perché questo manda in crash la mente collettiva. Ogni volta che Carol perde il controllo, milioni di persone muoiono, trasformandola nella «più grande assassina della storia umana dai tempi di Stalin».
Non è certo la prima stronza del piccolo schermo, sia chiaro. Lo era Glenn Close (una che sull’essere stronza ci ha costruito una carriera) in Damages. The Good Wife ha costruito una serie epocale sulla genesi di una stronza partendo da, appunto, una buona moglie e madre, stagione dopo stagione. È, inoltre, la versione preferita, la stronza, della Nuova Lesbica televisiva (e guarda un po’, Carol è queer).
La differenza con la lunghissima progenie di protagoniste stronze però sta nel fatto che, che ci piaccia o no, Carol rimane la prospettiva privilegiata attraverso cui assistiamo alla fine dell’umanità e all’inizio di un’altra cosa, ancora tutta da capire. Le donne stronze già le mal tolleriamo, a meno che non rientrino in uno stereotipo a cui siamo abituati (la madre stronza, la moglie stronza, la zitella stronza e via dicendo). Figurarsi quando poi ricoprono quel ruolo solitamente maschile verso il cui cinismo e la cui cattiveria provare empatia e ammirazione.
Spesso, quando vedo Carol, penso che sia costruita talmente bene da metterci ancora più a disagio dell’entità aliena, per come ci manda in crash con la sua rabbia, con la sua cattiveria. Un po’ come faceva un’altra scrittrice queer di successo bollata come stronza e assassina che finiva (letteralmente) sul banco degli imputati: Sandra di Anatomia di una caduta. E anche lì era tutto un discutere via vocali o agli aperitivi tra chi era assolutamente certo che fosse colpevole e gli innocentisti di ferro, che vedevano una certezza laddove nella sceneggiatura c’era solo una curatissima ambiguità. Perché alla fine quanto troviamo stronze e colpevoli le Sandra e le Carol della tv e del mondo, quanto è difficile infilarci nei loro panni, quanto somigliamo alla mente collettiva di Pluribus.

L'evento si terrà in diretta streaming sui canali YouTube della Fondazione Umberto Eco e della Fondazione Bottega Finzioni Ets, con inizio alle 12 del 18 febbraio, ora italiana.

Il film di Chloé Zhao, candidato a 8 Oscar e da poco uscito anche in Italia, racconta la storia di una famiglia devastata dalla morte di un figlio. Lui, William (Shakespeare), ne scriverà. Lei, Agnes, dovrà trovare il suo modo di sopravvivere.