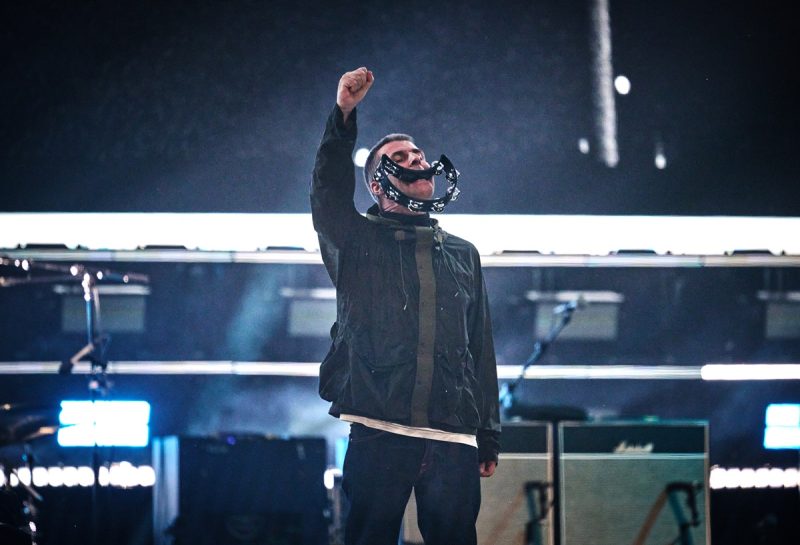Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Piero Portaluppi, dall’Italia del Ventennio alla Milano di Instagram
Architetto tra i più noti durante il regime fascista, ha costruito i luoghi della nuova Milano turistica: tutta la sua opera è stata ora raccolta in una grande monografia curata da Skira e dalla fondazione Portaluppi.

Negli stessi giorni in cui finiva il restauro del Palazzo del Fascio di Lissone, costruito nel 1940 da Giuseppe Terragni, ritornava il dibattito sull’obelisco del Foro Italico, dove la scritta “Mussolini Dux” accoglie gli atleti che hanno appena attraversato il Tevere. È un dilemma che ogni tanto si riaccende, e che negli ultimi anni è stato rifomentato dagli energici movimenti che dalla Francia agli Stati Uniti vogliono fare un’opera di pulizia delle statue di uomini considerati lesivi alla memoria delle popolazioni colonizzate o di certe minoranze, come schiavisti o esploratori. A Milano è successo con la statua di Montanelli, spruzzata di rosa.
Nel clima post-coloniale della rilettura del mondo – e delle intenzioni – così come nei tentativi giurisprudenziali che vedrebbero i rimasugli decorativo-propagandistici del ventennio soggetti all’articolo 4 della legge Scelba, c’è qualcosa che sopravvive: l’architettura. Le statue dei comandanti e degli imperatori cadono, da sempre, ma gli edifici costruiti sotto il loro benestare vengono restaurati e trovano nuovi usi. Si possono staccare le aquile, le falci e i martelli, i fasci e le svastiche da portali, pareti, timpani e stipiti, ma l’architettura prodotta da e durante la dittatura resta, giustamente, intoccata. Al massimo, restaurata, ma sfugge all’iconoclastia. Non solo uno smantellamento sarebbe complicatissimo e costosissimo, ma sarebbe un delitto: la cosa più bella a uscir fuori dai regimi oppressivi, spesso, sono case, palazzi, torri. E col fascismo italiano questo è più vero che mai, dal razionalismo-funzionalista di Terragni al monumentalismo di Piacentini, passando per Franco Albini e Adalberto Libera.
Il periodo più buio del secolo breve ha prodotto le location più amate della nuova Milano turistica. l’Olimpo degli influencer ha trovato nella villa Necchi Campiglio il suo luogo d’elezione. Tempio della foto Instagram wesandersoniana, con gli scatti all’oblò del bagno e stories dei divani verde pastello del salotto, ci si mette in posa a bordo piscina con i Wayfarer o imitazioni Linda Farrow rettangolari, ricreando atmosfere da jet set italico con filtro Oslo. Un precursore dell’estetica chic-tumbleriana come Luca Guadagnino non a caso aveva usato la villa per il suo film Io sono l’amore, con Tilda Swinton vestita da Jil Sander. Gli architour della città la mettono come prima tappa dei must-see meneghini, per farla seguire poi dal Planetario Hoepli, o dal Palazzo della Società Buonarroti-Carpaccio-Giotto, o dalla Casa degli Atellani. Sono tutti lavori di Piero Portaluppi, che diventa così il più social degli architetti degli anni trenta. L’atticismo dei palazzi INA e della banca Commerciale Italiana segnano la modernità del centro di Milano e, oggi, il suo mood business-chic.
Come succede con Carlo Scarpa a Venezia, il suo portfolio equivale a una buona percentuale dei gioielli architettonici novecenteschi che si trovano nelle guide milanesi, e nei feed di Meta. Lo stesso sagrato del Duomo, catalizzatore di migliaia di selfie all’ora, è progettato da Portaluppi che sceglie la pavimentazione nel 1928. Ci tornerà più avanti per costruire, insieme a Magistretti, Muzio e Griffini il palazzo dell’Arengario, rivestito in marmo di Candoglia, che oggi ospita il Museo del Novecento e una succursale del ristorante Giacomo, nonché ottima photo-opportunity con il Duomo alle spalle.
Non possiamo dire che Portaluppi fosse un architetto di regime, anche stilisticamente il suo eclettismo si distanzia dal razionalismo più assolutista – seppur sia sua la magnifica torre littoria, sede della Federazione dei fasci milanesi, di Piazza San Sepolcro, luogo d’origine del movimento. Ma come disse lui stesso in una conferenza, «lo stile fascista in architettura certamente sarà e segnerà una delle più belle tappe dell’arte nostra». Iscritto al partito sul tardi, come molti italiani il suo rapporto col regime è sfumato da gesti altruistici, come aiutare l’amico Saul Steinberg a fuggire dal paese. Uscì prosciolto dai processi di epurazione post-liberazione. Nato nel 1888, imparentato con Gadda, Portaluppi in gioventù con lo pseudonimo Don Pedro Puerta Lopez aveva fatto il caricaturista per il Guerin Meschino, settimanale satirico. A meno di venticinque anni progetta le prime centrali idroelettriche, a Fivizzano e a Verampio. Dalle sue biografie escono fuori infiniti interessi, dalla filatelia al cinema – gli piaceva riprendere scene di vita e architettura, fare filmini. Ancor prima della morte, nel 1967, un oblio della sua opera. I palazzi restano su, ma senza esser onorati e studiati. È dimenticato. Insieme alla mostra in Triennale del 2003, molti vedono nel restauro e nella celebrazione di Villa Necchi-Campiglio il suo ritorno come rappresentante della città.
Ora per continuarne il ricordo e la glorificazione è uscita una grande monografia per Skira con collaborazione della fondazione Portaluppi. L’ha curata Piero Maranghi, che non è solo regista, viveur dedicatissimo alla musica classica, ma anche nipote dell’architetto. Portaluppi, da cui ha preso il first name, era il suo bisnonno. Nell’introduzione ringrazia l’avo, “per un mondo pieno di fantasia, eleganza, cromatismi, ingegnosità”. Nelle belle foto di Ciro Frank Schiappa viene fuori una dimensione rarefatta, ad alto potenziale cinematografico. Risaltano le ombre e la pulizia e il modo unico in cui Portaluppi gioca con i materiali, soprattutto minerali. I marmi e le pietre sono per lui allo stesso tempo tavolozza da cui tirare fuori il tono di colore perfetto per quel particolare punto, e celebrazione della casualità naturale della venatura. Basta passeggiare in Piazza Diaz, sotto quei portici nerissimi con archi e oblò e i riflessi della luce, o guardare la facciata della Sede della Società Metallurgica Italiana, in via Leopardi, con quei morbidi rosa, ammorbiditi ancor di più dalle forme curve di finestre e balconcini.
Nello studio Portaluppi teneva un generoso campionario di marmi comprato da un collezionista romano. C’è poi, altra caratteristica portaluppiana, un lavoro sullo spazio da riempire, che lo differenzia dai suoi più metafisici, dechirichiani, colleghi contemporanei. L’architetto non sembra ragionare sul riempire o svuotare, ma sul lasciare spazio a ciò che verrà inserito dentro. Vuole costruire accoglienza, intimità. E c’è, come nei grandi registi, un lavoro autoriale, di selezione e di precisione del decoro, che va dai pavimenti ai copri-termosifoni. Nel libro un altro Piero, un altro membro della famiglia, il nipote Castellini, che ha decorato le case della più estrosa alta borghesia milanese, dice nell’intervista fatta proprio da Guadagnino: «Oltre a fare il progetto dell’architettura [Portaluppi] segue anche gli interni, disegna tutti i particolari. C’è questo gusto di disegnare ogni cosa, non tanto gli oggetti, un divano, un mobile». La pervasività e l’influenza di Portaluppi su Milano mostrano un altro tipo di archistar, non celebre per una grande opera protagonista, monumentale, disturbante, avanguardista, ma per una presenza morbida e costante, elegantissima e borghesissima, di cui i post su Instagram riescono solo a captare un frammento.