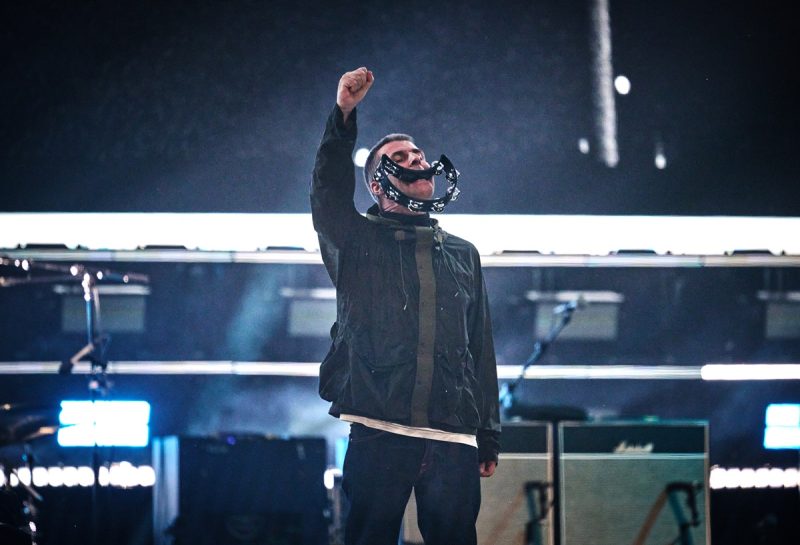Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
La dolce vita di Peppino Amato
Uno dei produttori più importanti del cinema italiano viene ricordato in un docufilm presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia il 10 settembre.

Nel dopoguerra si era fatto costruire una villa Hollywoodiana in via Cortina d’Ampezzo ma Peppino Amato non ci abitò mai. Preferiva di gran lunga lo sfarzo dell’hotel Excelsior, consapevole che all’epoca i produttori cinematografici per essere credibili avevano bisogno di esibire segni di una loro potenziale grandeur, seppur effimera. Lì, in quella stanza affacciata su via Veneto, quando non era in compagnia della sua amante, l’attrice americana Linda Durrell, una stangona che aveva perso la testa per questo intraprendente napoletano fai da te, Peppino Amato riceveva amici e maestranze, rigorosamente in mutande – in questo ricordava don Gaetano Caltagirone, quello del celebre «a Fra’, che te serve», che accoglieva politici democristiani e portaborse vari in pigiama, ai bordi del letto – dando vita a scenette e racconti memorabili. Che diventavano immancabilmente comiche quando c’era da trattare, senza interpreti, con attori e produttori stranieri e dunque bisognava rispolverare quell’inglese che non era mai riuscito a digerire, nonostante i soggiorni americani. «What cazzo do you want?», era il suo abituale incipit, per rompere il ghiaccio. Poi, se la trattativa si prolungava, arrivava un definitivo, «You sign, I sign, you don’t sign, allora diche you vaffancul».
Ma non era un problema legato all’incomprensione di una lingua straniera. I suoi involontari strafalcioni erano proverbiali, il giornalista Vincenzo Talarico diceva che soffriva di daltonismo linguistico, e alcuni erano talmente geniali – ho un salottino tutto di Rimini; ho un completo d’inferiorità; si sono tutti alcolizzati contro di me – da costringere Ennio Flaiano a stilare il Catalogo Peppino Amato. A futura memoria. Ma per comprendere appieno la storia di questo avventuroso cinematografaro, che è stato attore, regista, produttore e chissà cos’altro, bisognerebbe immaginarsi cosa era il microcosmo cinematografico a Roma nell’immediato dopoguerra: un piccolo mondo dove circolavano pochissimi soldi e moltissime idee, non tutte confuse, regnava l’assoluta improvvisazione, una buona dose di anarchia, ma anche un pizzico di sana follia e di misteriosa euforia per il futuro.
La figura di Peppino Amato (vero nome Giuseppe Vasaturo) viene ora ricordata nel docufilm La verità su La Dolce Vita, che sarà presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia il 10 settembre. Diretto dal nipote Giuseppe Pedersoli (figlio di Bud Spencer), il film ricostruisce, partendo da una serie di memorie ritrovate, bozze, contratti, telegrammi, e basandosi sulla corrispondenza tra Giuseppe Amato, Angelo Rizzoli e Federico Fellini, il travagliato cammino che portò alla realizzazione del film più conosciuto del regista romagnolo, prodotto proprio da Amato dopo che Fellini ruppe con De Laurentiis, che fino all’ultimo insistette per imporre il nome di Cary Grant come interprete. Peccato che gran parte dei guadagni del film il produttore di La Dolce Vita li trasferì nel giro di brevissimo tempo nelle casse del casinò di Montecarlo, dove in alcuni weekend si rischiava di incontrare mezza Cinecittà. A cominciare naturalmente da Vittorio De Sica, che esordì dietro la macchina da presa nel 1940 con Rose Scarlatte proprio accanto al produttore napoletano, che in seguito gli finanzierà anche Umberto D.
A pensarci bene è la vita stessa di Amato a poter essere raccontata come un film. Aveva cominciato a Napoli negli anni Venti come attore di una compagnia dialettale napoletana ma ben presto aveva conosciuto un regista americano della MGM e lo aveva inseguito fino a New York, dove però aveva tragicamente scoperto che la fantasia e l’arte di arrangiarsi non erano sufficienti per tirare a campare, almeno non da quella parte dell’Atlantico. Per un breve periodo si lanciò nel commercio di tappeti, pare con l’aiuto della mafia, e successivamente si rifugiò a Los Angeles, dove riuscì non si sa come a farsi assegnare da una piccola casa di produzione un contratto in esclusiva per l’importazione di film in Italia. Nulla di trascendentale, ma quando bastava per tornare a casa con un certo credito nell’ambiente cinematografico romano.
Irascibile, raramente accettava un no come risposta, estroverso, con punte di folclore a volte eccessivo, a suo modo geniale, seppur non particolarmente colto, qualcuno arrivò a definirlo un semi analfabeta, affrontò il mestiere di produttore con lo stesso approccio con cui si affacciava ai tavoli di trente et quarante: un mix di spavalderia, istinto predatorio e una giusta dose dei casualità. Mostrando però un ottimo fiuto e una notevole capacità di intercettare i cambiamenti. A partire già dagli anni Trenta, quando offrì la prima occasione cinematografica a Eduardo e Peppino De Filippo. Poi arrivarono i film di Alessandro Blasetti, La cena delle beffe e Quattro passi fra le nuvole, e il successo nel dopoguerra con la produzione del primo film della serie Don Camillo.
Intuì in anticipo anche le potenzialità, non facilmente leggibili, di Roma città Aperta, quando il titolo provvisorio era ancora Storie di ieri, e decise di investire duecentocinquantamila lire in cambio dei diritti di vendita del film all’estero, a condizione che il ruolo di Pina fosse affidato alla Magnani. Successivamente cambiò idea, più per questioni di principio che non per reali divergenze cinematografiche, e si ritirò dal progetto. Non prima però di aver contribuito al cambio di titolo, dopo una lunga telefonata avuta con lo sceneggiatore Sergio Amidei: «Sergio, che cazzo vuol dire Storie di Ieri? Niente! È una stronzata!… Ci vuole Roma!».