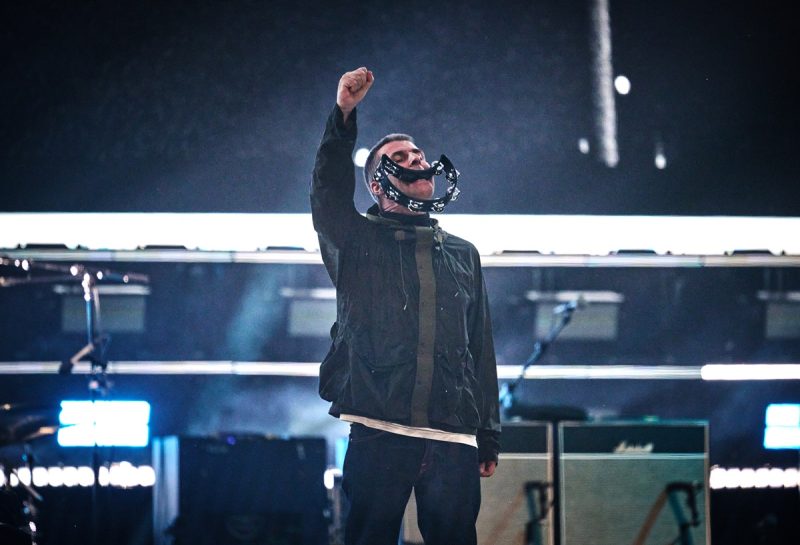Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
La regina degli scacchi è la sorpresa dell’autunno
La nuova mini serie Netflix con Ana Taylor-Joy è una storia bellissima, tra riscatto e dipendenze.

Mattina, una stanza d’albergo di lusso a Parigi. Un cameriere bussa con insistenza alla porta, una ragazza esce da una vasca, in sottoveste, con i capelli bagnati e il trucco colato. Nel letto c’è un’altra ragazza, si rigira, mormora qualcosa. Non si fa in tempo a immaginare la notte di bevute e sesso, e il mal di testa del giorno dopo, che la ragazza della vasca ha addosso un vestito verde acqua asciutto, i capelli rossi pettinati e corre verso la porta con le scarpe in mano.
È la scena iniziale di La regina degli scacchi (in originale The Queen’s Gambit, da una mossa di apertura di partita), miniserie in sette puntate da un’ora scritta e diretta da Scott Frank. Quando la telecamera inquadra la faccia non convenzionale di Ana Taylor-Joy – labbra a cuore da diva del muto, occhi grandi lontani e zigomi alti da ragazza ultramoderna, quasi una reincarnazione post Instagram di Stefania Sandrelli a vent’anni – la curiosità di sapere come sia arrivata a quel punto è grande.
La prima parte della serie si sviluppa come un lungo flashback ed è tratta dal romanzo omonimo del 1983 di Walter Tevis, uscito in Italia nel 2007 da minimum fax con traduzione di Angelica Cecchi e prefazione di Tommaso Pincio. Taylor-Joy è Beth Harmon, una ragazzina cresciuta in un orfanotrofio dopo la morte della madre per un incidente d’auto (forse volontario). A otto anni Beth, interpretata da Isla Johnston, si annoia in classe perché è troppo intelligente e viene mandata dalla maestra di matematica a pulire i cancellini nel seminterrato. Ci trova un inserviente, Mr. Shaibel (Bill Camp), che gioca a scacchi da solo. È ammaliata dal movimento dei pezzi sulla scacchiera, chiede a Shaibel di insegnarle tutto. Shaibel tratta Beth da moscerino fastidioso ma presto si rende conto di avere a che fare con un talento incredibile.
Siamo, fino a questo momento, in una tipica storia di riscatto sportivo. Come Karate Kid o Rocky con gli scacchi al posto dello scontro fisico, bisognerà lottare e impegnarsi ma è chiaro che oltre gli ostacoli c’è la vittoria. Il fatto che la protagonista sia una ragazzina conta. Beth è Heidi, è Jane Eyre. Dà soddisfazione vederla, con la frangetta corta e le scarpe sbagliate, vincere il primo torneo al liceo locale battendo uno dopo l’altro i campioni della regione sotto gli occhi ammirati delle ragazze con i vestiti giusti. Ma c’è dell’altro.
La regina degli scacchi è un racconto sulla dipendenza. È una storia di fantasmi. Ogni storia di dipendenza è una storia di fantasmi. A Beth nell’orfanotrofio danno capsule (librium, una benzodiazepina) per stare calma e dormire. L’effetto le piace, le mette da parte, quando le ingoia a due a due si sdraia nel letto e vede una grande scacchiera sul soffitto su cui può studiare mosse e combinazioni. Quando viene adottata, nel rapporto intenso con Alma, la madre adottiva, scopre l’alcol. Alma è una donna degli anni cinquanta che ha rinunciato a diventare una pianista per restare a pulire la villetta nei sobborghi di un marito che parte per lavoro e non torna più. Beth si butta negli anni Sessanta con al polso l’orologio anni cinquanta che le ha regalato Alma. In una scena fuori da un hotel a Las Vegas Beth cammina come Joan Holloway nei corridoi dell’agenzia di pubblicità, un chiaro omaggio a Mad Men (a cui le scenografie di Uli Hanisch devono sicuramente qualcosa).
Beth inizia a vincere e a vincere, qualche volta perde, ma solo per accrescere il desiderio di vincere. È circondata da adoratori e non prova niente. Ha le emozioni e il corpo anestetizzati dai traumi. Non sa decidersi tra la vita e l’autodistruzione. La regina degli scacchi, in apparenza una serie dal formato classico, non cancella l’ambivalenza che pervade il romanzo di Tevis. In una scena a metà del racconto Beth, che ha vinto diversi tornei e si è comprata dei bei vestiti, viene finalmente ammessa nel circoletto delle ragazze ricche del college. La sera, nel salotto di una di loro, le ragazze si mettono tutte a ondeggiare e a canticchiare “You’re the One” dei The Vogues (1965) davanti alla televisione. Beth è immobile, le guarda. La cosa che più desiderava all’improvviso la terrorizza. Inventa una scusa, finge di cercare un bagno, ruba una bottiglia dallo studio del padre e scivola fuori da una portafinestra sul retro.
Il finale ha dei difetti, forse è inevitabile. La redenzione dalla dipendenza è didascalica, ha bisogno di parabole universali. Di soluzioni semplici. Come ha scritto David Foster Wallace in Infinite Jest: «Tanto più è insipida la frase fatta degli AA, tanto più affilati i canini della verità vera che nasconde». Di certo prima Beth deve toccare il fondo. Le scene in cui è da sola rivelano tutta la bravura di Ana Taylor-Joy, che nei momenti più complicati non ha bisogno di essere morbosa, si concede totalmente e nello stesso tempo mantiene una distanza ironica dalle cose, così essenziale al suo personaggio. Come quando vomita in una delle coppe vinte giocando a scacchi e sembra che stia per mettersi a ridere da sola. A un certo punto viene salvata da una sbronza senza fine da Jolene (Moses Ingram), unica amica dei tempi dell’istituto. Vanno insieme al funerale di Shaibel e Beth si rende conto che aveva conservato tutti gli articoli sui suoi trionfi scacchistici. In macchina per la prima volta piange. Forse si riconcilia con il passato, con le madri che l’hanno lasciata sola troppo presto, accetta il destino di giocatrice geniale, si prepara a affrontare a Mosca il campione del mondo. In un ristorante di Mosca rifiuta la caraffa di vodka che le porge un cameriere, a una festa in suo onore dice no allo champagne. La regina degli scacchi ridiventa un’edificante parabola sportiva, se avete visto Karate Kid sapete già come andrà a finire.