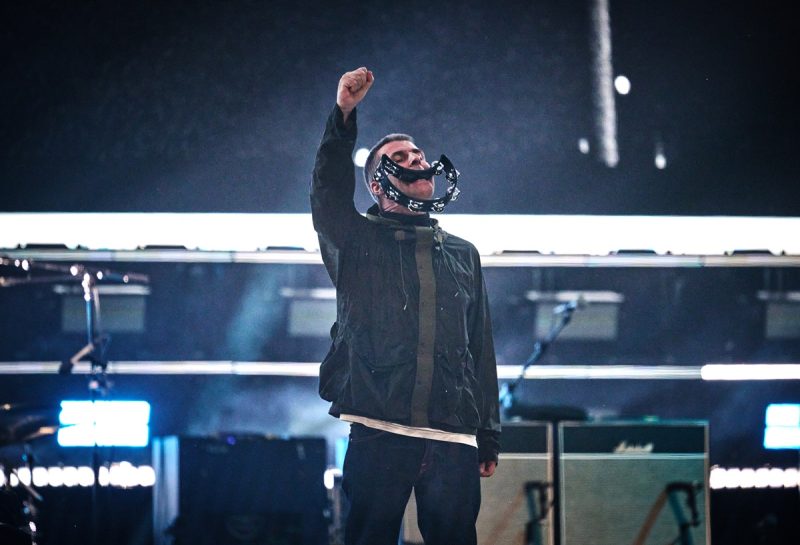Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Cercare la libertà lontano dalla coppia
Dalla tossicità relazionale della propria famiglia d’origine alla canonica infelicità di una coppia etero, per arrivare a cercare la libertà in un annuncio su internet, ma senza lieto fine.

Ai tavolini dei bar con le amiche iniziamo con la politica, i libri e i pettegolezzi ma finiamo sempre per parlare di amori. Qualche tempo fa ci siamo rese conto che nessuna di noi in questo momento vive una situazione sentimentale che si potrebbe definire come coppia stabile. È qualcosa di cui non parliamo mai come di una mancanza in sé. La mancanza o la tristezza sono sempre legate a una persona in particolare, a un sentimento complicato o non corrisposto, e mai alla condizione di solitudine intesa come assenza di condivisione costante di un letto e di responsabilità.
Non è sempre stato così. Per quanto riguarda me, in un passato non troppo lontano ho fatto parte di una coppia con dei figli piccoli. Nei pomeriggi dopo la scuola, nei fine settimana o in estate mi trovavo a frequentare altre coppie con bambini e bambine della stessa età, a riempire le giornate di sole con gite al parco, e le giornate fredde o di pioggia con cinema e biblioteche con sezioni per ragazzi. Credo che noi adulti fossimo accomunati soprattutto dalla fiducia nella possibilità di un aperitivo che spezzasse la noia di quei pomeriggi lunghi e stipati di svaghi non adatti a gente della nostra età. Tra un bicchiere di vino e una birretta mi trovavo a studiare, con furtività da ladra di misteri altrui, le dinamiche interne alle coppie. Misuravo la mia infelicità confrontandola con quella degli altri, cercavo una crepa nel loro benessere apparente, godevo segretamente nell’essere a conoscenza di dettagli che avrebbero potuto incrinare equilibri già instabili. Fantasticavo di scoparmi i mariti e le mogli degli altri, o perlomeno di assistere a una scopata, come una mosca appoggiata a una parete o l’occhio di una telecamera nascosta in una lampada. Dal mio punto di vista, non ho mai respirato un’aria satura di repressione infiammabile come quella di una stanza piena di coppie eterosessuali. Forse perché niente mi sembrava più facile di desiderare persone che non potevo avere. Deve essere un problema di carattere, mi capitava anche da piccola con gli adesivi o le gomme da cancellare, ma in quel caso era meno complicato chiedere alle altre bambine se per caso avessero voglia di fare a cambio.
Mi sono sempre chiesta se esistesse un’alternativa a questa frustrazione apparentemente inevitabile. Altre persone l’hanno cercata tramite forme evolute di normatività sentimentale, come ad esempio il poliamore. Ne so poco, forse perché negli anni ho avuto già abbastanza problemi con il formato di coppia base, ma ho intuito che, a differenza di come appaiono i fatti da una certa distanza o tramite una conoscenza superficiale, si tratta di relazioni che si muovono sullo stesso terreno friabile di tutte le altre. La scrittrice peruviana Gabriela Wiener nel romanzo autobiografico Sanguemisto (uscito a settembre per La nuova frontiera) racconta tra le altre cose di un momento di crisi nel suo matrimonio composto da tre persone: «Il nostro letto a tre ormai non serve più per il sesso. Il letto che è stato la superficie sulla quale abbiamo ricreato le nostre fantasie di rottura con il ruolo di “marito e moglie” è ora un letto per dormire, un letto in pensione, al massimo un enorme letto in aspettativa. Praticamente non facciamo più sesso di coppia. Ci sono giorni in cui mi sento truffata, ma se ci penso seriamente, quanto poteva durare un’orgia matrimoniale? La prima cosa che spiego a chi mi chiede della nostra relazione multipla è che non faccio più sesso della maggior parte della gente». In questo passaggio del libro, Wiener è venuta meno al patto di trasparenza sentimentale e sessuale con il marito e la moglie. In poche parole, è andata a letto di nascosto con un altro uomo: «Non ho bisogno della terapia per sapere perché ho sabotato la nostra vita», scrive. E poi: «Sono mio padre infedele e geloso perché la sua amante gli mette le corna con un altro. La sua versione postmoderna».
Leggendo quest’ultima frase mi sono resa conto di averle tentate tutte per non diventare anche io la versione postmoderna di mio padre. Mio padre, in camicia e pantaloni fine anni Settanta con lo stesso taglio di quelli disegnati oggi da Alessandro Michele, faceva davanti a me commenti alla Philip Roth sulle donne da quando avevo tre anni. Diceva che l’amore è un’invenzione del capitalismo, la famiglia tradizionale un luogo di tristezza e frustrazione. Le donne, secondo lui, dopo i trent’anni erano da buttare. Con il suo maschilismo mascherato da cultura aveva fatto scappare mia madre con un principe decaduto e alcolista, che aveva i capelli lunghi e biondi e sorrideva sempre. Mio padre poco dopo aveva iniziato a convivere con una donna che passava il tempo sul divano a leggere biografie di principesse e romanzetti Harmony, mangiava solo fiocchi di latte e banane, non cucinava mai. Il nostro regno era una tavola calda sul Lungotevere. Io andavo il più possibile a pranzo dalla vicina: aveva la mia stessa età, e c’era un padre con il grembiule sopra la camicia con le maniche arrotolate che infornava lasagne e una madre in carriera che tornava da viaggi in Giappone portando regali per tutti. A casa non osavo dirlo, ma a vederli mi sembravano felici. Quando avevo quindici anni mio padre mi aveva rivelato di avere un’amante. Era una persona che frequentava casa nostra, la conoscevo. Mio padre disse che da quel momento l’avremmo chiamata con il nome in codice Walter. Da qualche parte conservo ancora una copia di Foglie d’erba con la dedica “Natale 1989, con affetto, Walter”. La loro storia d’amore non è durata molto, secondo mio padre era soprattutto perché Walter aveva le tette troppo grosse.

A volte ho l’impressione di avere iniziato davvero a vivere quando sono rimasta senza genitori, quando non ho dovuto avere più niente a che fare con la tossicità della mia famiglia di origine e ho potuto iniziare a coltivarne una versione immaginaria, da venerare e rimpiangere. Ma qualcosa mi aveva contagiato. Dopo la fine della mia convivenza, con i figli grandi che pensavano ai fatti loro e alcuni anni di silenzio emotivo e fisico, sono stata travolta dalla scoperta di poter incontrare persone sconosciute tramite applicazioni e pagine internet dedicate agli annunci. Mi dicevo che si trattava di ricerche per il romanzo che volevo scrivere, in realtà mi ero appassionata all’idea di poter scegliere, come sul menù di un ristorante, pezzi di uomini. Ginocchia, spalle, polpacci, piedi, bicipiti, tagli degli occhi, colori di capelli. Tutto faceva parte della stessa ossessione. Collezionare figurine, non legarsi più a una persona sola, disinnescare qualunque forma di fedeltà possibile, diventare un’altra per dimenticare me stessa. Sono sempre stata poco coraggiosa, volevo dimostrarmi temeraria, almeno nel sesso. Per un certo periodo è stato divertente, fino a che non ho incontrato qualcuno che mi ha fatto desiderare di punto in bianco di vivere tutto quello che credevo di disprezzare. Tra le sue braccia avevo visioni di casette, prati, alberi, ruscelli, margheritine, rondini e pesciolini volanti come nei disegni dei bambini delle elementari. Andavo a casa sua a mezzanotte senza mutande per farmi sculacciare e pensavo a come sarebbe stato bello camminare per mano lungo le frecce adesive del percorso obbligato di un negozio Ikea riempiendo la busta gialla di oggetti inutili, da lasciare nel cesto dei ripensamenti subito prima della cassa. Non è difficile indovinare cosa ci sia finito in quel cesto, insieme alle candeline profumate e ai sottopiatti di bambù.
Dopo aver scritto il romanzo sui pezzi di uomini, o forse dovrei dire sull’uomo che mi aveva lasciato a pezzi, ho avuto per la prima volta la sensazione di cosa volesse dire sentirsi veramente sola. Ho continuato a pensarlo ogni giorno, fino a che non l’ho incontrato con un’altra, davanti a un chiosco vicino alla Piramide. Erano arrivati su due biciclette gemelle in affitto. Lei era giovane e carina, vestita come per una passeggiata in un corso di provincia, messa in piega, borsetta e scarpe coordinate. Era una domenica pomeriggio di sole, io avevo un vestito nero e le calze come per i nostri antichi appuntamenti erotici, ma in versione luttuosa. Una specie di sposa cadavere che rovesciava lacrime nel gin tonic, con il sottofondo straniante delle musichette lounge che uscivano dagli altoparlanti bluetooth del locale. Quando li ho visti scendere dalla bici per ordinare una birra, ci ho messo qualche minuto per convincermi che non si trattava di immaginazione o delirio. Non pensavo più all’infelicità primordiale delle coppie etero. Vedevo solo la mia, così grande da occupare tutto lo spazio. Mi vergognavo di aver buttato via un’idea scombinata e post traumatica di libera infedeltà per inseguire, senza successo, la versione da centro commerciale di una vita a due. In quel momento non ho trovato altro da fare che smettere di bere e iniziare a frequentare riunioni nei seminterrati delle chiese, dove potevo parlare, stare zitta o piangere, senza che nessuno lo trovasse strano. Ero sempre triste. Poi, come per tutte le cose, a un certo punto mi è passata.
Mi arriva ogni tanto su Instagram qualche richiesta di messaggi da sconosciuti. Si tratta quasi sempre di uomini, dicono che hanno letto il romanzo e hanno trovato un’affinità di perversioni sessuali. Mi chiedono di incontrarci, io non rispondo. Non ho più voglia di incontrare nessuno, non così. La mattina vado al parco con il cane, mi siedo per qualche minuto al sole. Faccio una meditazione sull’amore universale poi uscendo insulto gli automobilisti che si fermano sulle strisce. L’unica cosa a cui penso è che mi manca essere abbracciata.