Il film si intitola The Mountain, The Moon Cave and The Sad God ed esce nello stesso giorno del loro nuovo disco, The Mountain.
I libri del mese
Cosa abbiamo letto a settembre in redazione.

Letizia Muratori, Carissimi (La nave di Teseo)
Nurit Camerini vuole raccontare una storia: è nata con un’inseminazione artificiale, lo sa da quando è bambina, e ora che ha diciotto anni ha questo desiderio, felice e non tormentato, di mettere insieme i pezzi della vita del padre biologico morto da poco, Giorgio Amati. Nurit, israeliana di origini italiane, vuole fare una cosa che, ogni volta che la si fa, ognuno nelle proprie vite, crea letteratura: cercare le proprie radici. Telaviviana di sangue italiano, con quelle radici Nurit vuole farci un documentario. Deve mettere insieme il cast imbarazzato e spiazzato: è la famiglia di Giorgio, i fratelli, la compagna che gli è sopravvissuta, i figli, il nipote.

Questa è la semplice sinossi di questo Carissimi, ultimo romanzo di Letizia Muratori, che ha una forma originale e gioiosamente imprigionante, fatta di lettere – quelle che iniziano appunto con «Carissimi…» – che Nurit indirizza ai suoi quasi-familiari per indagare la loro vita che sarebbe in un certo senso anche la sua, in un viaggio tra Israele e Roma, dagli anni Trenta del Novecento passando per i rastrellamenti del Ghetto fino a questi anni odierni in cui i vecchi protagonisti si scrivono goffamente su Facebook chiedendosi cosa farsene di questa impicciona israeliana. Ma al di là della struttura, quello che è straordinario in Carissimi è l’eleganza e la sensibilità con cui Muratori tratta i personaggi che qui passano, le case in cui vivono, i vezzi che li distinguono, i discorsi che li animano. Può sembrare un romanzo d’altri tempi, a tratti in forma teatrale, per l’ambizione e la naturalezza antica, per la cura con cui scandaglia questa epica familiare borghese, la stessa cura di artigiani che soffiano statuine di vetro a cui daranno una qualità che nessun’altra tecnica potrà mai eguagliare. Carissimi – ecco – è un gioiello, ed è una descrizione meno banale di quanto sembrerebbe, per la rarità che rappresenta, per la gioia che dà a chi ne entra in possesso. (Davide Coppo)
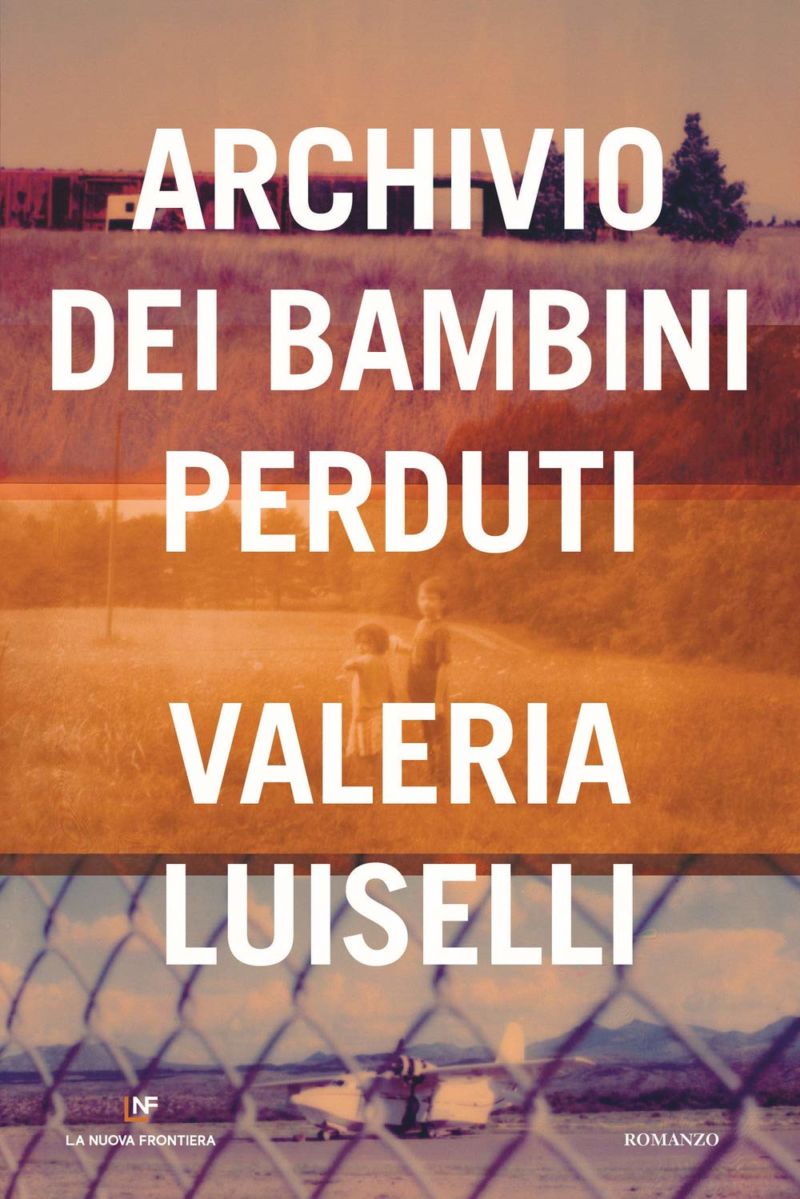 Valeria Luiselli, Archivio dei bambini perduti (La Nuova Frontiera)
Valeria Luiselli, Archivio dei bambini perduti (La Nuova Frontiera)
Trad. di Tommaso Pincio
Archivio dei bambini perduti, arrivato a inizio settembre in Italia dopo ottime critiche sulla stampa anglofona, è un “libro di frontiera” sotto molti aspetti: innanzitutto quello più evidente della linea di separazione tra Messico e Stati Uniti, al centro dell’interesse della voce narrante del libro, una documentarista sonora, la cui attenzione non solo professionale viene catturata dalla tragedia dell’immigrazione infantile tra i due Paesi. Insieme al marito e ai due figli inizia un viaggio da New York verso il sud degli Stati Uniti, dall’esito incerto, visto che la coppia sembra voler seguire strade diverse, o che si stanno biforcando. La frontiera è anche quella invisibile linea di separazione tra un uomo e una donna, che può all’improvviso diventare invalicabile. C’è poi la frontiera della lingua che Luiselli, messicana dalla formazione cosmopolita, ha voluto superare in questo che è il suo primo romanzo in lingua inglese, dopo tre libri (fiction e non) scritti in spagnolo e il saggio Dimmi come va a finire, che aveva rappresentato la prima tappa di questo passaggio. C’è infine la frontiera della forma, che la scrittrice ha dimostrato in tutti i suoi libri di volere percorrere come una equilibrista tra finzione e realtà: sono tanti i registri che vengono attraversati, il reportage, il diario, il memoir, e persino la fiaba. Luiselli dimostra di possedere la capacità rara di tenere insieme la dimensione privata e famigliare con il contesto politico e sociale e di voler ragionare su come quest’ultimo sia in grado di influenzare la prima. Viene da definirlo un libro incastonato in questo tempo, nel senso migliore e meno ideologico possibile. Misurato e ipnotico per due terzi, straborda sul finire con una deriva fantastica e allegorica, che sulle prime si fa fatica a far collimare con il resto, ma poi una volta chiuso il libro sembra quadrare. (Cristiano de Majo)
 Nicolas Mathieu, E i figli dopo di loro (Marsilio)
Nicolas Mathieu, E i figli dopo di loro (Marsilio)
Trad. di Margherita Botto
Sono numerosi i romanzi che in questi ultimi tempi mettono al centro l’adolescenza, diventando casi letterari. Al centro c’è sì l’adolescenza, ma a leggerli – soprattutto – sono gli adulti, forse nel tentativo di recuperare il filo perduto che li ha portati a definirsi tali. E i figli dopo di loro (Premio Goncourt 2018) traccia i contorni di una storia che chi è nato in provincia conosce fin troppo bene. Anche se non è quella della Lorena degli anni Novanta, è fatta comunque di perdigiorno, di canne, di autoscontri, di bar che rimarranno sempre uguali. Anche quella di E i figli dopo di loro è fatta di sogni, di famiglie sfasciate, di tentativi di riscossa, di fabbriche chiuse e di aperture di centri commerciali, di falò estivi in cui tutto sembra cambiare, come dopo la doppietta riappacificatrice di Lilian Thuram in semifinale ai mondiali di Francia 1998. La provincia è fatta soprattutto di ineluttabilità del proprio destino, ed è lo stesso per la maggior parte dei personaggi che affollano il romanzo di Nicolas Mathieu: Anthony, il cugino e le loro famiglie perdenti che perderanno sempre; Hacine, francese di seconda generazione che pensa di svoltare provando a fare il boss; Steph, bionda e confusa figlia dell’Assessore alla Cultura della città. Chi ha nel dna il riscatto, ce la farà, per gli altri ci sono i turni del magazzino. Sembra già tutto scritto, appunto, invece Mathieu riesce ad appassionare. I volti faticano a delinearsi, le caratterizzazioni sono forti ma minime, perché in realtà sono superflue. Ognuno di noi ha la sua provincia cronica in testa, la sua estetica anestetica, la sua calamità di marijuana e crimine. «La terribile dolcezza dell’appartenenza» che entra nella carne ed è datrice, alla fine dei conti, di senso. (Teresa Bellemo)
 Saskia Vogel, Consenso (Safarà Editore)
Saskia Vogel, Consenso (Safarà Editore)
Trad. di Alice Intelisano
Se Anaïs Nin avesse potuto leggere Consenso di Saskia Vogel, le sue parole sarebbero sicuramente state piene di grazia. Per la storia di Echo e del suo amore in senso lato, che vince «la stanchezza, il logorio o l’opacità». Più che di una trama, per spiegare ciò di cui narra il primo romanzo della scrittrice americana bisognerebbe parlare di “principio”: l’inizio della comprensione, di un percorso compiuto perdendosi nella pelle degli estranei. Tra i dintorni di Los Angeles, una ragazza impara a muoversi nella vita attraverso il dolore per la morte di suo padre, sperimentando i confini granitici del potere e del desiderio di chi entra in una comunità BDSM come quella di Orly, la sua vicina di casa: e cambiando per sempre la propria carne («benvenuta ogni parte di me»). Tra sottomissione e sadomasochismo, il racconto di Vogel procede sul binario unico dell’introspezione, lontano dai cliché e prossimo all’estetica femminista della sociologa Camille Paglia, in apertura del libro: «Sono una pornografa. Dalla più tenera età ho visto il sesso pervadere il mondo». Perché ciò di cui racconta Echo in prima persona, con la sua voce calda, emotiva (così vicina al suo lettore), è un mondo fatto di atmosfere, dove il rumore delle onde che si ritirano dalla battigia o il buio dei viali verso casa accompagnano il flusso dei pensieri. Mai volgare, mai troppo cruda sebbene così esplicita nelle descrizioni dei rapporti mercenari tra i clienti e la mistress, Vogel racconta l’universo di chi, attraverso rituali a tratti umilianti, riesce a colmare il vuoto che li corrode dall’interno. Di chi trova finalmente il piacere che ricerca per essere felice. Carne e cuore. (Corinne Corci)
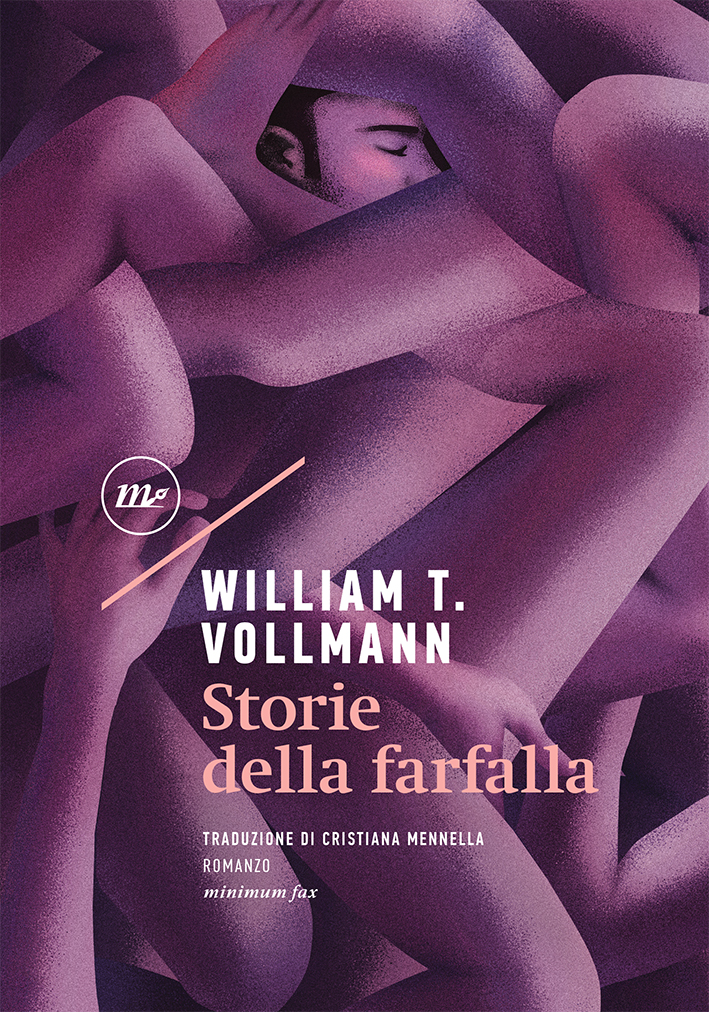 William T. Vollmann, Storie della farfalla (minimum fax)
William T. Vollmann, Storie della farfalla (minimum fax)Trad. di Cristiana Mennella
La pubblicazione di Storie della farfalla, uscito per la prima volta nel 1993, fa parte di un progetto editoriale che sembra volto a risvegliare il culto per Vollmann in Italia. Ripubblicando quattro romanzi più l’inedito I fucili (uscito nel 1994, ristampato nel novembre 2018), minimum fax segue di quasi 10 anni Mondadori (Europe Central, National Book Award) e di quasi 20 anni Fanucci Editore, che portò Vollmann in Italia nella mitica collana AvantPop. È quindi il momento di riprendere in mano questo scrittore (ma anche saggista e giornalista) venerato da David Foster Wallace che l’estate scorsa ha compiuto sessant’anni. Sentendosi raccontare la trama di Storie della farfalla si cade in preda al déjà vu: la sensazione è quella di rimettere mano in un garbuglio pulsante, velenoso e profondo già conosciuto altrove, da Cuore di tenebra di Joseph Conrad a Piattaforma di Houellebecq, da Viaggio al termine della notte di Céline al Burroughs più violento e farneticante di Le città della notte rossa. C’è il cliché dell’intellettuale che si innamora della prostituta, la violenza della guerra immersa in una vegetazione rigogliosa descritta con lirismo e minuziosità, un’idea di integrità morale che si rivela per contrasto, continuamente violentata e tradita, ricacciata in fondo alla gola come un pianto trattenuto. La disperazione, virilmente trasfigurata in degradazione compiaciuta ma anche in un sentimentalismo piagnucoloso (nell’amore per Vanna, la prostituta amata): il viaggio di un giornalista e un fotografo nel sud-est asiatico è un’esplorazione sessuale vorace e auto-distruttiva, basata sull’incomunicabilità e l’allucinazione. Un viaggio umido e viscido, organico e umano fino all’estremo, raffigurato con una scrittura ipertrofica come la natura che descrive, ma mai putrida come gli ambienti in cui si svolge la storia, anzi, sempre impeccabile nella sua atroce ironia, espressa nel ragionato sregolamento di ogni pagina: dalla perfezione dei dialoghi deliranti con chi non parla l’inglese, alla descrizione, senza descriverla, dell’oppressione di un popolo da parte di un altro. E poi i disegni, i meravigliosi disegni di Vollmann che compaiono tra le pagine come fiori sgargianti e irresistibili tra il fogliame fitto delle parole. (Clara Mazzoleni)
 Irene Soave, Galateo per ragazze da marito (Bompiani)
Irene Soave, Galateo per ragazze da marito (Bompiani)
Conosci un uomo, ti accorgi che flirta, all’inizio la cosa quasi ti sorprende – aspetta, è lui quello che sto cercando? – e poi, prima che tu te ne renda conto, finisce per piacerti. O magari ti piace subito, non è detto, ma da quel momento, il momento in cui un uomo supera la barriera della cortesia, della scocciatura, dell’interesse casuale, inizia la solita storia di sempre. Anche oggi, anche nell’era di Tinder e della quarta ondata femminista, le donne che si trovino a cercare un compagno si invischiano come cinquant’anni fa in una serie di non mi scrive, non mi cerca, non mi richiama. Deve avere una sorta di effetto catartico, allora, il manuale per cercar marito compilato da Irene Soave, giornalista trentacinquenne del Corriere della sera con il pallino delle enciclopedie femminili. Nel volume edito da Bompiani, Soave ha raccolto massime, liste e regole (oh, quante regole) di manuali italiani che vanno dal Cinquecento al Sessantotto. E se la sua (la mia) generazione ha avuto più o meno solo “La verità è che non gli piaci abbastanza”, le nostre madri, sorelle e antenate sono state subissate di dettami, che a rileggerli tutti viene da sospirare, ridere e incazzarsi allo stesso tempo. Guardarsi indietro può essere però un modo utile per inquadrare le paranoie che ci affliggono oggi, anche perché, come ha spiegato l’autrice a Vanity Fair, «Nonostante sappiamo che non è più necessario [sposarsi, nda] e abbiamo anche superato il “meglio sole” delle nostre madri femministe, la mia generazione ha un feticismo per il matrimonio e la vita a due. Un mito riportato in voga dalla crisi, dal precariato nel lavoro, dalle difficoltà di emanciparsi davvero dalle proprie famiglie d’origine». Come a dire che ci siamo lasciate alle spalle i calcoli sull’età maritabile e le “buone maniere” per tenerlo al suo posto, ma la strada verso la felicità, perché è quella che vogliamo, è ancora lontana. (Silvia Schirinzi)

Che si vanno ad aggiungere ai 77 che spenderà per completare l'acquisizione. Che comunque potrebbe non completarsi, se l'Antitrust non darà il via libera. E in questo caso, Paramount dovrà pagare altri 7 miliardi di multa.

Le ricerche dicono che il gusto musicale si congela intorno ai 33 anni. Ma dietro c'è un fenomeno più profondo, che riguarda il modo in cui il cervello codifica i ricordi, la costruzione dell'identità e un'industria che monetizza la nostalgia.





