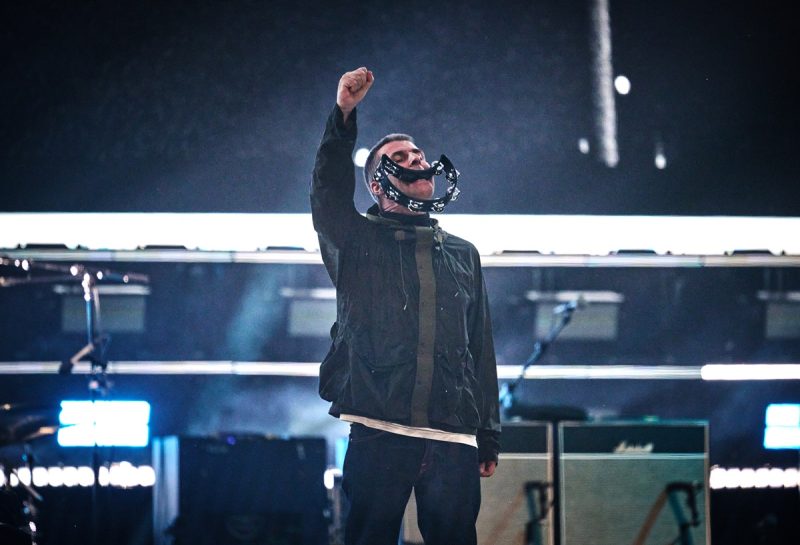Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Molto furore per nulla
Dopo la prima a Cannes è arrivato nelle sale Furiosa: A Mad Max Saga, il sequel del film con il quale quasi dieci anni fa George Miller ha cambiato la storia degli action movies.

George Miller è un artista della fuga e Mad Max: Fury Road è stato il suo capolavoro. Nove anni fa, Miller ha dimostrato che tutto il cinema che è mai stato fatto e tutto il cinema che sarà mai fatto stanno sulla linea retta che unisce un inseguito all’inseguitore. In Fury Road, lungo questa linea retta la cinepresa si muoveva in ogni modo finora concepito e anche in quelli ancora non concepiti né concepibili. È stato il capolavoro di un regista che ha sempre considerato la parola parlata come una forma di cosmetica cinematografica, un accessorio di cui l’arte avrebbe potuto fare a meno. D’altronde, Miller si è appassionato al cinema leggendo il leggendario saggio The Parade’s Gone By, scritto nel 1968 dallo storico e critico cinematografico britannico Kevin Brownlow. Nel libro, Brownlow spiega come il linguaggio del cinema fosse nato e fosse stato definito – buonissima parte delle inquadrature e dei movimenti che si usano ancora oggi sono stati inventati ai tempi – nell’epoca del muto, in particolare nei film d’azione dell’epoca del muto (quelli di John Ford, di Harold Lloyd, di Buster Keaton). «Quando è arrivato il sonoro, ha “interrotto” la normale sintassi del cinema», questa la conclusione che Miller ha tratto dalla lettura del libro.
Non che Miller non apprezzi nulla di quanto è stato fatto dall’avvento dei talking pictures a oggi: in tutti i suoi film ci sono Hitchcock, Yates, Friedkin, Spielberg, e ovviamente la scena della corsa delle bighe di Ben-Hur, alla quale ha pensato ininterrottamente dal 1959 e della quale tutti i film di Mad Max sono alla fine una extended version ultraviolenta e ipermoderna. Ma se per 45 anni della sua vita e carriera Miller ha continuato a tornare nella terra desolata, è stato solamente per dimostrare vera la tesi derivata dalla lettura di Browlow: Mad Max è alla fine il sogno reazionario – e realizzato – di un cineasta che non ha mai accettato di essere nato troppo tardi, la fantasia ricorrente di un artista che si è autoassegnato la missione di provare al mondo che «basta spostare la cinepresa e sistemare la disposizione delle inquadrature per rendere completamente diversa la stessa scena».
Ancora una volta: missione compiuta, sogno realizzato con Fury Road. Miller non aveva più niente da dimostrare, e quindi si è inventato un altro sogno, un’altra missione. Quindi si è messo a girare un altro film per provare che le parole non sono necessarie neanche quando si vuole raccontare un’odissea, pure questa ovviamente ultraviolenta e ipermoderna. Furiosa esiste per questo, esiste perché Miller voleva scrivere il suo Ulisse – sia la Furiosa di Charlize Theron che quella di Anya Taylor-Joy vogliono la stessa cosa che vuole l’eroe omerico: tornare a casa, compiere il nostos – perché voleva girare il suo Padrino: Parte II. Senza cedere a quella moderna corruzione cinematografica che è la parola parlata.
Taylor-Joy ha raccontato in una lunga intervista al New York Times quello che tutti gli appassionati della saga di Mad Max sanno già: girare uno di questi film con Miller è un’esperienza che prima o poi avrà una variante tutta sua di disturbo da stress post traumatico. Miller è noto per essere un uomo allo stesso tempo dolcissimo e intollerabile: sui suoi set è quasi impossibile trovare un copione perché lui lavora principalmente sullo storyboard. Uno storyboard che sta soltanto nella sua testa però, quindi anche di quello è quasi impossibile trovare una copia fisica. L’unica maniera per un attore di capire cosa Miller voglia è chiederlo direttamente a lui e scoprire quanto prolisso sia l’uomo che odia la parola parlata.
Della sua prolissità Miller si scusa persino con i giornalisti durante le interviste: tra una domanda e la successiva capita passi un’ora intera. Con gli attori è persino peggio e con loro non è nemmeno tenuto a scusarsi, perché dirigere è il suo lavoro ed essere diretti il loro. Sul set, in particolare sui set di Mad Max, Miller è capace di interrompere le riprese per ore perché ritiene assolutamente necessario spiegare per filo e per segno il vero incidente automobilistico che ha ispirato una tale sequenza (Mad Max inizia negli anni in cui Miller ancora non era un regista di mestiere ma uno studente di medicina impiegato presso il pronto soccorso dell’ospedale St. Vincent di Sydney, in anni in cui la sicurezza stradale era così lasca da far sembrare gli incidenti di Mad Max una pietosa edulcorazione della realtà), l’aneddoto bellico tratto dai racconti della sua defunta madre che ha ispirato una particolare posa di Furiosa, il modo esatto di tenere il manubrio della moto che lui ha scoperto quando decise di mollare il lavoro da medico a Sydney e andare a studiare cinema a Melbourne, facendosi tutti i 900 kilometri che separano le città a cavallo di quel vecchio scassone di motocicletta che all’epoca poteva permettersi (storia vera).
Si capisce: lavorare con Miller è esasperante. E a questa esasperazione data dall’uomo va aggiunta quella data dalle circostanze: girare nel deserto, aspettare per ore e ore e giorni e giorni, poi affrettarsi perché la luce del sole ha finalmente dato alla sabbia quel colore marziano, tra la cannella e l’ocra, che Miller ritiene indispensabile. Trascorrere 78 giorni, quelli che la maggior parte dei registi impiegano per girare un film intero, per completare una sola scena (anche se va detto che scena: la prima road war a bordo della blindocisterna in Furiosa è manipolazione dello spazio-tempo di cui solo un mago dovrebbe essere capace). Portare allo stremo delle forze 200 stuntman, 50 in più di quelli impiegati in Fury Road, perché ogni sequenza va rifatta fino ad avere una quantità di riprese sufficiente a trasformarla in qualsiasi cosa in sede di montaggio. Si capisce perché uno dei prodotti correlati a Fury Road che ha riscosso più successo sia il libro-making of di Kyle Buchanan, Blood, Sweat & Chrome: perché girare un film con Miller è quasi come vivere nelle terre desolate, i nervi degli attori tendono inevitabilmente alla disintegrazione lavorando con un regista che è per il set quello che Immortan Joe è per la Cittadella, e che intende gli attori come Figli della Guerra di cui disporre nel perseguimento del suo Valhalla cinematografico.
È inevitabile chiedersi, dunque: ne è valsa la pena di versare ancora tutto questo sangue, sudore e acciaio per Furiosa? La risposta è inevitabilmente no. Non c’è niente di davvero sbagliato in Furiosa, sia chiaro. E c’è tanto di giusto, anche: l’azione come drammaturgia, come esposizione sbavante e sanguinolenta di un conflitto; una storia d’amicizia e forse amore, quella tra Furiosa e Praetorian Jack, raccontata attraverso una nauseante successione di catastrofici incidenti stradali; il modo in cui gli occhi enormi di Taylor-Joy, soprattutto quando Furiosa li esalta col grasso nero che usa come pittura di guerra, compensano la sua inferiorità fisica rispetto a Charlize Theron e (quasi) le permettono di eguagliarne il carisma; quello in cui gli avvicinamenti e gli allontanamenti della cinepresa di Miller riescono a ricreare artificialmente nello stomaco dello spettatore il vuoto aperto dall’improvvisa accelerazione del motore della macchina.
Non c’è niente che non funzioni, in Furiosa, dicevo. Ma tutto sembra attempato, come uno spettacolo giunto ormai alla replica di troppo. Quell’inebriante senso di meraviglia, di creatività infantile, di spontaneità caotica che in Fury Road coglieva alla vista del Coma-Doof Warrior, il Figlio della Guerra che suonava la carica dell’esercito di Immortan Joe con addosso un pigiama rosso e in braccio una chitarra-lanciafiamme, è sparito. La sensazione destabilizzante che si avvertiva guardando la scena in cui Furiosa dimostra di essere una tiratrice migliore di Max (degnandolo della scarsa considerazione che si meritano le mere superfici d’appoggio), quell’impressione di aver assistito a una mirabile rappresentazione artistica del vibe shift culturale che all’epoca si iniziava appena appena a percepire, è andata. Il vibe shift è venuto e passato, Furiosa è diventata la Ellen Ripley di una nuova generazione di eroine, come Miller anche lei la sua missione l’aveva compiuta in Fury Road.
Visto da un altro punto di vista, Furiosa è il film che dimostra ancora una volta quanta ragione avesse Miller sulla parola parlata: è un film assai più parlato (con dialoghi che talvolta tendono allo shakespeariano), molto più mitologico di Fury Road, e infatti funziona molto meno. Miller aggiunge una terza dimensione – potremmo dire che aggiunge la narrativa: Fury Road non era una storia, Furiosa sì – al suo cinema bidimensionale fatto soltanto di tempo e spazio, piega su sé stessa la linea retta che gli è tanto cara, a formare un triangolo (geometria che in Furiosa infatti torna spesso). Il risultato è che il film gira intorno a sé stesso, in tondo, in triangolo, diventa un andirivieni che costringe sia nella struttura che nelle intenzioni a fare il paragone che ne accerta inevitabilmente l’inferiorità: quello con sé stesso, con Fury Road, appunto. Proprio dove Fury Road aveva trionfato, dove Miller aveva trionfato, però, Furiosa fallisce: nel dimostrare che si può fare sempre la stessa cosa ma renderla anche completamente diversa. È una consapevolezza, questa, che mi ha colto quando ho visto comparire sullo schermo il Coma-Doof Warrior che tanto mi aveva sconvolto nove anni fa. Mi sono sentito coccolato come solo il fanservice fa sentire coccolato un fan: che bello, sono tornato sulla Fury Road, per fortuna non è cambiato niente, mi sono detto.