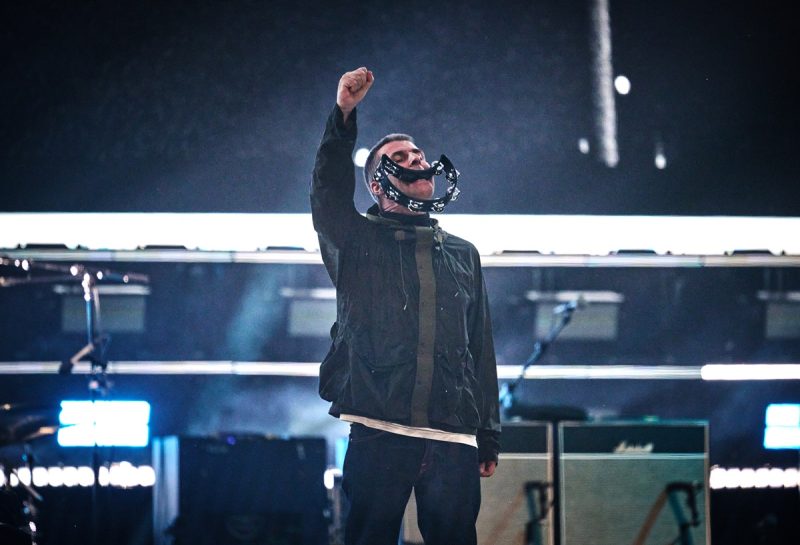Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.
Il disco più bello degli ultimi anni non è nemmeno su Spotify
Diamond Jubilee di Cindy Lee, un album di due ore non disponibile sulle solite piattaforme, ha conquistato la critica musicale come non succedeva da tempo.

Com’è successo che uno dei dischi più chiacchierati (ma anche tra i più belli e interessanti) del 2024 è l’album di un artista non-binary canadese che si esibisce in drag e spesso in falsetto, della durata di due ore, non disponibile sulle classiche piattaforme dove si ascolta musica (non su Spotify, non su Apple Music, ma nemmeno su Bandcamp), promosso attraverso un sito realizzato su Geocities che sembra uscito dall’internet di fine anni Novanta? Dobbiamo fare qualche passo indietro.
Nel 2010 esce Public Strain, il secondo album dei Women, una band di Calgary. Tra i suoi membri ci sono Patrick (chitarra e voce) e Matthew Flegel (basso), fratelli. Sepolte sotto coltri di un rumoroso post-punk ci sono melodie e canzoni che attirano l’attenzione del pubblico indie, e che danno inizio a quello che verrà definito in seguito Calgary Sound, una scena locale che comprende anche gruppi come Faux Fur e Telstar Drugs. La chitarra è al centro della chiesa, come anche le originali strutture dei brani che guardano alla psichedelia. Durano poco però, i Women: all’inizio del 2012 il secondo chitarrista Christopher Reimer muore nel sonno, ed è la fine della band.
Matthew Flegel e il batterista Michael Wallace danno allora vita ai Viet Cong, che dopo un primo disco di un certo successo cambieranno nome in Preoccupations, sigla con la quale sono ancora attivi. Patrick Flegel invece non li segue, e lì comincia il progetto Cindy Lee, «ispirato alle dive di un tempo, e dalle sonorità piene di una dolorosa bellezza, che ricordano le colonne sonore dei film di David Lynch, ma pure i Broadcast e in generale un romanticismo underground, qualcosa che fa venire in mente le fotografie di Nan Goldin e tutto un immaginario ben preciso», scrivevo qui nel 2018. Immaginate i Velvet Underground che suonano la colonna sonora di Velluto Blu, il noise che si mescola alle canzoni di una grande diva del passato un po’ invecchiata.
Flegel si esibisce in drag e in falsetto, a volte con altri musicisti ma restando sempre l’anima del progetto, con il quale realizza sei album tra il 2012 e il 2023. Un nome di culto, di grande qualità, sempre sospeso tra pop e abrasività, tra melodie e inquietudine, che trova anche un legame con l’Italia attraverso l’etichetta Maple Death, che ne ristampa un paio di album usciti originariamente solo su cassetta, e che contribuisce anche a organizzare una serie di live nel nostro Paese.
Ho cercato di farla breve per arrivare in fretta a quest’anno, al 29 marzo, quando esce sul già citato sito (e solo un paio di giorni dopo anche su YouTube) un doppio album, Diamond Jubilee, in download gratuito (con offerta consigliata di 30 dollari canadesi) in formato WAV. Senza troppi giri di parole la spiegazione. Testualmente: «THE CEO OF SPOTIFY IS A THIEF AND A WAR PIG. HE STOLE 100 MILLION EUROS FROM ROCK AND ROLLERS AND USED THE MONEYTO INVEST IN “HELSING”. “HELSING” IS A MILITARY ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATOR».
Quello che succede però è che il disco, realizzato interamente da Flegel con l’aiuto del solo Steven Lind (polistrumentista presente in una manciata di canzoni e produttore dell’album), è davvero bello e particolare, e la voce comincia a girare. Prima in modo più carbonaro, poi ci pensa Pitchfork a fare esplodere il tutto: il 12 aprile il magazine musicale più seguito al mondo pubblica una recensione dove gli assegna, oltre al titolo di Best New Music, un 9.1, il voto più alto dai tempi di Fetch the Bolt Cutters di Fiona Apple del 2020.
Nel giro di poco tempo Diamond Jubilee è anche l’album del 2024 con il voto più alto nella community di appassionati Rate Your Music, diventa presto uno dei dischi più chiacchierati e più lodati dalla critica degli ultimi tempi, escono articoli che si chiedono se la sua disintermediazione sia un indicatore del futuro della musica, e riflessioni-fiume sul ruolo nel suo successo del giornalismo musicale, a margine di concerti andati sold-out in mezz’ora. Il contatore di YouTube segna oltre 350mila visualizzazioni e quasi un migliaio di commenti, in buona parte al limite del commovente.
Fino a qui la storia del disco, le curiosità. Ma cosa c’è dentro a questo album e perché sta toccando così profondamente un sacco di ascoltatori in tutto il mondo? La definizione scolastica è quella di hypnagogic pop, insomma siamo dalle parti di Ariel Pink e del suo pop distorto, annebbiato, come in un ricordo sbiadito. Ma è fortissima anche l’influenza delle girl band prodotte da Phil Spector (come le Ronettes), quella della psichedelia, e un sacco di altre cose. Il suono è orgogliosamente lo-fi e la chitarra la fa da padrona, tra riff appiccicosi e assoli assassini, la voce non è solo in falsetto ma in una grande varietà di registri, oltre a essere più esposta nel mix che in precedenza.
Se già il progetto Cindy Lee ci aveva regalato musica molto affascinante, qui il passo in avanti è spettacolare: un capolavoro di melodie, scrittura, idee, soluzioni e varietà all’interno di un’idea precisa. Ha quella particolarità dei dischi in cui le cose “sbagliate”, che non suonano al posto giusto, sono strane ma anche molto belle.
Una differenza con la classica categoria musicale dell’hauntology (che evoca il passato in modo un po’ sinistro) è che qui, prendendo a prestito due termini da un famoso titolo di Mark Fisher, siamo nell’ambito del “weird” ma non dell’”eerie”: tutto è soffuso in una certa bellezza, le asperità ci sono, ma sono levigate rispetto al passato, trasmette una sensazione di beatitudine più che di inquietudine, oltre a stimolare in continuazione l’ascoltatore con infinite idee e cambi di direzione.
Il segreto è anche in un songwriting straordinario: il pop è davvero pop, le tecniche, inserite in una visione personale, sono quelle degli anni Cinquanta e Sessanta, del primo rock and roll e delle girl band, fino al Brill Building (il palazzo newyorchese dove sono state scritte un’infinità di hit del pop americano), e dà origine a quel mix di pop e stranezza, a quel connubio tra piacere di ascolto e deragliamenti, che è alla base di quasi tutta la musica più interessante degli ultimi decenni.
Nelle sue trentadue canzoni si possono sentire sicuramente i Velvet Underground, ma anche le sezioni ritmiche blues dei Rolling Stones, la potenza e la ripetitività del krautrock, la psichedelia dei Doors e quella dei 13th Floor Elevators, i Fleetwood Mac, la spigolosità del post-punk, il dream pop, la sensuale abrasività dei Jesus and Mary Chain, echi dell’ambient di Basinski… Ho letto addirittura qualcuno nominare Blonde di Frank Ocean o i Beatles. Un commento su YouTube dice che sembra la colonna sonora di Breaking Bad se l’avesse diretto David Lynch. Ci sono dentro il pop dei Sessanta, la psichedelia dei Settanta, il suono radiofonico degli Ottanta e il lo-fi dei Novanta, in un disco che suona come una distante, disturbata trasmissione radiofonica.
Un lavoro non retromaniaco, perché a differenza della calligraficità anastatica di un Random Access Memories, prende tutto quel passato ma in termini di struttura e produzione fa cose possibili solo nell’era digitale, raccontandoci tutta quella musica come qualcosa di decisamente trapassato, possibile solo nella forma di vaghi, annebbiati, ricordi.
La durata è lunga, è innegabile. Però per una volta sembra un viaggio con un senso, minimalista nella scarnificazione e massimalista nelle intenzioni e nella cesellatura melodica. È raro vedere qualcuno pubblicare così tante belle canzoni tutte insieme, torna alla mente lo Stephin Merritt di 69 Love Songs, ma questo è un viaggio che va fatto nella sua interezza, e al di là di tutta la teoria, per capire se funziona o no, se emoziona, se tocca qualche corda, bisogna immergersi in quell’inizio killer con cinque canzoni una più bella dell’altra (“Dreams of You” forse la più amata in giro), nel soul funk rallentato di “Olive Drab”, nelle particolarità di “Always Dreaming”, nella follia di “Flesh and Blood”, nell’intermezzo medievale di “Le Machiniste Fantome”, nella perfezione di “Kingdom Come” (un’altra tra le più apprezzate), nell’appiccicosa “Demon Bitch”, nelle stortezze di “I Have My Doubts”, nell’acida “Til Polarity’s End,” nella basinskiana “Realistik Heaven” che chiude il primo disco, nei krautismi di “Dracula”, nell’ubriachezza marcia di “Lockstepp” seguita dalla liquida “Government Cheque”, nella dolcezza di “Deepest Blue”, nelle asprezze di “If You Hear Me Crying”, nella splendida “What’s It Going To Take”, nelle briglie sciolte della coda di “Durham City Limit”, o nella conclusiva “24/7 Heaven”, che richiama alla mente il lavoro di Leyland Kirby. Ultimato l’ascolto, non resta che chiederci che cosa ci possa raccontare questo disco dello stato della musica, oggi.
Intanto che il “rock” ha ancora qualche cartuccia da sparare. Che quello che, almeno a livello di critica, promette di restare come uno dei dischi più memorabili di questi anni non viene dal rap o dall’elettronica ma, per quanto suoni più come un funerale dell’indie pop che una sua rinascita, è pur sempre un disco che basa la sua ossatura sul trittico chitarra, basso e batteria. Un’altra cosa interessante è che può essere letto come un’ “opera al nero” delle grandi dive contemporanee. In un mercato e un immaginario pop dominati da Taylor Swift e Lana Del Rey, Cindy Lee è una versione speculare e al negativo delle attuali divinità del pop, una specie di memento mori.
Infine, è un disco che, almeno a livello superficiale, non prova nemmeno a essere innovativo nel senso tradizionale del termine: non arriva alla sua innegabile rilevanza artistica cercando di scoprire il suono del futuro. Quello che fa è invece prendere certe selezionate cose dal passato, metterle in una capsula, e portarle in un’altra, eterea dimensione. Prendere i migliori ricordi di un mondo alla deriva, e spostarli su un altro piano di realtà, in un altro pianeta. Non vi ricorda qualcosa dei tempi e delle disperate prospettive che stiamo vivendo? Pare che questo disco segnerà la fine del progetto Cindy Lee. Sinceramente non sapremmo cosa poter chiedere di più.