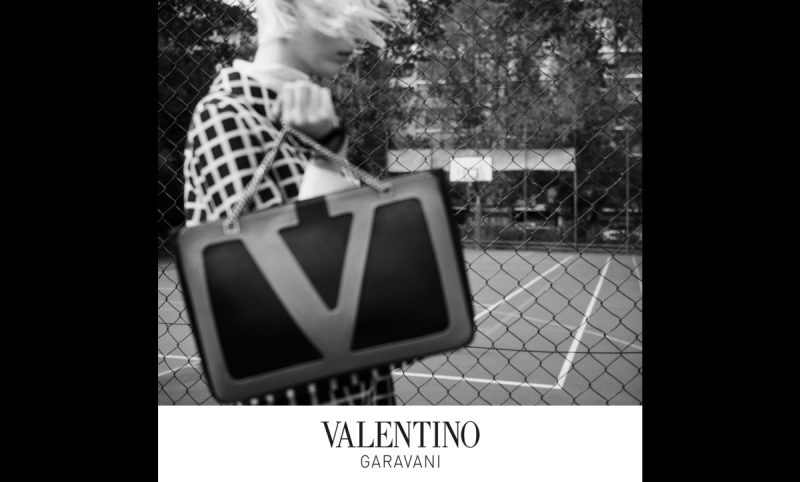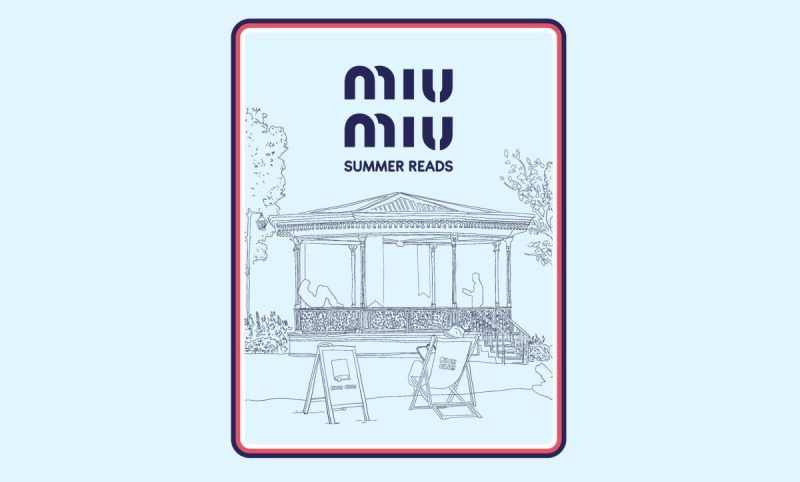È il secondo capitolo della collaborazione tra i due marchi, lanciata lo scorso settembre con una collezione maschile il cui testimonial d'eccezione era Martin Scorsese. Ora, per la prima volta, comprende anche una collezione donna.
Il Lyst Index, pubblicato da Business of Fashion, è la classifica che misura la forza globale dei brand della moda. In quella di aprile, relativa al primo quarto del 2018, dopo il podio Balenciaga-Gucci-Vetements, la triade che sta ridefinendo i concetti di moda e lusso, troviamo Off-White, il brand del fenomeno Virgil Abloh, nuovo direttore creativo di Louis Vuitton, e al quinto posto Stone Island. Per i più attenti e appassionati, la presenza nell’olimpo della moda contemporanea del brand di Ravarino, Modena – insieme un precursore e un continuo innovatore di tutto quello che c’è fra l’abbigliamento tecnico e lo streetwear – è una sorpresa fino a un certo punto. I numeri parlano chiaro – più 36% nel 2017 rispetto all’esercizio precedente e addirittura più 70% rispetto al 2015 – ma, se si mettono le cose in prospettiva, non sono che la risultante logica di un lavoro meticoloso e coraggioso che arriva da lontano e che parte dall’intuizione originale di Carlo Rivetti, fondatore e presidente del marchio, su come sarebbe cambiato il modo di vivere e di conseguenza di vestirsi degli uomini, con la nascita quindi di nuovi spazi, impensabili qualche decennio fa, per il cosiddetto streetwear.
La fine dell’abbigliamento ultra formale quotidiano, l’importanza della qualità del prodotto, la ricerca e la sperimentazione strettamente legati alle performance dei capi. E una coerenza di brand con pochi eguali in questo campo. Oggi che tutto il mondo sembra andare in questa direzione, Rivetti si gode il momento: «La cosa meravigliosa è il fatto che non siamo cambiati noi, è il mondo ad essere venuto nella nostra direzione». Sarebbe interessante sapere come siamo arrivati qui. «Era un cambiamento secondo me inevitabile. Non ne sono sorpreso, l’unica cosa che mi stupisce è la velocità. È un cambio repentino, epocale: la pancia del mercato si è mossa verso di noi, il modo di vestirsi delle persone è venuto in questa direzione. E quello che a me impressiona abbastanza è che il fenomeno si manifesta sia nei mercati in cui siamo storicamente presenti e conosciuti, sia in quelli in cui non lo siamo stati, come gli Stati Uniti. Una delle mie idee era il fatto che dovevamo, in un mercato nuovo, muovere il marchio da essere “push”, cioè noi a proporlo, a essere “pull”, cioè gli altri a chiedercelo. Ed è quello che sta succedendo, ci cercano, perché in un momento in cui tutto si sposta verso lo streetwear, noi siamo percepiti come quelli che l’hanno sempre fatto, e a un certo livello. È un fatto di credibilità. Non siamo gente che arriva adesso e cavalca l’onda. Siamo sempre stati lì ad aspettarla, come in Un mercoledì da leoni».

La sede operativa di Stone Island, fondata nel 1982, si trova a Ravarino, in provincia di Modena
La credibilità è tutto per Stone Island, se è vero come è vero che, prima che arrivasse l’onda, la sua “spiaggia” era già frequentata da nicchie crescenti di appassionati. È uno di quei marchi che hanno i fan, i supporter veri. Cosa trovano in Stone che altrove non trovano? «Credo il prodotto stesso. Abbiamo anche provato a cambiare codici e linguaggi, ma ci siamo resi conto che i nostri clienti sono interessati solo al prodotto e al racconto che ne facciamo. In qualche maniera abbiamo tracciato una strada e non l’abbiamo mai cambiata, e questo è premiante».
Ma cosa ci dice questo della moda tradizionale? Cos’è che quel mondo non ha capito, e che invece Rivetti e altri hanno intuito in anticipo? «Durante il Salone del Mobile abbiamo 4 mila persone che arrivano qui da Stone Island, quando apriamo gli spazi al pubblico per presentare i nostri progetti più innovativi», ragiona Rivetti, «un rito che apre la città alla curiosità della gente. Confronto tutto questo con la settimana della moda: un susseguirsi di gente che sale su auto nere, che entra in posti neri, chiusi al pubblico. Tutto ciò per me è il passato. Non a caso si è molto parlato ultimamente del “see now, buy now”, quel meccanismo per il quale forse bisognerebbe far trovare nei negozi ciò che le persone vedono online, nel momento in cui lo vedono, senza dover aspettare un’intera stagione. Noi lo stiamo facendo da almeno cinque anni, e in questo ci hanno aiutato le collaborazioni con Supreme e Nike, da cui abbiamo mutato alcuni concetti distributivi: lanciamo le nostre cose sui media e sui social nel momento in cui il prodotto entra in negozio».
Rivetti è una di quelle persone che ha intuito, più di trent’anni fa, che l’abito formale non sarebbe più stato, a lungo andare, l’uniforme esclusiva quotidiana dell’uomo. Oggi sembra normale, per molto tempo non lo è stato. Che ne pensa del formale uno come lui? «Secondo me il formale avrà ancora un ruolo importante, ma molto diverso. Osservo i ragazzi: hanno ancora il piacere di vestire elegante, ma non tutti i giorni, solo per l’occasione. Cosa che trovo assolutamente corretta, bella anche. Quando hanno la possibilità di usare l’abito e la cravatta perché c’è una cerimonia, li usano con grande piacere. Chiaro però che, per loro, non sarà più l’abbigliamento di tutti i giorni. Fra l’altro, detto con il know-how di un vecchio capospallista come me, gli abiti formali medi che ci sono in giro adesso sono veramente brutti. Allora, per gusto estetico, meglio vestirsi in modo diverso che con un brutto abito formale. Prendiamo un abito solo, ma prendiamolo bello. Vale anche per il mio mondo».

L’inconfondibile logo di Stone Island con la rosa dei venti
Da qui il discorso scivola sulle nuove generazioni, specie quelle italiane. E da lì, iniziamo a parlare di vocazione italiana in generale, di cosa dovremmo scegliere di essere per dare un futuro ai più giovani, nella moda ma anche in altri settori. Un tema che appassiona Rivetti: «L’anno scorso ho fatto il giro della Sicilia. È una terra baciata da Dio, si mangia benissimo, si beve benissimo, i ragazzi che lavorano nei ristoranti sono sorridenti, orientati al cliente. Noi, dagli anni Sessanta in avanti, abbiamo sbagliato completamente la filosofia di sviluppo del nostro Paese: il centro siderurgico di Taranto doveva essere un golf club. Noi dovevamo diventare la Florida dell’Europa. Pensa alla Toscana, pensa al cibo, al vino, a tutte quelle cose lì. Questo, traslato sul mio mondo, mi fa dire che forse è ora di ritornare alle cose che abbiamo sempre fatto meglio, come la sartoria. Ho l’impressione che i ragazzi comincino a capirlo. La mia grande preoccupazione in azienda era legata a quello che noi chiamiamo il reparto del cucito, quello dove costruiamo i prototipi. Anno dopo anno, lì dentro notavo sempre più teste bianche. Adesso è successo l’ineluttabile: le tre figure storiche sono andate in pensione, abbiamo un po’ programmato e investito sui giovani. Finalmente ce ne sono alcuni che hanno capito che stare alla macchina da cucire, in un’azienda come la nostra, non è un’attività né alienante né di basso livello, anzi. La nuova responsabile del reparto è una mia ex-studentessa di 27 anni. E le persone che ci sono dentro adesso sono tutti ragazzi giovani. Certo, ci vuole un pochino più di tempo, ci vuole forse un po’ di pazienza, però il futuro lì è assicurato».
Facciamo notare che però Stone Island non è un marchio la cui italianità è esplicita nel brand, non lo compri perché è italiano. Quanto è importante per voi esserlo, e perché? «Fino a un certo punto. Per esempio, dobbiamo spesso andare in giro a cercare tecnologie o basi tessili che magari in Italia non troviamo. Credo che sia importante una certa multiculturalità. Però i ragazzi dell’ufficio stile, che vengono da tanti Paesi diversi, alla fine vivono qui in Italia, mangiano italiano, respirano aria italiana, vanno a vedere le mostre nei nostri musei. Questo fa sì che abbiano una visione moderna e internazionale delle cose, però filtrata con lenti italiane. Faccio sempre un esempio, perché siamo geograficamente vicini alla Ferrari. In quel caso, l’azienda è la macchina. Se hai Schumacher ma non hai la macchina, non vinci il mondiale. Ma se hai la macchina e hai un buon pilota, magari non il migliore, se arrivi in fondo probabilmente il mondiale lo vinci. Ecco, quello che secondo me è fondamentale è che la “macchina” Stone Island sia sempre a Ravarino. Questo mi interessa dell’essere italiani».
Chiudiamo da dove abbiamo iniziato, cioè l’intuizione dello streetwear che sembra arrivata a compimento. Quando abbiamo intervistato Virgil Abloh per Studio, ci ha detto «voglio disegnare un aereo, voglio disegnare un grattacielo. Il mio movimento architettonico è lo streetwear». Lo streetwear è diventato davvero un modo di disegnare e di pensare le cose? «Sì, è diventato un vero e proprio movimento. Rispetto Abloh, e rispetto specialmente quei signori francesi che l’hanno assunto, perché hanno dimostrato di capire quello che sta succedendo nel mondo».

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.