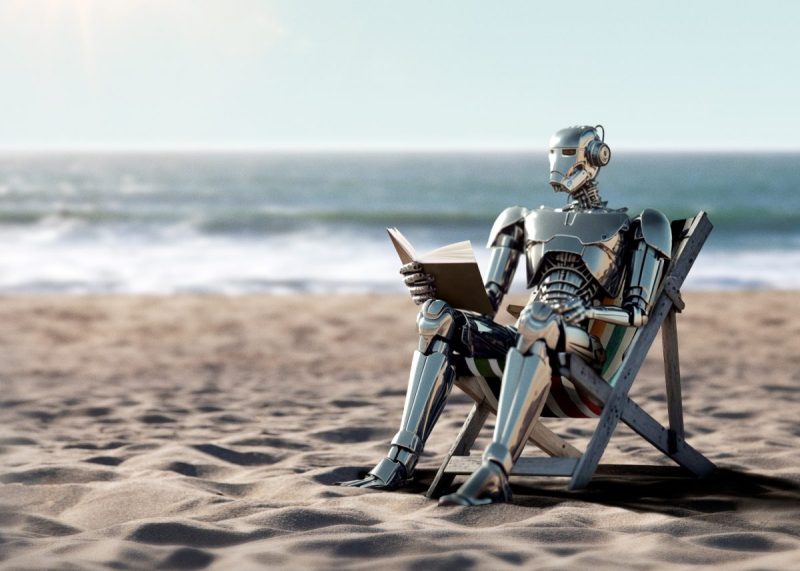Dopo il battibecco tra Rovazzi e le istituzioni milanesi, la parola è tornata d'attualità. Senza che però nessuno ne conosca il vero significato.
Parachute journalism è un’espressione di derivazione statunitense che descrive quel giornalismo estemporaneo, costruito senza una reale conoscenza del contesto da raccontare, in cui il reporter viene “paracadutato” sul posto per documentare una vicenda. Il sistema dell’informazione in cui operiamo in Italia finisce spesso per produrre esattamente questo tipo di copertura – non per semplice mancanza di cultura giornalistica, ma per la cronica assenza di mezzi e condizioni che permettano un lavoro approfondito e continuativo. Si tratta di una logica di per sé problematica, che diventa ancora più disturbante quando si parla di tragedie come quella di Ramy Elgaml e di quartieri periferici e marginalizzati come Corvetto. È lì che arrivano le troupe televisive in cerca di immagini che confermino le aspettative del pubblico: il disagio, il degrado, la “banlieue”, il “ghetto”, la “casbah”. La sceneggiatura è sempre la stessa: il dolore della famiglia, l’indignazione dei “bravi cittadini”, il tono contrito dell’assessore di turno. Poi, dopo qualche giorno, tutto si spegne. Si volta pagina. Come se non fosse accaduto nulla.
E invece non è così: l’omicidio di Ramy ha cambiato la vita di molte persone. Per molti, questa vicenda ha rappresentato la conferma brutale che il clima sociale ostile che attraversa l’Italia oggi produce vittime innocenti. Ad un anno di distanza, è dunque fondamentale tornare su questa storia non solo per ricordare una tragedia, ma per interrogarsi su ciò che è accaduto dopo la morte di Ramy e sul tipo di Paese in cui viviamo oggi. Ne parlo con Nada, la fidanza di Ramy. In lei questa perdita ha prodotto una presa di coscienza: il suo ragazzo non aveva altre colpe se non quella di incarnare il mostro sociale del momento, il giovane cresciuto in periferia e di origini nordafricane, etichettato da tanti come “maranza”. La incontro al Centro Sociale Lambretta, dove in questi giorni si organizzano i preparativi per le iniziative del 24 novembre, anniversario dell’omicidio di Ramy. Con lei c’è Rajaa, attivista del centro e figura di riferimento per Nada.
Le indagini
A luglio si sono chiuse le indagini del Giudice per le indagini preliminari, ma attorno a questa fase regna ancora molta confusione, anche se alcuni elementi sono ormai chiari. «Innanzitutto», mi dice Nada, «quello che è emerso è che poteva davvero accadere a chiunque. È vero, erano senza patente, ma Ramy e Fares (il ragazzo alla guida del motorino, ndr) non avevano rubato alcuna collanina e non c’era nessun posto di blocco a cui non si sarebbero fermati». Nei giorni immediatamente successivi all’incidente, infatti, si erano diffuse illazioni su presunti crimini commessi dai due ragazzi, insinuando che fosse questo il motivo che li aveva spinti a non fermarsi all’alt dei carabinieri. Ipotesi poi smentite dalle indagini, che hanno dimostrato come i due stessero semplicemente girando in motorino e che la pattuglia non stesse effettuando alcun posto di blocco.
Il punto centrale dell’inchiesta resta stabilire se, al termine dell’inseguimento, l’auto dei carabinieri abbia urtato il motorino causandone la caduta oppure no. Per chiarirlo sono state realizzate numerose perizie, ma le conclusioni sono risultate tra loro contrastanti. «In questo contesto quello che rischia di più è Fares. I pubblici ministeri hanno chiuso le indagini contestando un concorso di colpa per omicidio stradale a lui e al carabiniere alla guida dell’auto», mi racconta Rajaa. Recentemente la giudice ha respinto la richiesta dei Pm di una ulteriore valutazione affidata a un esperto terzo, gettando il procedimento in una sorta di limbo. Nel frattempo una seconda inchiesta per falso in atto pubblico e depistaggio va avanti nei confronti dei quattro carabinieri coinvolti, accusati di aver cancellato dai telefoni dei testimoni le immagini che ritraevano il momento dello schianto.
«Noi stiamo seguendo da vicino il percorso giudiziario di questa vicenda, perché speriamo davvero che non si traduca in un nulla di fatto, come troppo spesso accade in Italia», mi dice Rajaa. «Tuttavia, nel momento in cui è stato accertato che non c’era alcun posto di blocco, nessuna segnalazione e nessuna flagranza di reato, ci si chiede in base a cosa gli agenti abbiano deciso di fermare Ramy e Fares. L’impressione è che ci si trovi di fronte a un episodio di profilazione razziale». L’inseguimento è stato poi particolarmente lungo: da corso Como fino a via Ripamonti, per 24 minuti durante i quali l’auto dei carabinieri si è avvicinata più volte allo scooter, arrivando a speronarlo almeno in un’occasione, anche quando Ramy aveva già perso il casco. Nelle settimane successive sono emersi i video interni alla volante, in cui si sentono i due carabinieri imprecare quando i ragazzi non cadono. Le immagini hanno suscitato un’ondata di indignazione pubblica, ma la giudice per le indagini preliminari le ha definite frasi «da contestualizzare nella tensione e nell’adrenalina del momento».
Il quartiere
«Mi dispiace che ci siamo fatti sentire troppo poco subito dopo i fatti», esordisce Nada. «Avremmo potuto fare di più, e mi ci metto dentro anche io. Ma è difficile: nessuno sa davvero come si dovrebbe reagire a un evento del genere. Per me è stato fondamentale provare a dare un significato alla morte di Ramy, collocare questa tragedia personale dentro un quadro sociale più ampio. È stata la mia forma di cura, in qualche modo». Rajaa interviene per completare il quadro: «Va anche detto che è stata la reazione di Corvetto a creare attenzione sull’omicidio di Ramy. Nei primi giorni non se ne parlava affatto. Sono state le manifestazioni notturne e i presidi pacifici in via Ripamonti, organizzati dai ragazzi del quartiere, ad attirare finalmente lo sguardo della città. Poi ci sono state diverse fiaccolate e due cortei cittadini, che hanno posto al centro il tema del razzismo e della profilazione razziale. Sono state situazioni partecipate, anche se purtroppo la maggior parte della cittadinanza sostiene ancora che la responsabilità sia di Ramy e Fares. Tutto è durato poco: la presenza massiccia delle forze dell’ordine nel quartiere e l’attenzione morbosa dei media hanno rapidamente spaventato molti ragazzi, che si sono sentiti esposti, sotto osservazione, in pericolo».
A un anno dalla morte di Ramy, l’intenzione di Nada, dei suoi familiari, degli abitanti di Corvetto e delle attiviste e degli attivisti è quella di organizzare una giornata di ricordo che parli all’intera città. L’invito è rivolto soprattutto ai giovani, cioè a coloro che più spesso subiscono la profilazione razziale e che oggi vivono gli effetti delle “zone rosse” introdotte dal Prefetto di Milano. «Ramy non è il primo e, purtroppo, non sarà l’ultimo», mi dice Nada con un tono amaro. «Io lo faccio per Ramy, ma non solo per lui. Viviamo in un sistema di merda, e quello che è successo a lui poteva succedere a tanti altri. È questa consapevolezza che vorrei portare in piazza: che il 24 non sia solo una data di ricordo, ma un momento per denunciare ciò che sta accadendo».

Prima della guerra tra Iran e Usa e Israele il costo di un volo privato da Riyad all'Europa oscillava tra 50 e 80 mila dollari, ora è arrivato a 350 mila.

Il guaio in cui è finito il presidente della giuria Wim Wenders, che ha detto che il cinema non deve fare politica, è una costante in ogni grande evento, da Sanremo alle Olimpiadi. Un personaggio pubblico può davvero dire la cosa giusta nell'epoca della polemica permanente?