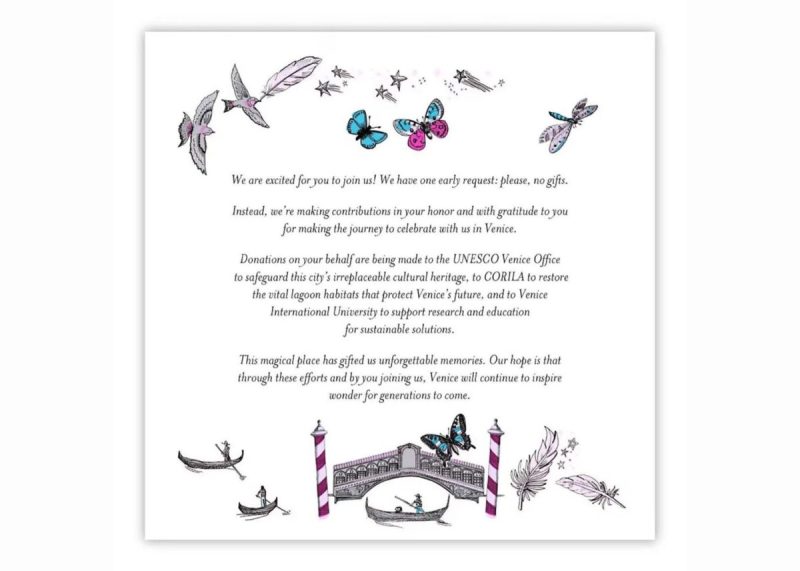Lo ha fatto con una direttiva che l’Italia deve recepire entro il 2026. L'obiettivo è una maggiore trasparenza e, soprattutto, contribuire alla diminuzione del gap salariale tra uomini e donne.
Si dice che il problema principale della scuola sia che tutti ne parlino come se fosse ancora identica a quella che hanno frequentato loro, che chi parla di scuola si affida solamente ai propri ricordi e alla propria esperienza personale, mentre la scuola è molto cambiata. Sono abbastanza d’accordo. Di scuola dovrebbe parlare solo chi la frequenta davvero ogni giorno. Ma sarei pienamente d’accordo se non fosse per gli open day, le giornate in cui con la scusa di dover aiutare nella scelta tuo figlio puoi andare a visitare le scuole e hai voglia a dire che è cambiato tutto se poi il quadro svedese è ancora lì in palestra accanto al cavallo con maniglie, le mappe alle pareti non hanno il Kosovo, la collezione di minerali nella bacheca sembra non incuriosire nessuno dal Mesozoico, forse sotto il banco c’è la gomma da masticare che hai appiccitato tu. “A proposito, ma dove sono i banchi a rotelle?” domanda il solito genitore brillante, subito rigenerato dal ritrovarsi in aula e galvanizzato dal ricordo di quando era bravo a far ridere i compagni di classe.
Ho partecipato a open day di elementari, medie e scuole superiori. Classici e scientifici, centro e periferia. In un mondo dove tutti hanno imparato a fare i conti con il drastico calo della soglia dell’attenzione, in cui tutti hanno imparato che l’interlocutore è pronto a distrarsi e a cambiare canale dopo venti secondi, a scorrere alla foto successiva, a leggere un altro status, a guardare lo schermo mentre gli parli perché sei noioso, gli insegnanti sono le uniche persone a non aver capito che siamo in una nuova era e che l’attenzione bisogna conquistarsela con le unghie e i fuochi d’artificio. Hai quarant’anni, sei un sabato mattina ad ascoltare una professoressa di chimica insieme a tuo figlio indeciso tra il linguistico e lo scientifico, ma dopo pochi minuti ti senti di nuovo sedicenne. Il tempo si dilata, non passa più. Non riesci a concentrarti, guardi l’orologio in continuazione, ecco com’era quella sensazione orrenda, me l’ero dimenticata, è la quinta ora di lunedì, la professoressa spiega l’elettrolisi: ma come facevamo alla quinta ora di un lunedì senza telefonini?
Sono in un liceo classico del centro di Milano. Ma potrebbe essere l’Alabama del 1952: incredibilmente non ci sono stranieri. La preside parla da un’ora e l’unica informazione che sono riuscito a registrare è che al pomeriggio fanno un corso di padel, sport di cui a mio figlio ovviamente non frega nulla. Si parla di competenze, tematiche, problematiche, metodologie, momenti frontali per il passaggio delle informazioni, cadenze settimanali, personale Ata. C’è tutto il gergo astratto e burocratico della scuola: dunque non solo sono costretti a scrivere così, proprio parlano così. Mi accorgo che i ragazzi sono decisamente più abituati degli adulti: ma io perché dovrei sapere cosa è il personale Ata? Perché lo danno per scontato?
Abituato alla presentazione dei libri in cui il momento delle domande dal pubblico è vissuto sempre con profondo imbarazzo – il silenzio diventa insostenibile e quando finalmente si alza una mano ne consegue poi una domanda che ti fa rimpiangere la quiete precedente – quando il preside apre alle domande dei genitori mi aspetto che la pratica si risolva in meno di un minuto. Ma mi sbaglio clamorosamente. Parte un fuoco di fila di decine di domande. Tutti genitori democratici, che si vantano di lasciare la scelta ai figli. Però hanno mille domande. E la preside o uno dei professori presenti rispondono a tutte. Senza infuriarsi ripetono perfino cose che hanno già spiegato due volte, un genitore domanda “come si comporta la scuola con i ragazzi plusdotati e ad alto potenziale?” e loro placidi come monaci zen non rispondono: “scusi, ma chi ha certificato che suo figlio è un genio?”, bensì “in questa scuola c’è posto per tutti”. Io non capisco se perché hanno davvero introiettato l’inclusività o per il vecchio detto per cui “il cliente ha sempre ragione” e devono trattare ogni genitore da cliente.
L’unica cosa che vorrei domandare io da anni – ci penso ogni volta che vado a un open day o a un saggio o a qualsiasi incontro pubblico in una scuola di uno dei miei figli – è: ma perché non riparate l’impianto stereo? Prima delle lavagne elettroniche, prima della famigerata carta igienica dei bagni che devono comprare i genitori, delle gite scolastiche, delle giornate al museo, degli incontri di orientamento, prima di tutto: perché non fate in modo che le casse non gracchino o che i bassi non siano troppo forti e che i microfoni non fischino orrendamente? Prima di ogni aggiornamento dei programmi scolastici, prima di aggiungere ore di lingue straniere o di cultura del made in Italy, prima di ogni competenza digitale, se io fossi per due ore ministro dell’Istruzione comincerei dall’impianto stereo.
Quando, dopo oltre tre ore e altre infinite chiacchiere sul fatto che i nostri figli scegliendo proprio quella scuola lì troveranno un ambiente che al confronto l’accademia di Platone era una scuola del Bronx, degli studenti fermano mio figlio e gli danno un volantino con la pubblicità del giornalino scolastico. Sarà tutto rose e fiori come dice la preside, ma il giornalino si chiama Spleen. Per fortuna ci sono i ragazzi.