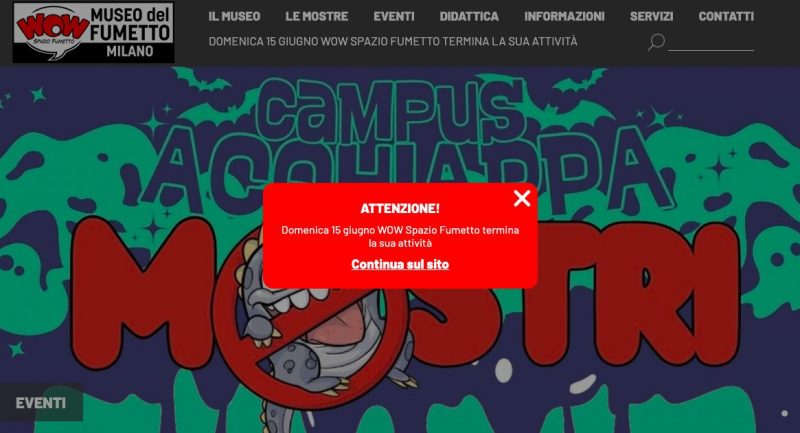La città "provinciale" che si legge negli strilli dei quotidiani locali e quella internazionale e kitsch raffigurata nei souvenir turistici. Per capire davvero Venezia bisogna fermarsi davanti alle sue edicole.
L’annuncio della chiusura dell’Old Fashion il prossimo 31 dicembre arriva dopo quelli di due altri posti storici che tireranno giù le serrande alla fine di questo 2023: la Latteria di via San Marco – che dal 1965 cucina i migliori spaghetti al limone e peperoncino in città – e Le Trottoir in Darsena – un’istituzione per artisti, musicisti e bohemienne milanesi, tra cui svettava il nome di Andrea G. Pinketts, che al “Trott” era di casa e che già tra le pareti della vecchia sede in via Tivoli era solito riunire la sua “Scuola dei Duri”.
La storia dell’Old Fashion è antica, perché il locale fa parte di quel complesso in viale Alemagna, firmato da Giovanni Muzio negli anni ’30, che ospita la Triennale, il Teatro dell’Arte e che si affaccia sul Parco Sempione, in uno dei punti più belli (in teoria) e più degradati (in realtà) di tutta Milano. Nell’ambiente si sapeva già da un po’ che la Triennale, padrona di casa della celebre sala da ballo, non le avrebbe rinnovato il contratto d’affitto, stufa, pare, dei degeneri accaduti dentro e fuori dal locale, che da tempo arricchivano le pagine di cronaca dei giornali. E si parla di tentati omicidi, violenze sessuali, risse, bivacchi di parcheggiatori abusivi e compagnia bella. Ciò nonostante per la mia generazione, per quelli cresciuti negli anni ’90, l’“Old”, come lo chiamavamo confidenzialmente tra di noi, un perché ce l’ha sempre avuto. Fin dall’aprile del ’95, quando riaprì con il nuovo nome, sulle ceneri del vecchio Piper. Lo storico locale beat in cui una sera nel 1968 suonò perfino Jimi Hendrix, in quella che passò alla storia come la sua unica travagliatissima data italiana. A chiamarla Old Fashion Cafè, facendosi ispirare da un cocktail americano a base di whisky molto in voga negli anni della cosiddetta Milano da bere, furono i fratelli Cominardi, ancora oggi gli attuali gestori, che, insieme a un loro socio, gallerista d’assalto e pronipote newyorkese di Gabriele D’Annunzio, un certo Markanthony, puntavano a farla diventare un punto di riferimento della vita notturna milanese. Ci sono riusciti per quasi trent’anni, facendo ballare generazioni di ragazzi.
Volevamo bene all’“Old”, un po’ perché per lungo tempo è stata l’unica discoteca ad avere un giardino all’aperto dove poter andare a ballare in centro quando faceva caldo senza doversi sbattere fino all’Idroscalo, e un po’ perché se mettevi i dischi o parlavi al microfono, come facevo io, era uno dei pochi locali del giro a rimanere aperto anche durante la stagione estiva. Fino ad un certo punto è stato un posto frequentato prevalentemente da fighetti: i pettinati come si diceva all’epoca. La selezione all’ingresso era rigidissima e se non eri accompagnato o vestito bene non entravi per nessun motivo. In linea di massima all’“Old” ci trovavi i figli dei massoni con la giacca blu, le scarpe di legno e la camicia bianca, le principessine naziste ondeggianti sui tacchi. Era il periodo in città in cui ancora comandavano i pierre, che decretavano i successi o i fallimenti dei locali, e i modellari, nient’altro che un manipolo di ragazzi di buona famiglia che avevano una serie di contatti con le agenzie di modelle, che decidevano quando, e soprattutto dove, portarsele dietro. La cultura imperante era ancora basata sul concetto di privé, un’idea iper-esclusiva, nata per necessità verso la fine degli anni Ottanta, quando ai locali bomboniera dei ragazzi bene, tipo il Nepentha e il Charlie Max, si sostituirono i casermoni alla Hollywood e alle bottiglie di Tattinger e agli Alexander con la noce moscata, le bocce di vodka o di rum. A cambiare tutto nei primi Duemila fu la musica: l’avvento della house, dei deejay superstar e delle serate, tipo il New York Bar, l’Exogroove, Colazione da Tiffany e soprattutto il Supalova, che il dj Joe T. Vanneli portò, mutuando quello che aveva visto suonando in giro a New York a Londra o a Ibiza, proprio all’Old Fashion, tutti i giovedì, nel 2004. Se passavi al Supalova il giovedì sera potevi trovare indifferentemente in consolle gente come Roger Sanchez, Tony Humphries o Carl Cox oppure Andy Fletcher dei Depeche Mode che mischiava nei suoi dj set l’electro-punk a dischi dei Kraftwerk, di Bowie, dei Roxy Music, di Boy George, o dei Visage.
Nel maggio del 2008 avevo 28 anni e lavoravo nei locali più o meno da quando ne avevo quattordici. Facevo il vocalist, parlavo al microfono. Per molti ero qualcosa di più di un deejay, perché intrattenevo, animavo, decidevo i tempi della serata. La gente mi conosceva con il nome di Andrea Spider, uno pseudonimo, un nome d’arte, che mi porto dietro fin dai tempi da sbarbo fiordilatte in cui facevo il pierre al sabato pomeriggio al Madame Claude. Lo trovavo un po’ ridicolo alla soglia dei trent’anni ma non potevo farci niente, mi era rimasto appiccicato addosso come un marchio. In quella che non potevo sapere sarebbe stata la mia ultima serata da resident all’Old Fashion arrivai con passo lento e strascicante e davanti al locale c’era ancora la fila per entrare, nonostante la mezzanotte fosse già passata da un pezzo. Mi ricordo che fingevo indifferenza, giocherellavo con una canna mezza spenta che tenevo in tasca. Spensi l’iPod e mi diressi verso il cordone, facendomi largo tra la folla con ancora indosso il cappuccio della Carhartt. Oltrepassai le transenne con qualche stretta di mano, camminando sul sontuoso tappeto viola e verde che portava all’ingresso. Feci un cenno ai tre buttafuori, dietro alle funi di velluto con i walkie-talkie, affidandomi a una ragazza in miniabito, decisamente bella, con la lista degli invitati stretta fra le braccia. Non mi girai nemmeno quando alle mie spalle sentii qualcuno gridare il mio nome. Raggiunsi la consolle ancora prima di prendere il microfono in mano chiedendo un cuba e dicendo alla sicurezza di allontanare un po’di gente. Poi mi accesi una Philip Morris gialla anche se nel locale era vietato fumare. C’era un casino boia, tutti avevano la camicia a parte me, che indossavo una t-shirt bianca con sopra il teschio dei pirati, e le ragazze erano tutte in miniabito, risuonavano le note di un vecchio pezzo di Gaudino che mettevamo al Casablanca al pomeriggio almeno cinque anni prima.
Poi la musica cambiò e lo show ebbe inizio. Rivolsi verso la pista il mio sguardo di disgusto. In quell’ultimo periodo era come se non mi interessasse più nulla: né il proliferare di polveri e pasticche che giravano da quelle parti, né le varie ragazze sculettanti, sempre sorridenti. Anche il secchiello pieno di ghiaccio con fissa la bottiglia di Veuve Clicquot, sempre presente in consolle, aveva smesso di destare interesse. Tutte le serate erano diverse e uguali al tempo stesso. Nulla rimaneva dei gloriosi tempi andati, delle feste selvagge negli scantinati, dei rave illegali a ballare con le mani nei capelli e le pupille ribaltate. Niente. Solo la solitudine, davanti al mixer, dietro al vetro, nella cabina del deejay. In mezzo a centinaia di persone ma irrimediabilmente solo. Così ho smesso, di colpo, e in una discoteca non ci sono nemmeno più entrato, dopo quella sera all’Old Fashion. «Hai sentito che chiude l’Old Fashion?», mi ha detto un tizio l’altro giorno. «Ah sì? Non pensavo fosse nemmeno più aperta. Non ci mettevo piede da una vita», gli ho risposto. Poi ho distolto lo sguardo e mi sono messo a fissare il vuoto, pensando a tutte le discoteche che frequentavo da ragazzo, che per un motivo o per l’altro non ci sono più. «Pensa che l’Old Fashion è stato anche l’ultimo posto in cui ho lavorato», ho aggiunto poi, mormorando qualcosa fra me e me.

I movimenti che vogliono rovinare il matrimonio di mr. Amazon non ce l'hanno solo, né tanto, con lui: il problema è ciò che Bezos rappresenta e il fatto che abbia deciso di venire a rappresentarlo proprio a Venezia.