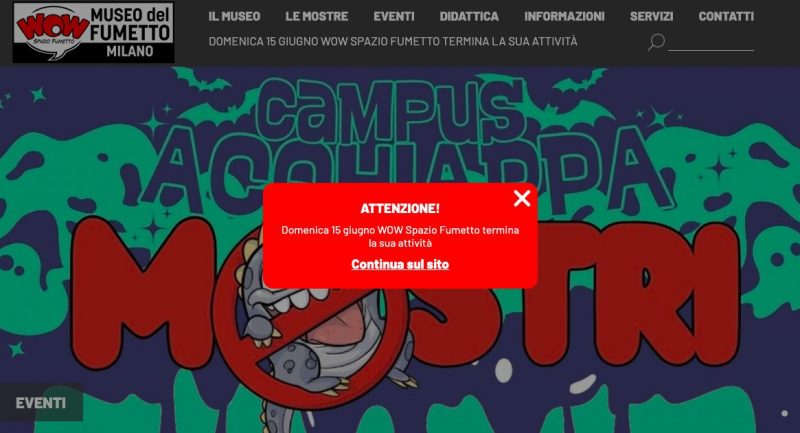Nei tre punti balneabili del fiume è già stata issata di nuovo la bandiera rossa. Stavolta, però, la colpa è della pioggia.
Qualche mese fa, nell’autunno del 2022, un agente immobiliare è passato da casa mia. Doveva andare al piano sopra, il quarto, ma il mio palazzo è senza ascensore e pensava di essere arrivato. Gli ho detto che al piano sopra non c’era nessuno – il piano è disabitato – e gli ho offerto di entrare per un bicchiere d’acqua. Ha detto che era una bella casa, e mi ha chiesto – istinto irrinunciabile dell’agente immobiliare – se avessi intenzione di venderla. Gli ho detto di no, che l’avevo comprata nel 2013 e che mi piaceva stare lì. “Lì” è una zona di confine tra il quartiere Fontana (che però viene ormai chiamato e venduto come Isola) e Maciachini. È una Milano nord che fino a vent’anni fa non sarebbe stata consigliabile a nessuno, e infatti i miei genitori, nel 2013, mi chiedevano allarmati: ma sei sicuro? L’agente immobiliare ha detto: «Peccato, questa la mettiamo fuori a…». Il prezzo era superiore al doppio di quello dell’acquisto.
Quando sono arrivato nel quartiere Fontana che tutti già allora chiamavano Isola, all’inizio degli anni Dieci, l’Isola di un tempo era già stata spazzata via dalla speculazione edilizia. La Stecca degli artigiani era stata abbattuta, la Biblioteca degli Alberi era un progetto già approvato e già in fase di realizzazione, l’ecomostro di Ligresti resisteva in via de Castilla. Proprio nel 2013 l’uscita del libro Fight-Specific Isola, del collettivo Isola Art Center, sanciva la sconfitta dei movimenti di resistenza alla gentrificazione. Un amico che viveva nel quartiere da molti anni prima di me mi indicava i palazzi che un tempo erano stati case d’appuntamento e che sono poi diventati bar per motociclisti fighetti (all’epoca erano una cosa di moda).
Conosco la mia portata gentrificatrice, per quanto modesta. Ho visto, negli anni, il mio palazzo popolarsi di classe creativa come quella di cui faccio parte, e per quanto andassi a fare la spesa al vecchio fruttivendolo sotto casa, so che la pizzeria gourmet che l’ha soppiantato ha aperto sperando di attirare clienti “come me”. Siamo tutti, quindi, i gentrificatori di qualcun altro? Fino a un certo punto, poi c’è un limite: il prezzo che l’agente immobiliare mi ha proposto è ingiustificabile sotto ogni punto di vista, ed è sintomo che la marea della speculazione che sta crescendo da una quindicina d’anni a Milano ha tracimato gli argini, raggiungendo livelli che non si credevano possibili, in questo piccolo mondo antico italiano. Il 2023, sui social e nel chiacchiericcio pubblico, quello che si fa anche su Whatsapp, alle cene, agli aperitivi, è diventato l’anno della rivolta contro il “modello Milano”. Il Corriere della Sera, in un articolo che riassumeva articoli apparsi sul Foglio, sul Fatto, e anche su queste pagine, titolava: “Milano sul banco degli imputati”.
Il tic identitario è dietro l’angolo, quando qualcuno tocca il posto in cui sei nato e cresciuto, o il posto in cui ti sei sentito accolto e hai fatto magari una certa fortuna. Ha preso anche a me, all’inizio: e quando sentivo certe critiche mi irrigidivo, e rispondevo che Milano è la città più accogliente d’Italia, e che la mobilità pubblica è comunque la migliore del Paese, e gli investimenti sulle ciclabili, e i nuovi parchi, e il piano di rinverdimento ForestaMi, la tolleranza, e così via. Il fatto è che io l’ho vissuta la versione precedente, di Milano, quella dipinta come grigia e triste, «fredda, frenetica e senza pietà», come diceva Alberto Fortis. E qualcosa a un certo punto si è innescato, è vero, e il clima è cambiato, migliorando nettamente. Cosa vuol dire “migliorare”? Milano si è fatta una città più bella, più aperta, più libera, più coraggiosa, più culturalmente vivace. Ma il marketing è sempre una bugia, e quando un complesso processo di rinnovamento culturale diventa uno slogan – Rinascimento – allora la complessità si appiattisce. La battaglia diventa – appunto – identitaria. O stai dentro o stai fuori. Non esistono vie di mezzo. A ogni dubbio, critica e perplessità rispondevo: «Allora vogliamo tornare a quando c’erano Moratti e Albertini?». Ogni cambiamento era buono, purché fosse un cambiamento.
Le cose, come spesso accade, sono complicate: a livello immobiliare, gli ultimi quindici anni hanno stravolto la città, hanno fatto nascere uno skyline prima inesistente e hanno contribuito a comunicare in modo immediato una percezione di cambiamento ed evoluzione, un nuovo corso iniziato più o meno con l’elezione Pisapia e culminato con Expo 2015. L’entusiasmo per la rivoluzione arancione del 2010 aveva coperto le inevitabili ambiguità della prima giunta di centrosinistra dai tempi di Mani Pulite: da un lato gli sgomberi dei centri sociali Macao, Zam, Lambretta, la vendita di 25 immobili nel nuovo quartiere di Porta Nuova al fondo sovrano del Qatar; dall’altro la nascita di Area C, lo sviluppo del bike sharing, il registro delle unioni civili. Sui grandi progetti che oggi vengono identificati come il simbolo del Rinascimento della Milano del Partito Democratico, e allo stesso modo criticati, le amministrazioni Pisapia e Sala hanno potuto fare poco: sono tutti stati avallati dalle giunte precedenti, e ai sindaci del Pd è toccato inaugurarli. Sono Porta Nuova, CityLife e Portello. Il primo è il quartiere della Biblioteca degli Alberi, del grattacielo più alto d’Europa, del Bosco Verticale che tutti fotografano ma in pochi abitano e dell’ecomostro incompiuto di Ligresti; il secondo è quello con le navi da crociera di Zaha Hadid ora casa dei Ferragnez e di altri calciatori e influencer, e i tre grattacieli atterrati dallo spazio – non certo da una tradizione architettonica meneghina – in mezzo a un parco spelacchiato; infine il Portello, ennesimo centro commerciale da cui si alzano, come piramidi in un deserto di cemento, i discutibili trapezi di Fabio Novembre.
Mentre crescono i grattacieli, crescono i milanesi. La ricchezza milanese degli ultimi quindici anni è stata soprattutto questa: la capacità di accogliere un patrimonio umano che ha ridisegnato la città, socialmente, commercialmente e geograficamente. E quindi questa nuova fase di sviluppo la si nota anche dai dati demografici: è dal 2008 che la popolazione aumenta sia come residenti che come domiciliati. Non solo gli italiani, ma soprattutto gli stranieri: sono il +47 per cento nel periodo 2008-2017. E poi, moltissimi giovani: i residenti tra i 19 e i 25 anni, nella stessa fascia temporale, sono aumentati del 22 per cento. Sono percentuali enormi, e le risposte politiche per gestirle non saranno mai semplici, né prive di problemi.
Cosa si vuole giudicare, quando si mette una città sul banco degli imputati? Non il milione e mezzo di abitanti, che sono poi ciò che riempie la parola Milano. Mi sembra che i nervosismi tra fazioni siano relegati soprattutto a una difesa a prescindere dell’entità “Milano”, e dall’altro lato a certi cortei trionfali – di Milano si è sempre parlato male, da fuori, spesso e volentieri – di chi non vedeva l’ora che finisse la narrazione del Rinascimento milanese. Il problema è, da un lato, di comunicazione: una città è di per sé un ecosistema complesso, e una città in crescita lo è enormemente di più. Complessi, quindi, devono essere i metri per comunicare le contingenze, per valutare e tentare di migliorarle. Il marketing, viceversa, non lo è affatto, altrimenti non funzionerebbe: è semplificatorio, e soprattutto furbo. Ma anche la furbizia, a volte, si inceppa: quando il marketing dice: “Milano non si ferma” e non capisce che si dovrebbe fermare subito, allora è un marketing cretino.
C’è quindi, oggi, un’insoddisfazione crescente verso un modello comunicativo da cui stampa e opinione pubblica si sono abbeverate per oltre un decennio, fatto anche di slogan e compiacimento. Poi, più in profondità, quello che si è messa in moto non è – non dovrebbe essere – un attacco a Milano, ai suoi tic, ai suoi caratteri di sempre: ma la messa in discussione di un modello di sviluppo globale che specialmente dopo il Covid ha mostrato i suoi limiti. Quello a cui stiamo assistendo a Milano non è inedito, e non è poi così colpa: molte delle città che hanno vissuto un aumento del turismo, del numero di residenti e domiciliati, e di conseguenza una serie di investimenti immobiliari esterni, in Europa e in Italia, si sono trovate ad affrontare grandi problemi sociali, legati soprattutto al caro abitativo. Un attacco, in un certo senso. Sta succedendo a Berlino, a Lisbona, a Barcellona. In Italia, soprattutto a Bologna.
Il modello abitativo che sta prendendosi queste città ha come fine, o effetto collaterale, quello di escludere i cittadini stessi. È un modello suicida, oltre che crudele: se proprio questo tipo di crescita demografica (studenti + giovani + stranieri) ha contribuito a una ritrovata vivacità culturale e commerciale della città, trasformare Milano una città esclusiva interromperebbe quello stesso processo che l’ha resa interessante soprattutto “dal basso” nell’ultimo decennio.
Sono nato a Milano e ho fatto tutte le scuole a Milano. Sono cresciuto nell’hinterland, e poi in città. Sono uno dei pochi nativi, e spesso mi sono chiesto: di cosa è fatto l’Heimat che mi fa chiamare “casa” questa città? La verità è che quello che io sento come profondamente milanese sta scomparendo proprio sotto i colpi degli slogan compiaciuti e delle Torri Isozaki, dei quartieri-ristorante e delle costruzioni frettolose e pacchiane. A poco a poco, quello che ci sembrava una novità colorata e vivace per ridare allegria al grigio dei quartieri sta mangiandosi tutto, come una specie alloctona che devasta l’equilibrio centenario di un habitat. Le strade sono mostrificate di insegne di pizzerie gourmet, i mercati pubblici vengono ristrutturati in “food hall” con macellerie pregiate di tagli curiosi e costosi (piazzale Lagosta); nel frattempo, chiudono le librerie di quartiere che riforniscono le scuole, le cartolerie, i fruttivendoli, le mercerie, i ristoranti meno cool ma che servivano uno specifico e limitato numero di case e isolati: ma non dovrebbe partire proprio da questi posti la città a 15 minuti? I cantieri generano palazzi di vetro destinati a rimanere semi-disabitati e affittati a breve termine, che potrebbero appartenere a Nanchino come a Stoccolma o Mumbai, privi di tradizione né dialogo con il contesto. I nuovi edifici si dotano di sparuti alberelli ai balconi a nascondere finiture di scarsa qualità, una patacca di Bosco Verticale da fotografare prima di tornarsene nella propria stanza pre-ammobiliata.
Leonardo Benevolo, uno degli urbanisti più importanti degli ultimi decenni, morto nel 2017, disse, a proposito del parco Tre Torri: «Abbiamo distrutto il nostro paesaggio, che è un patrimonio di rilevanza mondiale». David Chipperfield, uno degli architetti che aveva proposto una CityLife senza grattacieli, ma fatta di un vero, grande parco cittadino, ha detto: «La città lasciata in mano ai developers si prostituisce al miglior offerente: diventa un campo dove proliferano le operazioni più redditizie e più tristi».
Fortunatamente, un certo pragmatismo milanese esiste ancora: un messaggio dell’assessore Casa e Piano Quartieri Pierfrancesco Maran mi ha avvertito dell’inizio, lunedì 20 marzo, di “Forum Abitare“, una tre giorni di incontri per affrontare i problemi presenti e futuri. Nel pdf, molto dettagliato, si leggono molte cose buone, giuste e critiche: si riconosce che il 40 per cento degli acquisti immobiliari a Milano hanno finalità di investimento, pratica a cui mettere un freno, la necessità di calmierare gli affitti e di investire su una migliore infrastruttura pubblica, l’altrettanto importante necessità di un supporto statale per dare alle città un potere di limitazione all’ospitalità turistica che oggi non possono avere (tranne Venezia), e molte altre cose. Saranno tre anni fondamentali per l’amministrazione Sala e per questa città.
È Milano stessa, alla fine, a trovarsi minacciata. Una città è fatta da chi la abita, ma se i processi economici finiscono per emarginare questi abitanti per sostituirli con compratori più forti, allora questi processi non li chiameremo Rinascimento né modernità: sarà invece il tentativo di trasformare Milano in un’altra realtà, architettonicamente e antropologicamente parlando.

I movimenti che vogliono rovinare il matrimonio di mr. Amazon non ce l'hanno solo, né tanto, con lui: il problema è ciò che Bezos rappresenta e il fatto che abbia deciso di venire a rappresentarlo proprio a Venezia.