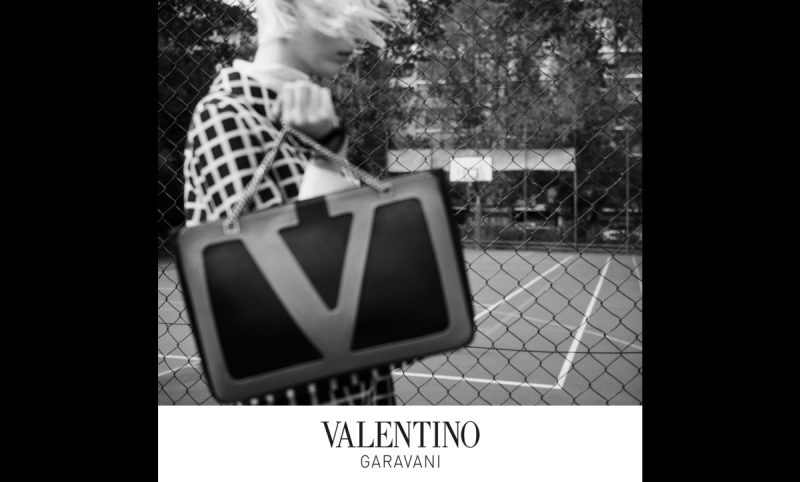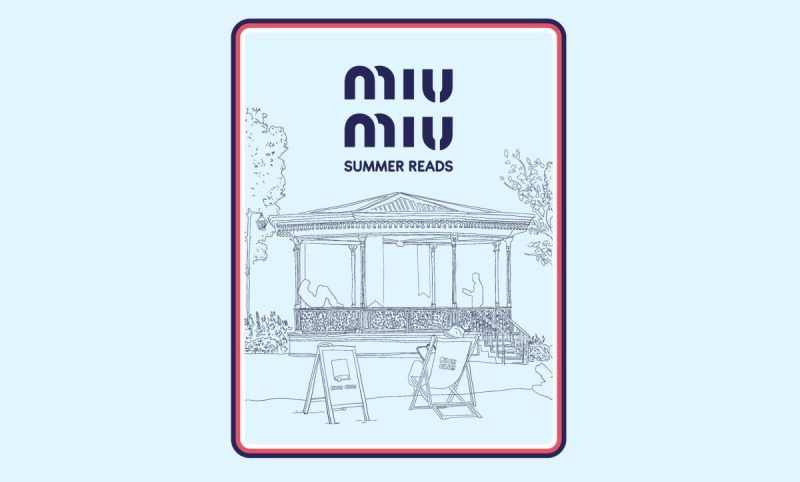È il secondo capitolo della collaborazione tra i due marchi, lanciata lo scorso settembre con una collezione maschile il cui testimonial d'eccezione era Martin Scorsese. Ora, per la prima volta, comprende anche una collezione donna.
Nonostante tutto sembri organizzato per tendere verso la tragedia, lo strazio e il mélo, High & Low: John Galliano, il bel documentario di Kevin MacDonald è invece una spassosa gemma camp che produce una gioiosa nostalgia per quel grand guignol che la moda è stata, non sarà mai più, e che noi ci siamo miseramente persi. E il merito di questa tridimensionalità va tutto a John Galliano, che non si risparmia e sin dall’inizio si dice pronto a raccontarci tutto, ma per farlo deve accendersi una sigaretta. Ed effettivamente lo fa. Racconta di come è passato da squattrinato genio diplomato alla Central Saint Martins, la celebre scuola di moda londinese, con una collezione di laurea eccezionale, a disegnare trentadue collezioni all’anno, per il suo brand omonimo e per Dior, che ha disegnato dal 1997 al 2011. Prima di approdare da Dior, era stato il primo designer britannico a ottenere la direzione creativa di una Maison francese, Givenchy, scettro che passerà ad Alexander McQueen, ma questa è un’altra storia. Il documentario è attraversato da un parallelismo sfacciato con Napoleone, che parte proprio da quella sfilata di laurea, intitolata Les Incroyables, fatta di ispirazioni neoclassiche e mollezze New Romantic da Blitz Kidz. E lì già si intuisce tutto, tanto che il giornalista di Vogue Us Hamish Bowles si spinge a dire che Les Incroyables è una delle cinque sfilate più belle che abbia mai visto. E si intuisce cioè che non ci troviamo di fronte a un bravo designer, ci troviamo davanti a un designer totale. Forse veramente a un poeta. E parafrasando l’elogio funebre di quello per quell’altro «di poeti non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Galliano sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe esser sacro».
E poi ci sono le interviste d’archivio, con lui sempre sudatissimo dopo le sfilate, in cui chiede qualcosa da bere e fuma e sembra sempre all’apice di una botta di coca buonissima. E poi quelle fatte per il documentario agli amici e ai collaboratori, celebri e senza bisogno di cognome, come Kate e Naomi, e poi agli addetti ai lavori come Anna Wintour e Sidney Toledano, l’uomo di Lvmh, lei mecenatesca, lui padre-padrino. E poi c’è sempre lui, in maglietta e capelli leccati all’indietro, assente e sornione insieme, attore, con la voce profonda e metallica e magnetica che guarda in camera come un consumato mattatore, e fa venire in mente quel film di Sally Potter del 2009, Rage, bellissimo e bistrattatissimo e sperimentalissimo, in cui una camera fissa dell’ipotetico cellulare di un ipotetico blogger intervista il febbricitante circo che sta dietro a una qualche sfilata, solo primi piani su sfondi lisergici fluo, e uno di questi intervistati è chiaramente modellato sul nostro Galliano, esasperandone i tic e la teatralità, e fa specie ripensarci ora, a come in quel 2009 lui fosse al picco della rilevanza e proprio a due passi dal baratro. Ma nel 2024 Galliano sembra avere invece acquisito la saggezza lunare di chi ha consumato droghe in abbondanza fino a quasi ammazzarsi e poi ha smesso e adesso è sobrio da undici anni. Nonostante il documentario cerchi di convinverci del contrario, quella di Galliano è in realtà una storia a lieto fine, innanzitutto perché è ancora qui.
Si sorvola, forse troppo, su tutto quello che Galliano ha fatto dopo (dopo cosa ci arriviamo, perché è in fondo l’elefante nella stanza) e in particolare cosa sta facendo come direttore creativo di Maison Margiela, dove è arrivato nel 2014 e dove oggi sembra vivere un momento di particolare splendore, soprattutto a seguito del successo della sfilata couture dello scorso gennaio, apprezzatissima dai critici e diventata virale sui social. Si sorvola anche sul ruolo di Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior, in modo forse un po’ comicamente indelicato, non la si menziona proprio, come non si menziona del resto Raf Simons che succedette a Galliano dal 2012 al 21015, lo stesso Toledano ribatte sull’irripetibilità di quell’esperienza gallianesca. Commuovono quelli che se ne sono andati, come Steven Robinson, braccio e mente pragmatica del periodo da Dior, uno di quei personaggi, fondamentali in tutte le storie di moda, che fanno succedere le cose, proteggendo il genio e la sregolatezza, non si sa poi mai bene a quale costo. E commuovono storie personali che oggi farebbero esplodere gli uffici HR, come quando a pochi giorni da uno show il padre di Galliano muore e lui prende il jet privato del signor Arnault per andare al funerale, in giornata, e la sera si torna in atelier per le prove finali dello show, che è nel caso di Galliano sempre performance e teatro e mise-en-scène totale.
L’elefante nella stanza è invece lo “sbrocco” pubblico di quando, una sera qualunque del 2011, venne ripreso a ripetere insulti antisemiti al Café La Perle, epicentro di modaioli e wannabe nel mezzo del Marais che è storicamente il quartiere ebraico di Parigi. In quel periodo Galliano era all’apice dell’autodistruzione che coltivava con amore e che era il risultato delle sue tre grandi ossessioni, ovvero l’alcool, i farmaci e il lavoro. Ci sono anche le sessioni intensive in palestra, che se all’inizio servivano a ristabilire un contatto con la realtà dopo le sbronze colossali che seguivano le sfilate, si trasformano ben presto in ossessione anche quelle: Galliano non si è mai nascosto davanti a nulla, neanche alla sua vanità. E la vanità è un tratto così interessante di Galliano: in fondo il titolo di designer superstar è forse stato inventato per lui e per Karl Lagerfeld. Altro designer totale in cui tutto si mischia e tutto si fa teatro, ma senza dubbio meno bravo di John Galliano nel disegnare vestiti. Quello scandalo portò alla cacciata da Dior e alla rovina e alla gogna, per giustissime ragioni e per cui lui poi si scusò e fece penitenza, per qualcuno a sufficienza, per qualcuno no, per qualcuno era un antisemita convinto, per qualcuno solo un tossico incapace di intendere e di volere, come avremmo poi imparato, queste cose diventano fatti polarizzanti e inconciliabili. Per sempre. Ma di questo si è parlato, e credo possiamo essere tutti d’accordo, a sufficienza.
Un aspetto poi meravigliosamente europeo di Galliano è il suo opporsi fermamente al ruolo di vittima. Non si abbandona mai a quel tipo di comfort, che sarebbe invece oggi la scelta più semplice, per lui, per tutti, anche per il documentarista. Si sarebbe potuto mettere addosso un look penitenziale, una tuta grigia, e invece no. Lui sta lì e sembra davvero pensarci alle cose, in uno stupore investigativo continuo, verso sé stesso, verso il mondo. Uno stupore che è curiosità, che è poi il terreno di coltura del genio. E l’acqua che invece il genio lo nutre è l’ossessione, totale, per quel che si fa. E non c’entra niente la moda, vale per Philippe Petit che camminò su una fune tesa tra le Torri gemelle come per Ottmar Mergenthaler che ha inventato la linotype, anche lui ossessionato dal lavoro, e morto quarantenne. E di ganci per costruirsi a tavolino il ruolo di vittima ne avrebbe avuti. Nato a Gibilterra in una famiglia iper cattolica e omofoba, fonte di glamour interiorizzato (la religione sicuramente la si ritrova nella grandeur lisergica dei suoi abiti, anche quando parlano di antico Egitto o di clochard), figlio di un padre macho e violento verso il quale lui non sembra portare rancore, o almeno così ci racconta: erano altri tempi e le cose andavano così, dice scrollando le spalle. Dopo lo scandalo, Galliano fu visto uscire da un appartamento di New York vestito con degli abiti e una capigliatura che potevano ricordare quelli di un ebreo chassidico, come a prendersi gioco di quello che era successo. Quando ne chiedono conto alla sua agente c’è uno dei momenti più esilaranti del documentario: lei sta in silenzio, fa una faccia tra l’incredulo e lo sconsolato, e poi dice qualcosa tipo «E chi cazzo lo sa perché ha fatto quella cosa, di certo avrebbe potuto evitare». Lui invece risponde semplicemente: «Non era una provocazione, era solo un look!», e la cosa assurda è che non si può non credergli. Non ci aveva pensato, o forse è quella la grandezza della moda di Galliano: la fedeltà all’immagine. Il documentario purtroppo non va molto oltre questa storia, successa più di dieci anni fa. Fortunatamente Galliano non è morto: è vivo, è sobrio, è ancora con noi.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.