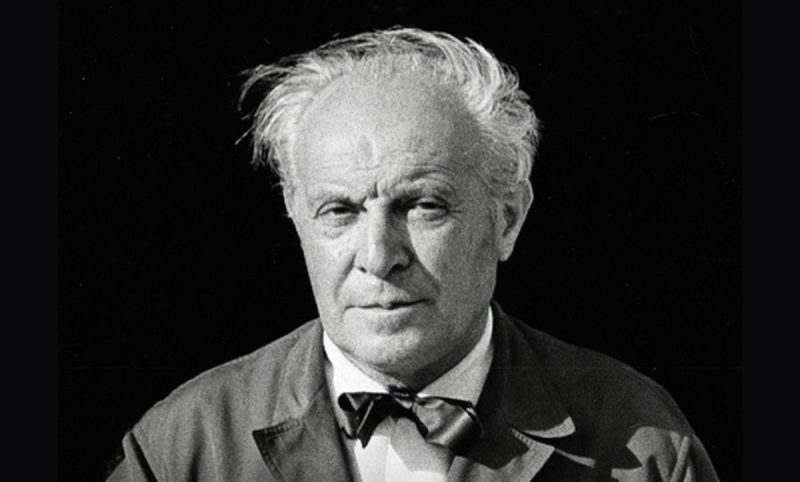Aprirà all’interno dell’ADI Design Museum, in piazza Compasso d'Oro 1, entro la fine del 2026.
Questo è il terzo articolo della nostra serie estiva “Gran Turismo” , in cui le autrici e gli autori di Rivista Studio raccontano luoghi e città dal punto di vista del turista o di chi i turisti li subisce. È un modo, un po’ più leggero, per continuare a far vivere il nostro numero estivo, tutto dedicato al turismo: da come, negli ultimi anni, sia diventato un problema politico (overtourism), a come nonostante tutto, il viaggio continui a conservare una sua dimensione romantica. Lo trovate in edicola e sul nostro store online.
Nell’estate del 2002 l’Europa aveva una forma irripetibile, che non avrebbe più ritrovato, antica e ringiovanita, vicina e lontana, c’era già l’euro, c’era Internet ma solo in luoghi sicuri e prefissati a tariffa fissa, potevi usarlo per cercare gli ostelli ma dovevi prenotarli chiamando da un telefono a gettoni, non c’erano gli smartphone né i social network, eravamo liberi e non lo sapevamo, le forme personali nostre e quelle generali del mondo avevano ancora la plasmabilità fluida e spontanea del secolo precedente, anche la Repubblica Ceca esisteva da poco come Paese nuovo, prendere un treno da Roma e arrivare a Praga poteva sembrare una discreta avventura, c’era stato da poco l’11 settembre e quella fu anche l’estate in cui per la prima volta sentii parlare di Ryanair.
Quando Studio mi ha chiesto di dare il mio contributo a questa serie estiva raccontando «una città o una spiaggia, una collina o una valle, un’isola o un borgo sperduto», ai quali fossero collegati ricordi remoti e fondativi, personali ma con un significato collettivo, mi sono accorto che il mio problema è che io non ho una città o una spiaggia, una collina o una valle, un’isola o un borgo a cui senta di appartenere in quel modo lì, qualcosa dove poter tornare, da rimpiangere e descrivere, per dire questo è il mio personale contributo alla persistenza del tempo. Sono cresciuto in una famiglia inquieta che non ha mai saputo cosa fare delle proprie estati, erano esuli dalle proprie origini e appartenenze, quel vuoto da riempire era il compito esistenziale per le vacanze. Era come se ogni estate il concetto di estate fosse stato appena inventato. Ogni anno provavamo a darci un canone nuovo e tendenzialmente non funzionava mai: sono stato un pioniere nella scoperta degli infiniti modi che ha il turismo di rendere infelici le persone.
L’estate del 2002 avevo diciannove anni e per la prima volta mi sganciai da questo tentativo familiare di inventarci una tradizione, come compito per le vacanze iniziai a cercare piccole mitologie personali, da allora iniziò una sequenza di progetti sconnessi e vagamente squilibrati concepiti durante l’anno per essere verificati a luglio e agosto e nessun progetto è stato sconnesso e apertamente squilibrato come quello dell’estate del 2002, quando decisi di mettermi in viaggio da solo per incontrare una persona con cui scambiavo lettere da quando ne avevo quindici, una mia coetanea norvegese, una persona di cui non sapevo niente ma di cui sapevo anche moltissime cose.
Era la versione analogica e artigianale di un problema che decenni dopo sarebbe diventato strutturale: verificare se l’immagine di me che avevo costruito per qualcuno somigliasse anche solo minimamente a quello che ero in grado di essere. Lei si chiama Eva, ancora oggi ricevo sporadici aggiornamenti della sua vita grazie a Facebook, è una delle poche persone di cui ricordo la data del compleanno senza reminder digitali, in quegli anni ci eravamo scritti centinaia di lettere e non avevamo mai parlato a voce né ovviamente ci eravamo mai incontrati. Ci eravamo agganciati in quegli indirizzari online per aspiranti amici di penna che esistevano nel Web di fine anni ’90. Trascrivevamo testi di canzoni, avevamo una lista sempre aperta e in lavorazione di cose per cui valeva la pena vivere che compilavamo parallelamente alle lettere, conoscevo i nomi dei suoi gatti, dei suoi genitori e dei suoi amici, mi mandava disegni che tenevo alle pareti della mia stanza, mi iniziò ai paesaggi nordici e all’heavy metal.
Nell’autunno dell’anno precedente le avevo scritto che avrei fatto un giro per l’Europa l’estate successiva, lei disse: anche io voglio fare un giro per l’Europa la prossima estate. Allora facciamone un pezzo insieme, così ci incontriamo. Praga ci sembrava a metà strada tra la Norvegia e l’Italia, prendemmo appuntamento per lettera, senza mai avere una mail o un numero di telefono per confermare nulla, Catfish non esisteva ancora, né come programma Tv né come concetto, comprai una guida della città, scelsi un punto che mi sembrava centrale, era un ponte, glielo comunicai, scelsi un orario, le comunicai anche quello, l’ultimo scambio epistolare avvenne a maggio, o a inizio giugno, poi con una fiducia irripetibile e impensabile per il me dei due decenni successivi feci due giorni ininterrotti di treno per arrivare a Praga in una mattina caldissima di metà luglio, pensando: sto davvero facendo questa cosa qui? Una cosa che non era né grande né piccola, né pericolosa né avventurosa, era solo specificamente mia, il nuovo canone delle mie estati giovanili. Non ho idea di come sia oggi fare un Interrail, nel 2002 mi sentivo puntino piccolissimo su una mappa enorme, avevo un quaderno, un Nokia che per tutto il viaggio è rimasto scarico e inutilizzato perché tanto non serviva a niente, leggevo un romanzo di Jonathan Coe. Avevo un’idea vaga di me, dell’Europa, della mia tolleranza agli alcolici, della qualità del mio inglese, del mio spirito organizzativo, della mia stessa capacità di rimanere curioso delle cose del mondo per un mese intero. Niente mi interessava a tal punto.
Per un miracolo che oggi mi sembra quasi metafisico, nonostante le premesse riuscimmo a incontrarci, senza telefono, senza sms, senza Whatsapp, senza nessuna rete di salvataggio dagli imprevisti rispettammo patti e promesse e passammo una settimana insieme a Praga. Non ci incontrammo né all’ora né al posto scelti da me, perché ero arrivato prima di lei, e andai a prenderla all’autobus Eurolines che arrivava da Oslo la mattina del suo arrivo. Lei scese per ultima, era uguale all’unica foto che mi aveva mandato, solo più vecchia di due anni, stropicciata e assonnata dal viaggio, aveva uno zaino enorme, dissi il suo nome per controllare che fosse tutto vero, mi sorrise, quindi era tutto vero.
C’erano diverse cose che non ci saremmo potuti raccontare per lettera, e che potevano essere verificate solo sul campo. Per esempio, non avevo idea di quanto si potesse bere con un’adolescente scandinava alla prima vacanza da sola nella vita. Dopo un lunghissimo abbraccio mi disse: va bene, andiamo a prendere qualcosa da bere? Erano le dieci del mattino. Andammo a prendere qualcosa di bere. Quella lunga sessione alcolica si sarebbe conclusa una settimana dopo. Fummo cacciati da una mostra di Mucha, da un cimitero e da un McDonald’s. Ci divertimmo e fummo felici, era un film di Godard ma anche uno di Vintenberg. Facemmo amicizia con degli altri norvegesi di cui non ricordo nulla se non un bagno in un fiume. Ci siamo fatti promesse che non eravamo in grado di mantenere, ci siamo raccontati la nostra vita daccapo, i genitori, gli amici, i gatti, l’università, i progetti, inventavamo personaggi e poi li interpretavamo per ore, per quello che ricordo non dormimmo mai. Su quel ponte ci siamo arrivati, alla fine, e ci siamo baciati lì, sotto il temporale, la vita non sempre è perfetta, ma a volte lo è. Dopo una settimana, come se fosse finito un giro di ballo, lei prese un treno per Bratislava e io uno per Berlino.
Da come prosegui il mio giro per l’Europa, la mia botta alcolica non doveva essere finita. Visto dall’alto di una mappa, il mio era il percorso di uno che barcollava, dopo Berlino puntai su Cracovia, risalii fino al Baltico e poi mi ritrovai a Colonia, poi in Belgio, chiusi a Parigi, dove comprai un altro libro perché avevo letto La casa del sonno già due volte. Per un mese nessuno a parte me seppe niente di dove fossi, mandai tre e-mail a casa, girare l’Europa in quel modo era una forma di sonnambulismo creativo, non imparai nulla ma non volevo imparare nulla, in ogni città ero una persona diversa, ho stretto amicizie che mi sembravano eterne di persone che non ho idea che fine abbiano fatto, mi sono innamorato spesso, ho preso psichedelici, ho scritto un racconto che mi sembrava eccellente (non lo era). Era una estraneità molto ben coordinata, senza domande, senza risposte, tutto sommato senza ansie. Arrivai a casa all’alba, stavo per fare vent’anni. Raggiunsi i miei familiari in una casa al mare che avevano preso per quell’estate, per festeggiare con loro il mio compleanno, un altro dei posti dove non siamo più tornati. Stampai le foto. Erano tutte inspiegabilmente orribili, tranne una di me e di Eva che ci avevano scattato i nostri amici norvegesi, poi l’ho persa in uno delle decine di traslochi dei decenni successivi, non c’erano copie digitali, posso solo ricordarmi che facce avevamo.

Nato con scopi educativi, prima di essere commercializzato, il famoso gioco da tavola incarna da decenni il capitalismo immobiliare. Ma una nuova versione si propone adesso di ritornare al suo senso originario.