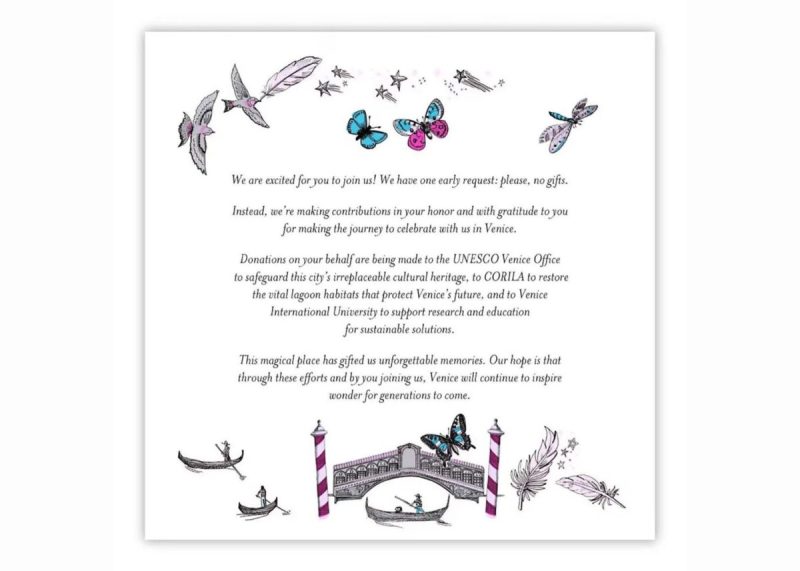Lo ha fatto con una direttiva che l’Italia deve recepire entro il 2026. L'obiettivo è una maggiore trasparenza e, soprattutto, contribuire alla diminuzione del gap salariale tra uomini e donne.
Alla mamma vlogger, ex star di YouTube, hanno dato 60 anni di carcere, per aver maltrattato i suoi sei figli, costretti a vivere come «in un campo di concentramento». Nessuno aveva sospettato nulla, finché il figlio più grande, denutrito e con segni di nastro adesivo su polsi e caviglie, non era scappato dai vicini chiedendo aiuto. Nessuno, tranne gran parte dei suoi follower su YouTube (più di due milioni e mezzo) che non solo l’avevano capito ma avevano lanciato una petizione online per strappare quei poveri bambini dalle grinfie della madre e della sua “amica” e life coach, con quest’ultima che si era stabilita a casa dopo che il padre era stato – diciamo così – estromesso dal business familiare. “I soliti haters”, avrà pensato il Commissario Winchester locale.
Comunque si tratta dell’ennesimo colpo di grazia all’influencer economy, di cui dobbiamo sorbirci anche i contenuti sul suo stesso disfacimento quotidiano, ma questa volta nel settore del parenting. L’ambito, questo, che ci ha avvelenato l’esperienza dell’essere genitori millennial, ricoprendola di una cappa oppressiva di procedure da seguire, regole montessoriane cui aderire, lista infinita di prodotti per l’infanzia da comprare. Abbiamo dovuto far diventare anche la genitorialità un culto, con le adepte-pancine chiuse nei loro gruppi a condividersi consigli mentre parallelamente si costituiva anche la tifoseria opposta, quella raccolta intorno al SignorDistruggere che faceva passare il messaggio che le mamme sono delle deficienti da dileggiare.
Nel frattempo, giovani donne di tutto il mondo trovavano un lavoro e un posto nell’economia dell’attenzione semplicemente facendo figli, e condividendo tutto della loro esperienza genitoriale. Le opportunità di fare content sono sempre state molteplici: racconti di parto (con gradi di splatter variabile a seconda dell’audience), documentazione passo per passo della gestazione (con quell’app che paragonava la dimensione del feto a frutta e verdure). E poi il profluvio di foto: talmente tante che di certi bambini che hanno avuto l’intera infanzia spiattellata online, si può ripercorrere tutte le tappe di crescita (da avocado a cinquenne) solo scrollando velocemente avanti e indietro il feed del genitore.
Internet ci ha reso dei genitori di merda. Insicuri, continuamente giudicati da chiunque, alla continua ricerca di approvazione esterna, ossessionati dalla performance dei nostri figli, incoerenti nel cercare di fare bene e nel doverlo poi rappresentare. I social media hanno reso la semplice condivisione di una foto, di un momento felice in famiglia, un incubo. Sono le foto che attirano più like e commenti, e complimenti, e questo perché polarizzano. Subito dopo i complimenti arrivano le sottili considerazioni, le domande a trabocchetto (“ma a tre anni ancora ha il cuccio?”, “ma quel letto lì dietro è montessoriano?”). Nella vita reale, la “mamma che posta tanto su Facebook” è sempre quella additata appena si gira: “ma non si rende conto che così danneggia il figlio?”, “Io l’ho dovuta bloccare”. Quel vezzo di coprire la faccia dei figli con le emoji è poi diventato barzelletta collettiva: come dire, condivido questo momento di gioia, ma “salvando” mio figlio dallo scrutinio pubblico.
E anche io a volte vorrei postare foto e dire al mondo che mio figlio è bellissimo, è eccezionale, è arrivato primo alla gara di nuoto (dove gareggiavano in due) ma ormai non ce la faccio più: troppa pressione. Gli hater, gli invidiosi, i pedofili nascosti, l’idea che mi denunci una volta diciottenne. Meglio lasciar fare alle professioniste del parenting, alle Disperatamentemamma, che poi si sono rivelate delle bugiarde patologiche. Chi cercava un ossessivo ritorno alla natura, chi tecnologizzava qualsiasi atto d’accudimento, con buchi di storytelling da post a post, da foto a foto, senza che nessuno si interrogasse mai della congruenza di quello che stava vedendo; se ci fosse effettivamente una logica, o se era solo creazione spasmodica di contenuto per mantenersi in hype (col foraggiamento da parte degli sponsor), manie di controllo esercitate sui figli, pensiero paranoico e adesione a “nuove teorie”, svincolate dalla medicina ufficiale.
Ha detto al giudice la mamma vlogger americana: «Sono stata portata a credere che questo mondo fosse un luogo malvagio, pieno di poliziotti che controllano, di ospedali che provocano danni, di agenzie governative che fanno il lavaggio del cervello, di capi della Chiesa che mentono e si lasciano trascinare dalla lussuria, di mariti che si rifiutano di proteggerti e di bambini che hanno bisogno di essere maltrattati». L’essere cronicamente online ha compromesso la capacità della mamma vlogger di distinguere tra realtà e finzione. Che la vita reale non ha necessità di essere rappresentata, che i fatti non si svolgono seguendo degli storytelling, che figliare non è un “contenuto spontaneo”. Ma le cose pare, stanno cambiando: sempre meno genitori intanto hanno voglia di postare alcunché online riguardo la genitorialità: forse si concedono giusto qualcosa, la manina del figlio appena nato (tanto per farlo presente alla gente del quartiere), il disegno di una casetta stortignaccola. E poi appunto le nuove mamme online sono come Alexandra Sabol, tiktoker. Nel suo video più famoso da tre milioni di visualizzazioni, fa vedere come prepara la colazione ai figli: faccia scazzata, piatto lanciato, roba processata trecento volte schiaffata nel piatto e data a figli con almeno due iPad a testa. Che contenuto fresco, che onestà, questo sì che può essere definito “spontaneo”: il neorealismo è la nuova frontiera della genitorialità.