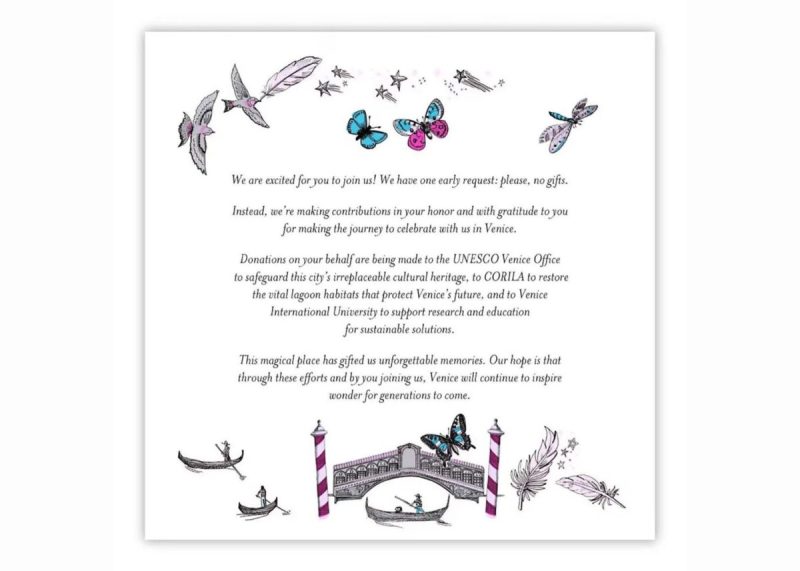Lo ha fatto con una direttiva che l’Italia deve recepire entro il 2026. L'obiettivo è una maggiore trasparenza e, soprattutto, contribuire alla diminuzione del gap salariale tra uomini e donne.
All’epoca di questa intervista Francesco Costa ha 40 anni, mancano meno di due mesi alle elezioni americane del 2024, Kamala Harris è da poche settimane la candidata alla presidenza degli Stati Uniti del Partito democratico, Israele sta invadendo via terra la Cisgiordania, il ministro della cultura Sangiuliano si è dimesso dopo il cosiddetto “caso Boccia”. Lo dico per contestualizzare, perché se capiterà di rileggerla tra qualche anno, Francesco Costa avrà probabilmente fatto ancora altre cose ancora oltre alle molte che già fa. Cioè: un podcast che si chiama Morning, una newsletter che si chiama Da Costa a Costa, un canale YouTube che si chiama, anche questo, Da Costa a Costa, tre libri per Mondadori, una serie di spettacoli teatrali, qualche programma in tv. Piace a moltissimi (oltre 160mila iscritti su YouTube, più di 340mila follower su Instagram), ha un “following” di lettrici, lettori, ascoltatrici e ascoltatori fedelissimi, al limite della venerazione. È un raro caso di giornalista famoso quasi tanto quanto la testata per cui lavora (come vicedirettore), Il Post. Una one-man-band giornalistica con pochi paragoni in Italia, che parla soprattutto di una cosa: l’America. La sua biografia su Twitter dice: «Mi occupo di cose americane», su YouTube: «Racconto e spiego gli Stati Uniti in Italia», su Instagram: «When in trouble, go big». A settembre del 2022, il New Yorker gli ha dedicato un ritratto, il titolo era «The Man Who Explains Italy». Mi pare che una volta avesse una bio tipo: «Spiego l’America agli italiani». Una volta, nel 2011 o giù di lì, sul suo blog c’era anche una mappa delle sue hamburgerie preferite, mi sa che oggi non c’è più, ma il panino è rimasto l’icona del suo sito.
ⓢ A un certo punto eri un giornalista con un blog sull’America, adesso sei un media multipiattaforma. Avevi qualcosa in più rispetto alla concorrenza?
A me sembrava che ci fosse nel racconto degli Stati Uniti un deficit, un gap generazionale, che mi sono trovato a colmare non col talento – che poi magari è servito in altre cose – ma proprio col mio avere trent’anni. Anche per la familiarità con certi linguaggi. Ho aperto un blog nel 2003, la prima cosa che ho fatto online. Lavoro al Post da quando esiste. Ho aperto la newsletter nel 2015, il podcast nel 2016, molto prima che diventassero di moda, intercettando una cosa che stava succedendo negli Stati Uniti. Quando è uscito California, nel 2022, è andato molto bene, e alla fine dell’anno il Corriere ha pubblicato una classifica dei 20 libri più venduti in Italia nella saggistica. C’era California quattordicesimo: per me era una grande soddisfazione. Però poi ho guardato i nomi degli altri, ed ero l’unico autore under 45. Questo non vuol dire che io sia l’unico bravo under 45. Però vuol dire che porto una cosa che nel mercato non c’è o non trova spazio.
ⓢ Andando avanti negli anni hai deciso di fare anche contenuti, diciamo, da content creator: come trovi un equilibrio tra il giornalismo, che poi è quello molto della competenza su cui si basa Il Post, e una divulgazione più leggera?
Secondo me queste definizioni non hanno molto senso. A volte le utilizzo, perché è più facile spiegare alle persone che cosa voglio provare a fare o cosa sto facendo. Però il giornalista è sempre stato un content creator, se pensi alla letteralità dell’espressione. E anche un divulgatore: ha raccolto delle informazioni e le racconta in un modo che sia efficace. Nei libri e nella newsletter continuo a raccontare le cosiddette hard news: l’immigrazione, l’industria, la droga, le armi, le elezioni, cosa succede nel Paese. Però io non credo di fare delle cose meno giornalistiche su YouTube, anche quando faccio il video in cui ti racconto i piatti tipici di Chicago. Anche se parlo di football, di cose molto pop, è chiaro che non sono un giornalista sportivo: non ti racconto delle cose che non sai sul gioco, sulle squadre, però è un tentativo di utilizzare quell’elemento, il panino, la pizza, la squadra di football per raccontarti un pezzetto della cultura di questo posto.
ⓢ Il New Yorker scrive, nel tuo ritratto del 2022: un giornalista che ha modernizzato un gran numero di «stodgy institutions».
Magari, modernizzare le stodgy institutions. Ma più per colpa loro che per merito mio. Il solo fatto di non fare le cose peggiori o di provare a parlare a un pubblico più giovane ti rende automaticamente questo grande innovatore. Ma io non faccio niente che non si faccia normalmente in America. Non ho avuto nessuna idea geniale. Le newsletter, i podcast, i video: non è che me li sono inventati io. Lo stesso vale per il modo in cui cerco di interpretare il mio ruolo dentro Morning. Quindi è molto per opposizione.
ⓢ Dici sempre che questi americani sono diversissimi da noi.
Ci sono popoli con cui condividiamo una cultura molto più vicina, soprattutto quelli mediterranei. Gli americani davanti a certe cose si comportano in dei modi che per noi sono inspiegabili. Una cosa l’avevo messa su Instagram perché mi faceva ridere. Ho fatto questo viaggio in agosto da cui sono tornato per la prima volta con un’idea: il prossimo libro lo faccio contro gli americani, non mi sono mai stati così tanto sul cazzo. Io posso anche essere sedotto da certi loro modi di essere efficienti, ma poi la mia cultura è un’altra. E quindi: è il giorno del disastro informatico di luglio, aerei a terra in tutto il mondo, voli cancellati. Saliamo su questo aereo dopo cinque ore in coda, tutti stanchi morti. L’aereo non parte perché una cappelliera non si chiude. La gente è disperata. Bisogna chiamare la squadra speciale. Arrivano questi, dopo un quarto d’ora, in quattro, enormi, con una cassetta degli attrezzi. Uno dà un pugno alla cappelliera – boom – e si chiude. Tutti applaudono. Lì ho pensato: noi italiani avremmo messo lo scotch, e poi all’arrivo se ne parla. Questa roba qui però, se io non provo a spiegartela, secondo me ti perdi anche un pezzo del perché poi in una certa città votano per Trump o del perché non gli piace l’idea di cambiare i fornelli di casa per mettere quelli più ecologici.
ⓢ Perché secondo te c’è così tanta gente interessata all’America e alle cose dell’America?
Non so, tu diresti che sia così tanta? A me invece a volte viene da farmi la domanda opposta: perché così poca gente si interessa di Stati Uniti, ma non voglio discutere qua delle dimensioni del mio pubblico o delle dimensioni del pubblico che segue l’America in generale. Dovunque mi giri a me sembra di vedere fenomeni sociali, culturali, economici, prodotti, mode, trend, parole, e se cerco da dove arrivano, sollevi un filo sotto la sabbia, mi sembra che portino tutti o quasi negli Stati Uniti. Il film che guarderò stasera, il telefono con cui ti mando i messaggi, il servizio con cui te lo sto inviando, i meme che facciamo sulla politica italiana… Può darsi che io sia il famoso martello del proverbio, che in quanto martello vede chiodi dappertutto, ma mi sembra che capiamo e conosciamo ancora troppo poco dell’America in relazione a questa impronta gigantesca che ha sulle nostre vite spesso con nostra inconsapevolezza.
ⓢ In Frontiera spieghi perché il declino americano secondo te non è davvero una cosa. Ma allora, secondo te, cosa ha creato in questi ultimi anni – anche qui, direi post 2020 – questa sensazione diffusa di fine impero a cui hai sentito il bisogno di rispondere con il libro? Forse c’è sete, una sete ancora “da bolla”, di specificità culturali che non derivino da questo secolo di dominio culturale americano, che è effettivamente ancora presente come lo descrivi adesso?
Se vuoi c’è di partenza il fatto che siamo un Paese molto anti-americano. Storicamente, per ragioni che hanno a che fare con la storia del ‘900, ma anche culturalmente siamo molto diversi da loro, nel rapporto che abbiamo con il rischio, con i soldi, con lo Stato, con gli altri, con la società: ci capiamo poco. Poi, più in generale, quel declino lì effettivamente c’è stato: dall’11 settembre, la crisi economica del 2008 con le sue conseguenze lunghissime, la vittoria di Trump e la crisi delle istituzioni, il fallimento delle guerre in Iraq e Afghanistan, la contestazione globale al capitalismo. Il declino americano c’è stato. Il punto è che noi pensiamo sempre di essere all’85° minuto della partita: in cui stiamo vivendo i momenti decisivi e scoprendo chi ha vinto tutto. Ma non è così: quel declino secondo me ha cominciato a finire già negli ultimi anni di Obama, e per certi versi anche gli anni di Trump hanno confermato che era iniziata un’altra era. Dopo la pandemia, i grafici che mostravano l’inesorabile sorpasso del Pil cinese non lo mostravano più. È cominciata una fase differente.
ⓢ Quanto ci avete messo, al Post, a trovare l’equilibrio tra il brand della testata e il tuo personal brand che a un certo punto è diventato importante, forse ingombrante?
Non ci abbiamo messo troppo, non l’abbiamo mai vissuto come un problema. E questo in prima istanza per l’intelligenza di Luca Sofri, che non solo non ha mai pensato che questa mia attività potesse entrare in competizione col Post, ma anzi, che la costruzione di un mio profilo pubblico più grande potesse aiutare il Post. Poi ho messo in chiaro da subito col Post che per me questa cosa non era un trampolino verso una carriera fuori dal giornale. Anche perché poi il Post ha fatto una serie di cose anche utilizzando il mio lavoro come una specie di percorso-beta: le newsletter le ha fatte dopo la mia newsletter, il podcast anche. Le raccolte fondi del mio blog sono una sorta di prequel dell’abbonamento. Ma non perché io sia stato un pioniere: perché per me era più facile prendermi dei rischi, fare degli esperimenti.
ⓢ Tu ti senti più quello di Morning o quello dell’America?
Io ho questa tendenza a sentirmi sempre dove non dovrei essere: quando lavoro alle mie cose e sono in giro per il teatro, una parte di me mi dice “dovresti essere in redazione”. E quando sono in redazione una parte di me mi dice “c’è la campagna elettorale in America e tu sei qua a fare delle robe che potrebbe fare qualcun altro”. A me Morning è servito soprattutto per dimostrare a me stesso, ma anche al Post e al mondo, che potessi fare anche delle cose non americane a un livello di qualità soddisfacente, che avessero un posto sul mercato. Per il resto Morning per me è un’attività che è sano se nella mia giornata e nella mia testa dura dalle cinque alle otto del mattino e basta, perché ti fagocita facilmente. Quindi la scissione è questa: appena pubblico Morning comincia la mia giornata e sono molto più americano.
ⓢ A un certo punto tu avevi una voce molto letta e considerata sulla politica italiana. L’hai lasciata da parte?
Se vuoi, ogni giorno parlo di politica italiana dentro Morning. Secondo me ho cambiato soltanto il luogo. A un certo punto ho perso fiducia nei social come luogo nei quali ha senso discutere, e forse anche scrivere e parlare. Mi sembra che non siano stati disegnati a questo scopo, e provare a usarli così è come fare la pasta ma invece di cuocere l’acqua nella pentola metterla nel casco da motocicletta: forse se togli la fodera e l’imbottitura si riesce, ma il casco non serve a quello, e la pasta verrà uno schifo. Allora il podcast è un modo per darmi la possibilità di parlare di politica italiana, anche con delle opinioni, però per cinque minuti e basta. E se tu vuoi dissentire, vuoi dire la tua, va benissimo: però devi scrivermi una mail. E la leggo soltanto io. Quindi è inutile che scrivi cose solo allo scopo di esibirti. Poi, figurati, mi insultano anche via mail. Però quell’attrito alza la qualità della discussione.
ⓢ E tu invece come hai accettato il metterci la faccia così tanto, e quali sono le controindicazioni?
In parte c’era sicuramente l’ambizione di provare a vedere se questa cosa mi riusciva. Quindi quando è arrivata l’ho vista come una cosa che avevo cercato e avevo ottenuto. Sul piano ideale il nostro lavoro ha un impatto se ha un pubblico. Più grande è il pubblico, più grande è l’impatto e viceversa. E in parte c’è anche la vanità del dire: ho scritto un libro, è andato bene, facciamone un altro. A un certo punto mi sono chiesto che cosa avrei dovuto mettere sui social. Adesso che non mi seguono più soltanto i miei amici, cosa devo fare?
ⓢ A un certo punto hai realizzato: sono un giornalista famoso.
C’è stato il 2020: quando siamo tornati a uscire di casa post-pandemia, io ho avuto la percezione che qualcosa era cambiato, nel senso che uscivo di casa a Milano e qualcuno mi riconosceva. Questa cosa prima non capitava, o capitava raramente. Poi sono arrivati il libro, il lockdown che ci ha attaccato agli schermi, tutti quei contenuti consumati. Io avevo le elezioni americane, il caso George Floyd ha fatto sì che passassi da 40mila follower a 180mila in una settimana. Lì ho cominciato a vedere le controindicazioni di questa cosa. Per cui da allora io vivo la parte di ambizione personale, di ricerca di un pubblico più ampio, come forse vive il tossico che si inietta la droga, e sta molto bene e però sa che si sta facendo del male. Perché più il mio libro va bene, più il mio libro vende, più i miei video sono visti, più Morning viene ascoltato, più io so che perdo un pezzetto di anonimato che non ho più indietro, ed è una cosa che negli ultimi anni comincio a soffrire. Senza che io sia Pippo Baudo.
Il nuovo numero si chiama “C’era una volta l’America”: compralo in edicola oppure sul nostro store, cliccando direttamente qui!