Spesso finiscono agli arresti per incitazione al vizio: è successo già cinque volte negli ultimi due anni, l'ultima all'italiana Linda Martino.
Stando alla filantropia geek degli Altruisti Efficaci, chiudere gli allevamenti intensivi è uno dei tre obiettivi che dovremmo priorizzare se vogliamo salvare il pianeta (gli altri due sono eliminare la povertà estrema e minimizzare il rischio di eventi globali catastrofici). La chiusura degli allevamenti intensivi ci consentirebbe infatti di abbattere radicalmente le emissioni di CO2 nell’ambiente, di sbarazzarci di carne che è spesso carica di antibiotici o batteri e di risparmiare la vita ai 56 miliardi di animali che ammazziamo annualmente a fini alimentari. C’è un problema: per quanto il veganismo stia diventando mainstream, si stima che il consumo di carne a livello mondiale raddoppierà entro il 2050 (come segnala la Fao), anche per via di paesi estremamente popolosi come l’India e la Cina che consumano sempre più proteine animali. Sulla carta, la soluzione a questo dilemma è semplice: dobbiamo trovare modi per produrre carne che prescindano dagli allevamenti intensivi.
Per fare questo, due sono i metodi al momento più promettenti: coltivare carne in laboratorio, a partire da cellule muscolari estratte da animali vivi (e che rimangono vivi e vegeti) o produrre finta carne utilizzando vegetali. Ma scordatevi i tristissimi hamburger di soia che occupano ormai da decenni le sezioni più recondite dei supermercati: con “carne vegetale”, si intendono oggi hamburger che sanguinano e che al palato sono indistinguibili da un hamburger proveniente da un animale in carne ed ossa. Questo sforzo titanico di creare la carne del futuro presenta evidenti sfide tecnologiche, economiche (coltivare carne in laboratorio costa ancora un sacco di soldi), politiche (come regolamentare la vendita di queste carni alternative?) ma anche lessicali: come chiamare queste carni che risultano indistinguibili al palato o, nel caso di quella coltivata in laboratorio, anche all’analisi biochimica, da quelle provenienti dal macello di animali?
Distinguerle è invece ovviamente importante. Mentre i bovari lavorano sodo per vietare l’uso della parola “carne”, le aziende di carni alternative (che, si badi bene, non sono uno sparuto manipolo di estremisti ambientalisti, ma spesso organizzazioni fiorenti, cospicuamente innaffiate di denaro da capitali finanziari) pensano a quale aggettivo far seguire (o, in inglese, precedere) alla parola “carne”. Nel caso di quella prodotta a partire da piante, la questione è pressoché risolta. In inglese, l’uso dell’espressione “plant-based meat” è oramai consolidato ed anche in italiano la sua traduzione “carne vegetale” non sarà equalmente cool ma non suona comunque poi così male. Diverso è il caso della carne prodotta in laboratorio. I media anglofoni alternano ancora diversi termini, tra cui i più comuni sono “lab-grown”, “in-vitro”, “cultured” e “clean”, ovverosia “pulita”, l’espressione spesso caldeggiata anche dalle aziende che vogliono produrla, in un evidente tentativo di assonanza concettuale con la “clean energy”, l’energia pulita. Ma quello che funziona in inglese non funziona necessariamente anche in italiano e “carne pulita” non si può proprio sentire, figurarsi mangiare.
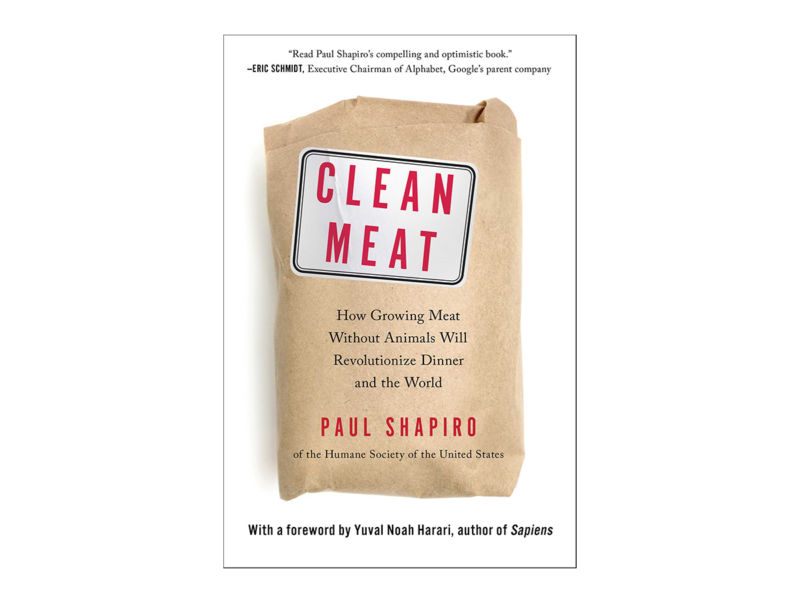
“Clean Meat: How Growing Meat Without Animals Will Revolutionize Dinner and the World ” di Paul Shapiro, introduzione di Yuval Noah Harari
Una buona opzione potrebbe forse essere “carne coltivata”, sobria al punto giusto, ma che è allo stesso tempo adita a fraintendimenti, dato che, in italiano, si coltivano anche le verdure. E la carne coltivata potrebbe essere quindi confusa con quella vegetale. L’alternativa più divertente è anche la più dadaista di tutte, dal sapore retrò se non proprio steampunk, e cioè “carne churchilliana”. In un relativamente celebre passaggio di un suo saggio del 1931, il Premio Nobel per la Letteratura (sì, Churchill) profetizzava infatti che, nel giro di cinquant’anni, l’umanità avrebbe trovato un modo di evitare l’assurdità di crescere un pollo intero per poi mangiarne solo il petto o le cosce. Ottant’anni dopo, l’ottimistica profezia di Churchill non si è ancora avverata, ma potremmo esserci finalmente vicini. Quella sul nome potrà sembrare una discussione inutile, ma in realtà è cruciale per almeno due ordini di ragioni. Il primo è puramente commerciale. Come ci ricorda The Good Food Institute, prestigiosa associazione no-profit Americana che fa lobby per le carni alternative, nessuno si voleva mangiare il Nototenide della Patagonia fino a quando Lee Lantz, un commerciante di pesce all’ingrosso, decise di iniziare a smerciarlo come “branzino cileno” facendolo diventare uno dei pesci più hip nei ristoranti di mezza America. Insomma, dal punto di vista del marketing, i nomi sono, ovviamente, importanti.
Il secondo motivo, sicuramente più astratto ma nondimeno sostanziale, tira in ballo questioni filosofiche sulla, beh, metafisica dell’identità. Si pensi, ad esempio, al paradosso della nave di Teseo. Il paradosso narra che la nave del mitico eroe greco Teseo si fosse conservata intatta negli anni, e che le sue parti fossero state sostituite mano a mano che si deterioravano fino a che non rimase neanche un pezzo della sua struttura originale.Ora, si chiede il paradosso, è quella che si è conservata la nave di Teseo oppure no? In altre parole, se una cosa cambia sostanza ma non forma è ancora la stessa cosa? Insomma, possiamo chiamarla carne se la forma è quella ma la sostanza no? Il discorso è leggermente diverso nel caso della carne coltivata in laboratorio poiché lì la sostanza è, perlomeno biochimicamente, identica a quella della carne tradizionalmente intesa, seppure il metodo per ottenerla sia completamente diverso. Una simile distinzione, tra l’altro, è anche teologicamente determinante nello stabilire se il bacon coltivato in laboratorio sia kosher oppure no.
Teseo, però, ci può aiutare fino ad un certo punto a dipanare questi dilemmi. In fondo, lui era un coetaneo di Icaro, quel tale che si schiantò al suolo nel tentativo di superare i limiti imposti all’uomo dalle divinità. All’opposto, la nostra è l’epoca dell’Homo Deus descritto da Yuval Noah Harari nel suo omonimo bestseller (pubblicato in Italia da Bompiani), un uomo che si libra al di sopra della sua condizione mortale grazie alla tecnologia, diventando dio. E non è certo un caso che proprio Harari abbia firmato la prefazione all’edizione inglese di Clean Meat, una delle poche monografie in circolazione dedicate esclusivamente al tema della carne coltivata. Il suo Homo Deus è anche l’uomo della carne coltivata e della carne vegetale, l’uomo che si reinventa la Creazione, riuscendo a produrre carne senza aver bisogno di animali. A pensarci bene, rimanere per un momento senza parole è del tutto comprensibile.







