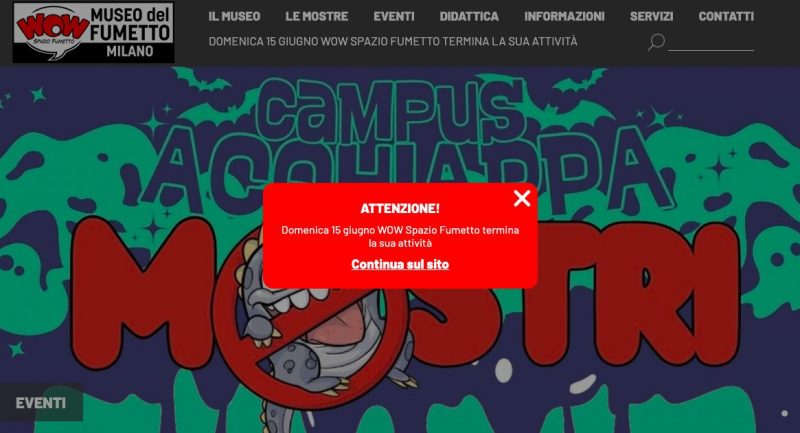La cospirazione delle colombe, di Vincenzo Latronico, immaginava gentrificazioni e scandali immobiliari milanesi nel 2011. Un'intervista su com'era Milano allora e come è cambiata oggi.
Sarà l’acustica che, grazie alla volta di legno, è una delle migliori d’Europa. O il Natale e tutti quei film ambientati in posti simili alla Scala ma sbiaditi – qui quell’atmosfera diventa a colori, saturata a livelli estremi, dà alla testa. Forse l’aria che con il buio della sala diventa profumata, di borotalco e incenso, come in un processo alchemico. Sarà che i fiori che la addobbano dagli anni Sessanta sono cresciuti di qualche migliaio, come le acconciature. Così la Scala distorce le percezioni di chi ci entra, anche di quelli più resistenti. È una specie di Lsd legale. Qualsiasi sia il periodo storico – le donne che durante l’intervallo ti stordiscono, le chiacchiere fitte di nulla, il panettone, l’albero griffato D&G – la Scala ha l’antidoto. Livella tutto. Neutralizza. Gli specchi assorbono la mondanità, le facce truccate, le espressioni buffe, anche le fotocamere degli iPhone.
- Un’ospite della Prima Alla Scala, il 7 dicembre 2018, in abito Dolce & Gabbana (Pietro D’Aprano/Getty Images)
- Tre ospiti si scattano un selfie davanti all’albero di Natale in attesa di assistere a L’Attila di Verdi (Pietro D’Aprano/Getty Images)
Appena si spengono le luci si è tutti presi da una strana frenesia che, pure se non capisci ogni parola, non ti va di leggere o Attila arriva in motocicletta, sei comunque catturato da un altro tempo. Il buffet nel foyer resta imbandito, come se nessuno avesse preso niente – fichi d’India, mandorle dorate, panettone nei vassoi d’argento. Tartine minuscole con sopra chissà cosa. Tutto resta intatto, nonostante le mani e le bocche piene. Ci dev’essere qualcuno sotto, un aiutante magico, che appena uno spettatore addenta qualcosa la rimette subito al suo posto. Un cosmo perfetto: solo qui se chiedi un bicchiere d’acqua te la versano in un calice più bello di quello usato dai bevitori di champagne.
La potenza della Scala è talmente oscurante che anche i tamarri non riescono ad essere veri tamarri, ci provano ma non ci riescono. La bionda piena di botox ha un colore fatto troppo bene per dire «guarda che fantastica tamarra», i suoi capelli sotto al lampadario della Scala sembrano di un biondo aristocratico. Ti cambia i connotati, il dna, per almeno tre ore. Il dna della Scala si mischia al tuo – è sangue milanese, austero, gonfio d’orgoglio. Roma. Si sente spesso “Roma” nell’Attila di Verdi ma anche la patria da difendere dai barbari sbiadisce, diventa solo una contingenza. Dopo i 6 ma anche 10 minuti di applausi a Mattarella un signore distinto fa: «Chissà se a Roma lo capiranno». Forse no.

Sull’abito di Dolce & Gabbana le locandine di La bella addordmentata nel bosco (Photo by Miguel Medina/Afp/Getty Images)
Ma anche i romani qui, per tre ore, s’ingentiliscono. L’unico a non ingentilirsi è Ildar Abdrazakov, Attila, il barbaro che muore ma vince – per carisma, espressioni, colore della voce: nero. Toni bassi che toccano la pancia. La sua voce è ovatta che assorbe i toni alti, quelli moralistici e tondi. Una voce scheggiata che rende giustizia alla devastazione – alle rovine, al tempo brutto, a tutto ciò che è scuro. Tutti gridano «Bravo! Bravo!» nel bel mezzo dell’atto e un signore tedesco scuote la testa. Scuote la testa anche se parte l’applauso quando non dovrebbe, quando sembra che sia terminata la scena perché c’è una pausa (altrimenti morirebbero soffocati dalla loro stessa voce) invece si sta ancora svolgendo. La scena ha solo bisogno di silenzio, anche questo fa parte della magia, razza di buzzurri! Tenetevi per voi le vostre patetiche emozioni. Questo dice il tedesco fra sé e sé.
- Giuseppe Sala e la compagna Chiara Bazoli (Pietro D’Aprano/Getty Images)
- Un’ospite in Dolce & Gabbana (Pietro D’Aprano/Getty Images)
Un signore anziano con il fiore all’occhiello parla della scenografia di Livermore definendola troppo poco tradizionale: un Novecento distopico fra Prima e Seconda guerra mondiale, richiami al Neorealismo e un tuffo in un locale anni Quaranta con ballerine e piume d’oca – è qui che Odabella indossa l’abito migliore: verde brillante su chioma rossa, ma davvero brillante (che uno potrebbe chiedersi, è fatto di brillanti?). Gira come se fosse su un carillon. Al contrario degli uomini, tutti rigorosamente in smoking – le uniche differenze che si possono trovare stanno nel colore del papillon – le donne sono uno spettacolo nello spettacolo. Dei lampadari loro stesse, fantastici. Ingioiellate, con cappelli che uno non riuscirebbe nemmeno a pensare, idee contorte, apparizioni. Mamma e figlia vestite da conigliette, cappello con veletta e due fili neri che disegnano le orecchie, lentiggini disegnate, copricapi con more e banane, schiene nude (tante), tette (tante tante), scarpe aperte altissime nonostante la pioggia (piedi bagnati, piedi scalzi, piedi rotti), giri di perle – molte sosia del dipinto di Maria Callas appeso su una delle pareti broccate, un abito lunghissimo con attaccate vecchie locandine della bella addormentata nel bosco.

Carla Fracci (Pietro D’Aprano/Getty Images)
Ci sono periodi che si alternano negli anni – esibizione, pelle, colori esuberanti vs discrezione, less is more. Oggi siamo nel primo, niente a che vedere con l’India misteriosa della Contessa Dompè, quando l’eleganza era nascondere il proprio corpo sotto tessuti complessi, broccati, maschere. Ma era anche scappare dai paparazzi, mettere la mano davanti alla faccia quando qualcuno si azzardava a fotografarti. Qui tutte vogliono una foto. Le chiedono ai giornali locali, ai nazionali, ai blogger, a chiunque. Una, due, tre che ero messa male. Taggami. E, come se la Scala non bastasse. Metti un bel filtro. Grazie.

I movimenti che vogliono rovinare il matrimonio di mr. Amazon non ce l'hanno solo, né tanto, con lui: il problema è ciò che Bezos rappresenta e il fatto che abbia deciso di venire a rappresentarlo proprio a Venezia.