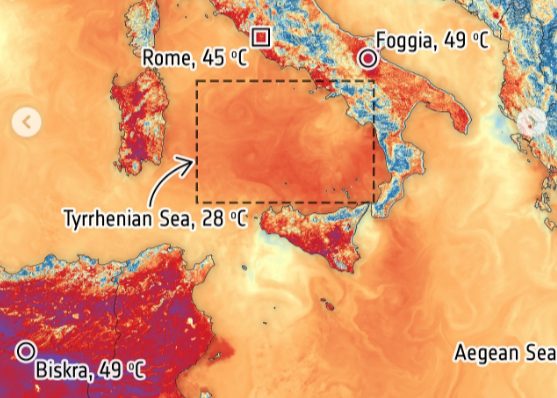Benvenuti nella prima ondata di calore dell'estate. Ma si soffre anche per la morte di Michael Madsen e per le strampalate dichiarazioni del ministro Tajani.
Qualche mese fa sono tornato a Casertavecchia, cioè il borgo medievale frazione della città in cui sono cresciuto, Caserta, e ho visto un ristorante che si faceva pubblicità con un cartello per turisti che recitava pressappoco così “entra ad assaggiare la nostra PAPOSCIA, il piatto tipico di Caserta”. Ho continuato a camminare e ho trovato un nuovo ristorante con una reclame analoga della “paposcia”. Qualche altro metro ancora e – si sarà già capito – il terzo ristorante con la terza scritta, stavolta su una lavagna, sulla “paposcia”. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che, in quarant’anni, non avevo non solo mai letto, ma neanche mai assaggiato, né proprio mai sentito parlare nessuno di questa tipica e, per me da subito fantomatica, “paposcia”. Ho cominciato allora a domandare ad amici e parenti e giuro che nessuno aveva mai sentito che la “paposcia” potesse essere un piatto da cucina. Per tutti la paposcia era la pantofola oppure, per la maggioranza, l’ernia altresì detta in dialetto la “uallera” (nelle tombole napoletane il 40 è proprio la paposcia). Finché qualcuno non mi ha detto che nei ristoranti, la paposcia è una specie di saltimbocca o bruschettona o pizza lunga (ho poi scoperto che nel Gargano esiste un piatto chiamato paposcia ed è una sorta di focaccia) condita in vari modi. E, soprattutto, che sì, se la sono inventata.
Questa buffa e affascinante invenzione di tipicità risponde sicuramente a delle poco raffinate esigenze turistiche contro cui ingenuamente potremmo pensare che tutti abbiano ormai sviluppato gli anticorpi e, invece, evidentemente no. Ma ha, prendendo a prestito un concetto dallo studio della Storia, una curiosa funzione di etnogenesi. Mi spiego meglio: in Storia si intende ormai con “etnogenesi” il processo per cui una comunità sviluppa un’identità (attorno a lingua, usi, religione e via dicendo) e intorno a quella comincia a definirsi come gruppo etnico. È un processo molto serio, ma qui possiamo prenderlo in prestito anche per vicende locali di puro campanilismo. Questo perché Caserta ha una storia tutto sommato recente e non esiste se non in relazione a Napoli. Tuttavia non è abbastanza Napoli per essere considerata Napoli, ma – per fare un esempio – non è neanche antica come Monza per distinguersi realmente da Milano. Vive e si percepisce in questo limbo, per cui da un lato vorrebbe essere considerata parte di una conurbazione e dall’altra vorrebbe avere storia a sé.
Ma visto che, oramai, in Italia nulla è serio come il cibo, anche l’etnogenesi locale può girare solo attorno alla gastronomia e, quindi, l’altra grande punta di orgoglio dei casertani è la pizza. Da qualche anno a questa parte ogni classifica delle migliori pizzerie d’Italia o, addirittura, del mondo (sento già gli indignati della cucina italiana strepitare perché, a loro dire, le due classifiche dovrebbero coincidere) porta ai primi posti delle pizzerie casertane. La classifica “50 Top Pizza 2023” ha tre pizzerie casertane nei primi 10 posti, per il Gambero Rosso sono due tra i primi quattro e nessuna napoletana, per “The Best Chef Award” il migliore chef nella categoria pizza è casertano, nella serie di documentari di Netflix Chef’s Table: Pizza solo due episodi su sette sono in Italia, uno a Roma e l’altro in provincia di Caserta, a Caiazzo, da Pepe in Grani. Come ha riassunto perfettamente Dissapore qualche anno fa: «Il problema che ha Napoli con la pizza si chiama Caserta».
Ma anche sul fronte vip le cose sono molto cambiate. Fino a qualche anno fa non c’era pizzeria di Napoli che non avesse la sua foto con famosi vari e praticamente tutte una con Maradona (a giudicare dalle foto in giro pare che Bill Clinton abbia mangiato dieci pizze a portafoglio nei due giorni in cui è rimasto a Napoli per il G7 nel 1994. Ma quella visita per i locali si ammantò fin da subito di leggenda anche per altre ragioni. Ricordo ancora un’amica napoletana di mia madre dire commossa che aveva letto su una qualche rivista che forse Hillary Clinton era rimasta incinta di un nuovo bambino proprio in occasione del G7 di Napoli – galeotte erano state le bellezze locali – e quella cosa, a dire dell’amica di mia madre, avrebbe dovuto inorgoglirci). Mentre a Caserta i pizzaioli avevano tuttalpiù una foto con i giocatori della squadra di basket. E se ancora in occasione di Mangia, prega, ama Julia Roberts va a mangiare la pizza all’Antica Pizzeria da Michele, oggi la pizza napoletana è attrattiva per la vecchia Hollywood, vedi De Niro ancora quest’estate da Michele, ma i nuovi divi si fanno fotografare da Pepe in Grani o come Leonardo Di Caprio, sempre questa estate, da I Masanielli a Caserta (anche se, forse, con DiCaprio c’entrano anche le sue mitiche origini casertane, pare legate a Trentola Ducenta).
Per quelli della mia generazione per cui andare a mangiare una pizza la sera equivaleva a trovare il primo tavolo disponibile, perché sedersi subito era più importante che ragionare sulle farine, sui lieviti e sulla differenza tra “pizza a ruota di carro” e “pizza canotto” (una sfumatura – e qui sento già i puristi che urlano “altro che sfumatura” – quindi diciamo “un discrimine” che non avrei mai voluto apprendere, ma che riferisco avendone sentito parlare centinaia di volte) il cambiamento è stato repentino e, a tratti, neanche spiegabile. Perché è come se improvvisamente le stesse smorfie una volta solo appannaggio degli esperti di vino fossero diventate fondamentali anche per mangiarsi una pizza. Allo stesso tempo scrivere di Pepe in Grani di Franco Pepe o di Cambia-menti di Ciccio Vitiello mi fa venire voglia di mettermi sul primo Frecciarossa e arrivare a fare la coda per sedermi a pranzo. E non capisco come resistere senza precipitarmi lì.