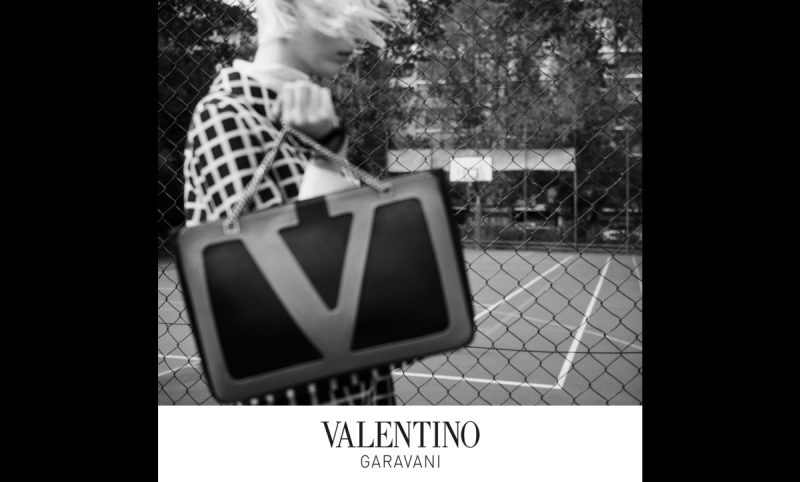L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.
Abbiamo passato almeno due anni a chiederci come sarebbe stata la nostra vita dopo la pandemia. Come sarebbero cambiate le nostre abitudini quotidiane, il lavoro, la politica, la prossemica, la socialità, il sesso. Abbiamo fatto previsioni e buoni propositi. E adesso siamo qui, dopo quasi quattro anni, in un mondo in cui forse è cambiato tutto e forse non è cambiato niente, e non abbiamo niente da metterci. “8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire” è uno dei primi slogan sindacali di metà Ottocento, con cui si cercava con slancio positivista di dare un’organizzazione scientifica alla vita delle persone, rivendicando una tripartizione (dalla Rivoluzione francese al Sessantotto dividere le cose in tre è stata una bizzarra ossessione di filosofi e intellettuali, qualcuno sa il perché?) perfetta, e al tempo stesso futuristica, delle attività umane. Più di centocinquanta anni dopo, la stragrande maggioranza di noi ancora vive secondo questa regola. E ora più ora meno nessuno sembra prendere veramente sul serio l’idea di scardinare una consuetudine, che, osservata laicamente, non ha più alcun fondamento reale. Siamo passati dal telegrafo a Zoom, ma continuiamo a lavorare dalle nove alle diciotto. Il modo in cui lavoriamo, invece, è cambiato. I lavori che facciamo, anche. La meccanica, la catena di montaggio, l’automazione, la tecnologia, l’informatica, l’intelligenza artificiale. È difficile individuare un momento in cui le cose non sono state più come prima, perché si è trattato di un processo più di sgretolamento che di crollo, ma fino a non troppo tempo fa, l’abbigliamento ha definito sia la suddetta tripartizione per ragioni sociali, funzionali e culturali, che l’appartenenza di classe.
Nel Quarto Stato, di Giuseppe Pelizza da Volpedo, sappiamo che le tre figure in primo piano che guidano la grande manifestazione sono proletari e non borghesi dal modo in cui sono vestiti. Gli uomini in abito scuro e bombetta che popolano i quadri di Magritte, la cui faccia spesso coperta da oggetti produce una sottile inquietudine nell’osservatore, rappresentano invece attraverso gli abiti il grado zero del conformismo borghese dell’epoca in cui l’autore era bambino e poi giovane uomo. Quella che indossano è una divisa da avvocato o da agente di borsa, la stessa divisa che diventa comica se indossata da Charlot, vagabondo farsesco e lunare. Ma ancora negli anni Cinquanta, basta leggere Il Talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith per averne prova, il tempo del lavoro, quello dello svago e quello del sonno prevedevano scelte vestimentarie codificate e precise. Anche (soprattutto?) per uno come Tom Ripley, giramondo senza un soldo e sociopatico che un lavoro vero nemmeno ce l’ha. Un inquietante flâneur che cerca di insinuarsi nell’alta società grazie a ingegno e intrighi e, come nel libro viene sottolineato con abbondanza di dettagli anticipando le ossessioni di Patrick Bateman in American Psycho, proprio attraverso i vestiti usati come divise per vendersi da pari, per rassicurare, per appartenere. Questo doppio livello di codifica resiste fino agli anni Ottanta, il decennio in cui la moda, immersa nel postmoderno, comincia a rimasticare il passato, a mescolarlo e a riassemblarlo in quella semiosi infinita che ancora o forse più che mai oggi ci perseguita. È da lì che lentamente ma inesorabilmente le destinazioni d’uso degli abiti cominciano a sgretolarsi e che il casual inizia ad infiltrarsi in ogni dove, conquistando posizioni su posizioni, fino alla discussione di solo qualche settimana relativa al dress code del Senato statunitense. Curiosamente però prende forza una tendenza, una tensione uguale e contraria, che riguarda il workwear, e cioè l’abbigliamento da lavoro. Quello dei colletti blu, del lavoro manuale, in opposizione ai colletti bianchi impiegatizi che invece venivano esasperati e incensati nella decadenza del power dressing.
C’è un qualcosa di paradossale ma anche di poetico nel fenomeno per cui all’accelerare della smaterializzazione del lavoro manuale è aumentata la presenza nella moda e nelle cosiddette classi agiate di abiti da lavoro slegati o forse liberati dalla loro funzione originaria. Paradossale perché il rapporto tra la moda come sistema per cui l’esclusività è parte essenziale della desiderabilità, e l’intento sovversivo rispetto al canone della moda stessa, ha sempre prodotto cortocircuiti e critiche anche sensate di appropriazione indebita. L’incongruenza tra celebrazione del lavoro e della classe operaia di designer fondamentali come Martin Margiela, che metteva in campo anche un cambio di prospettiva rispetto al lusso, con le sue sfilate fuori dai quartieri che la moda aveva sempre bazzicato, oppure di Miuccia Prada, che intellettualizzava il rigore penitenziale di grembiuli o gonne da portinaia o da bidella, con il prezzo a cui poi quei capi venivano venduti, non poteva non provocare un sano e sbalordito fastidio. Eppure mai come in quel periodo e fino alla presa del potere dei grandi gruppi del lusso, intorno alla fine degli anni Novanta, il potere delle narrazioni, all’interno della minoranza che quella moda se la poteva comprare ma anche di chi la poteva apprezzare sulle riviste, ha avuto una rilevanza tale capace di sovrastare il potere del marchio. Mai come in quel periodo la moda si è trasformata da consumo vistoso a scelta culturalmente posizionale. Che si trattasse, e per quanti?, di costruzione di pensiero o di trend è difficile misurarlo, ma certo la scelta di quei capi e di quei marchi necessitava di essere capita per essere apprezzata. Può sembrarci naïf oggi, ma vestirsi con le divise laiche della classe operaia era qualcosa di cool. E c’erano sufficiente innocenza da parte dei clienti e buone intenzioni da parte dei designer perché il gioco, comunque, reggesse.
Con l’inizio del nuovo millennio il tema del lavoro nella sua rappresentazione diretta attraverso i vestiti ha iniziato a rarefarsi sempre di più. Non è mai sparito dai racconti della moda, ma ha preso strade diverse e più difendibili. Ci sono sempre stati capi da lavoro nelle collezioni di Raf Simons, ma sempre edulcorati nel racconto di sottoculture giovanili di estrazione (anche) proletaria (l’indie, i rave) e mai come riferimenti diretti. Almeno fino a quando, a metà degli anni Dieci, i fratelli Gvasalia da Vetements prima e il solo Demna da Balenciaga poi non si sono rimessi a lavorare attivamente sulle uniformi della forza lavoro che i radar del resto del sistema moda non intercettavano pur incontrandoli quotidianamente. Quelle dei commessi di McDonald’s, delle guardie giurate, dei corrieri DHL o degli agenti che controllano il passaporto alle frontiere degli aeroporti (che sono figli di poveri, come diceva quello). Uniformi prese e messe in passerella, quasi tout court. In un momento in cui gli altri brand, in piena temperie woke, si ergevano a motori dell’avanzamento sociale sui temi più disparati, purché, sembravano far notare i fratelli Gvasalia, quei temi fossero cari a gruppi che avessero un certo potere di spesa. L’età dell’innocenza era già perduta da un pezzo e la trasformazione di quelle uniformi in vestigia, in simulacro, in cui stavolta anche il ruolo del prezzo serviva a rimarcare la presenza paradossale di quei capi in passerella, era più che mai consapevole. E allargava la questione alle intersezioni tra quei lavori, le etnie di chi quei lavori li faceva, e lo stato delle periferie in cui quei lavoratori vivevano. L’ottimismo di Margiela o la fascinazione poetica di Miuccia Prada non erano più contemplabili.
Poi è venuta la pandemia, con tutte le domande su cosa il nostro lavoro sarebbe diventato. Il lavorare dal divano in tuta, le call in camicia sopra e mutande sotto e tutto il resto (lo “Zoom look” dell’ultima collezione maschile da solista di Miuccia Prada, nel luglio 2020). È forse ancora presto per dire che cosa resterà e che cosa sia stato invece emergenziale oppure più semplicemente un modo per pensare ad altro. Quanti oggi credono ancora davvero di poter andare a scrivere codice o a fare l’account da Lanzarote per sei mesi all’anno? E quanto quegli anni hanno influito sulla tripartizione aurea tra lavoro, svago e riposo? A conti fatti, soprattutto chi di noi ha diversificato orari, modalità e luoghi, lavora di più o lavora di meno? Quanto tempo ha davvero per sé? E quello della tripartizione, pur cambiando gli addendi, mescolando le carte, resta un gioco a somma zero? O, peggio, nella nebbia delle modalità ibride, le cose hanno finito per peggiorare? Stiamo sempre lavorando? Stiamo davvero lavorando o le sacche di cazzeggio che gli schermi permettono hanno reso le nostre giornate un pastone indistinto in cui non si capisce più cosa è lavoro e cosa è svago, cosa è del padrone e cosa è nostro? Tra le nebbie di questo territorio ambiguo, in cui nessuno ci chiede più di indossare uniformi che dicano di noi che ruolo abbiamo e rotto il patto per cui al luogo del lavoro corrisponde l’abbigliamento del lavoro, viene da chiedersi: è forse il casualwear funzionale al capitale? Senza tirare in ballo dietrologie o persuasioni occulte, ma la rilassatezza dei costumi che ci viene sempre più concessa, non è un’arma a doppio taglio, una calcolata valvola di sfogo utile a non far alzare troppo la pressione di classe? In un mondo in cui il Ceo e lo stagista sono a una prima occhiata completamente indistinguibili, vien da chiedersi, cui prodest? Perché il distacco vestimentario che caratterizzava entrambi i fronti fino a non troppo tempo fa era certamente una barriera ma produceva, per tutte le parti in causa, anche un senso di orgoglio e di appartenenza estetico che si trasformava poi in azione e militanza e slancio. Oggi che stiamo tutti in jeans e maglietta e ci diamo del tu, la disintermediazione e l’omogenizzazione sembrano molto più a portata di mano, ma basta guardare gli stipendi per avere chiara quanto estetica e fantasmatica sia questa uguaglianza funzionale ai comunicati delle risorse umane.
Eppure il workwear è ancora qui, e anzi forse oggi più che mai, per quei gruppi del terziario creativo e dell’industria culturale a Partita Iva il cui lavoro è diventano così versatile da sembrare una pellicola che ricopre la vita tutta, ed è proprio il workwear lo stile più rappresentativo e rilevante. Non più nella versione rimaneggiata dalla moda autoriale (i cui prezzi aumentano e aumentano e aumentano e non sono più praticabili nelle classi creative affette da precarietà cronica), quanto piuttosto nei grandi marchi storici, nelle giacchette vintage bleu de travail, nei pantaloni Dickies, nel denim vintage che colleziona Carmy Berzatto. Ora che il lavoro è diventato un’entità quasi astratta ma più che mai presente, ci stiamo aggrappando ai vestiti come archetipi. E forse l’espressione pop che più rappresenta la nostra classe sociale, la «fascia alta dei morti di fame» come Michele Masneri definì i freelance e quindi il sé stesso del tempo in un pezzo accuratamente spassoso sulla vita dei giornalisti senza posto fisso del 2014, oggi, non è un dipinto o un romanzo, ma ovviamente un meme, chissà se nato come tale o se ha fatto il giro inverso, in cui si vede un Dj di spalle con indosso una T-shirt su cui campeggia la scritta: “I wear Carhartt because I’m working on myself.”

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.